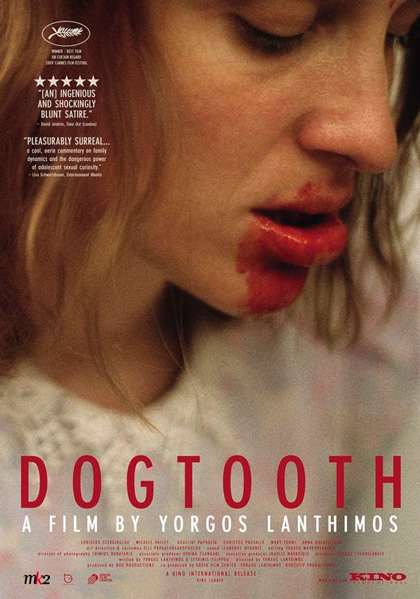Kinds of Kindness
di Yorgos Lanthimos
Gran Bretagna, 2024
Con: Jesse Plemons (Robert, Daniel e Andrew), Emma Stone (Rita, Liz ed Emily), William Defoe (Raymond, George e Omi), Margaret Qualley (Vivian, Martha e le gemelle Ruth e Rebecca), Hong Chau (Sarah, Sharon e Aka), Yorgos Stefanakos (R.M.F.)
Sceneggiatura di Efthymis Filippou
Trailer del film
Simboli su simboli si sovrappongono e stratificano dentro un film che può apparire (ed è) una commedia nera in tre episodi, un divertimento camaleontico per attori che interpretano personaggi assai diversi, una narrazione pulp nella quale scorre una discreta quantità di sangue sino a pratiche cannibaliche in cucina.
Ma dietro e dentro l’ironico titolo di un film dove la gentilezza proprio manca si intravvedono miti e credenze antiche, si direbbe quasi consustanziali a due greci come il regista e lo sceneggiatore Efthymis Filippou.
Il primo episodio si intitola La morte di R.M.F. e descrive un dirigente/demiurgo capriccioso e determinato che impone a un suo collaboratore/servo le azioni più bizzarre ed estreme, sino a ordinare in dettaglio le azioni quotidiane (sue e della moglie) e a chiedergli di assassinare un uomo. In seguito al rifiuto Robert viene licenziato ma non accetta questo esito e fa di tutto per ingraziarsi il capo/dio e tornare al suo servizio, compreso il cercare di compiere l’assassinio che gli era stato ordinato.
Nel secondo episodio, R.M.F. vola, un poliziotto è gravemente depresso perché la moglie è dispersa in un atollo a seguito di un naufragio. Quando Liz viene ritrovata sana e salva Daniel però non è affatto contento e convinto, perché sospetta che in realtà si tratti di una sosia, di una usurpatrice. Neppure i gesti più estremi di fedeltà e d’amore di Liz lo convincono e la donna arriva alla morte, tranne poi riapparire e finalmente essere accolta dal marito. La scena finale è una chiara illustrazione del mito della morte e resurrezione.
Il terzo episodio, R.M.F. mangia un sandwich, è il più chiaro nell’indicare la matrice teologica del film. Racconta infatti di una setta guidata da una coppia, maschio e femmina (Omi e Aka), le cui lacrime mescolate con l’acqua costituiscono l’unica bevanda ammessa e i cui membri non possono avere rapporti sessuali se non con Omi e Aka e con chi da loro è autorizzato. I disobbedienti vengono purificati tramite una sauna quasi mortale. L’obiettivo del gruppo è trovare una donna capace di resuscitare i morti. Andrew ed Emily, membri della setta, si mettono alla ricerca di questo Messia. Andrew è gelido ed efficiente, Emily è appassionata e tenace. Sarà lei a trovare l’eletta ma anche a segnarne il destino.
Molti altri sono gli elementi simbolici di questo film, tra i quali un sogno di capovolgimento del rapporto tra l’animalità umana e gli altri animali (in particolare i cani). In ogni caso, si tratta di una favola teologica sul destino dei viventi (per una lettura marcatamente gnostica rinvio a questo interessante commento di Francesco Patrizi: Un film sul rapporto uomo/dio). Il personaggio che si chiama R.M.F. muore, vola, risorge ed è lo sfondo, l’occasione, l’oggetto di tutti e tre i racconti, senza in pratica mai dire una parola. Le iniziali del suo nome rimangono enigmatiche ma il contenuto al quale rimandano è abbastanza chiaro ed è inscritto in una antropologia e cosmologie gnostiche per le quali questo mondo è intessuto di insensatezza, passioni e ferocia, è del tutto privo di gentilezza, è abitato da divinità usurpatrici e capricciose, può essere redento non dalle azioni che sono sempre destinate allo scacco, al fallimento e al male, ma dall’affrancamento da ogni eccesso emotivo; una liberazione conseguita tramite la conoscenza che quello che abitiamo è appunto un mondo perduto. E a partire da tale consapevolezza praticare la distanza (non certo l’amore) che di ogni gentilezza è la condizione.




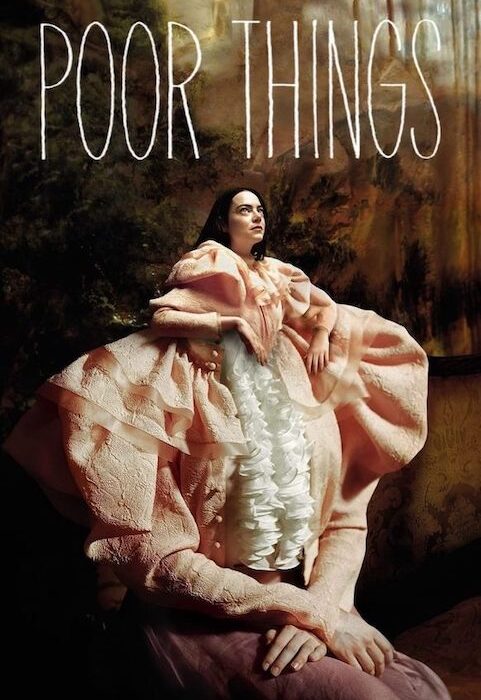



 In questo film il mito esplicitamente citato -sin dal titolo- è quello del sacrificio di Ifigenia da parte del padre Agamennone per volontà degli dèi. E dunque Martin è forse il dio crudele, vale a dire il dio.
In questo film il mito esplicitamente citato -sin dal titolo- è quello del sacrificio di Ifigenia da parte del padre Agamennone per volontà degli dèi. E dunque Martin è forse il dio crudele, vale a dire il dio.