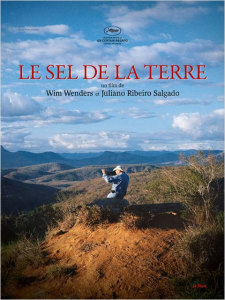Anselm
di Wim Wenders
Germania, 2023
Con: Anselm Kiefer
Trailer del film
Da molti anni lo Hangar Bicocca di Milano ospita in modo permanente I sette palazzi celesti di Anselm Kiefer. «Una verticalità immobile e cangiante» l’ho definita. E tutta la poetica di Kiefer è anche questa verticalità. Il film di Wim Wenders lo dimostra intessendo l’apparire delle opere – poiché di una epifania si tratta – con la vicenda biografica che ha condotto questo artista visionario dalla collaborazione con Joseph Beuys a un ampliamento sempre più imponente delle immagini, delle costruzioni, degli spazi. Sino a occupare intere ex fabbriche o ettari di terreno per trasformarli in luoghi poietici, dentro i quali sorgono le spose/Lilith; sorgono gli enormi pannelli fatti di ferro, cemento, ondate di colore; sorgono le torri disseminate nello spazio; sorgono le fotografie raccolte in volumi di piombo.
Kiefer appare dunque come un alchimista e un fabbro, la cui fiamma ossidrica vorrebbe illuminare anche la storia recente della Germania, accompagnato dalla lettura costante ed empatica delle poesie di Paul Celan.
Introducendo Celan, leggendo le sue poesie, Kiefer e Wenders parlano anche di Martin Heidegger. Lo fanno con immagini e video che raffigurano il filosofo mentre cammina, con il suo sguardo sempre ironico e magnetico. Kiefer e Wenders ricordano l’incontro tra Celan e Heidegger a Todtnauberg, nella baita. Celan scrisse in quell’occasione nel libro degli ospiti una frase che accenna all’attesa di una parola. Wenders/Kiefer rilevano che quella parola non è stata pronunciata.
Evidentemente l’ossessione nei confronti di Heidegger è pervasiva e sotterranea anche in un artista così disincantato come Kiefer. Quale parola si attendeva da Heidegger? Una parola di pentimento? Pentimento collettivo o individuale? Una parola di sottomissione ai vincitori? In realtà il punto non è questo, mai. Che ne siano o no consapevoli, i detrattori biografici di Heidegger – da distinguere dai critici teoretici più rigorosi – esercitano la loro moralità non sui «silenzi» e neppure sul «rettorato» ma su altro: sul fatto che per un filosofo di questa grandezza l’etica sia succedanea, secondaria, non necessaria. E invece io credo che anche qui, forse soprattutto qui, sta la grandezza di Heidegger: nell’aver tolto autonomia all’etica e nell’averne fatto la conseguenza dell’ontologia. Ci si comporta per come si è e non si cambia se non nei particolari; «operari sequitur esse», come ricorda anche Schopenhauer riprendendo Pomponazzi.
Secondariatà dell’etica rispetto all’ontologia che con altro linguaggio anche Carlo Emilio Gadda esprime con chiarezza: «Dopo rotto il déclic della molla organica interna, non c’è diti di Vescovo né virtù ed unzione di Sacramento che valga a rimontarne il tic-tac. Il gioco multiplo e avaro degli infinitesimi, delle minime elezioni accumulatrici, della dura disciplina selettrice, s’è scombinato in un blando desiderio di requie, s’è rilassato in un abbandono (alla lubido), o ne’ pisoli della vanità soddisfatta, s’è sdraiato in una eutanasia: l’essere è, da dentro, un morente: per cui la tromba la può suonare a perdifiato, ma suona invano» (L’Adalgisa, Garzanti, 2007, p. 280).
Heidegger ha rifiutato il primato etico della modernità e questo sembra ossessionare e nello stesso tempo affascinare molti interpreti. Ossessiona e affascina anche due artisti come Wenders e Kiefer capaci di cogliere, plasmare ed esprimere il male del mondo. Ancora un passo e capiranno che non c’è niente da chiedere a Heidegger ma c’è soltanto da capire, da conoscere, da sapere.