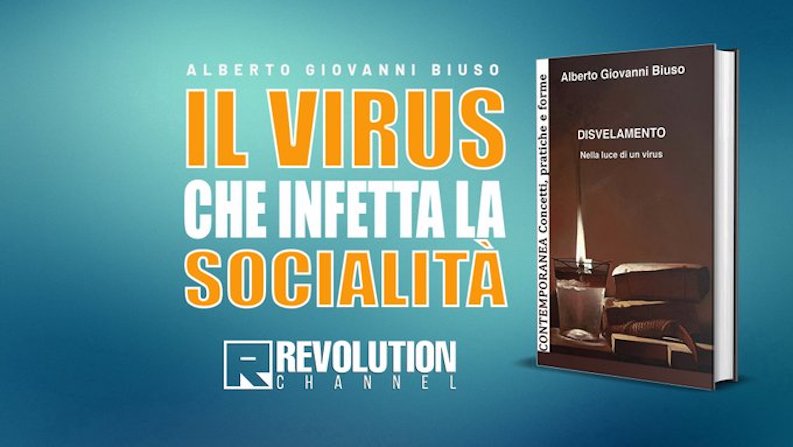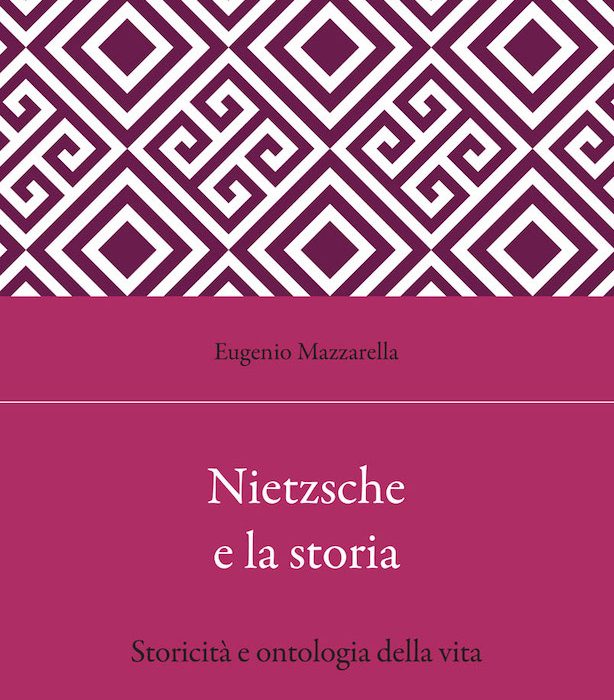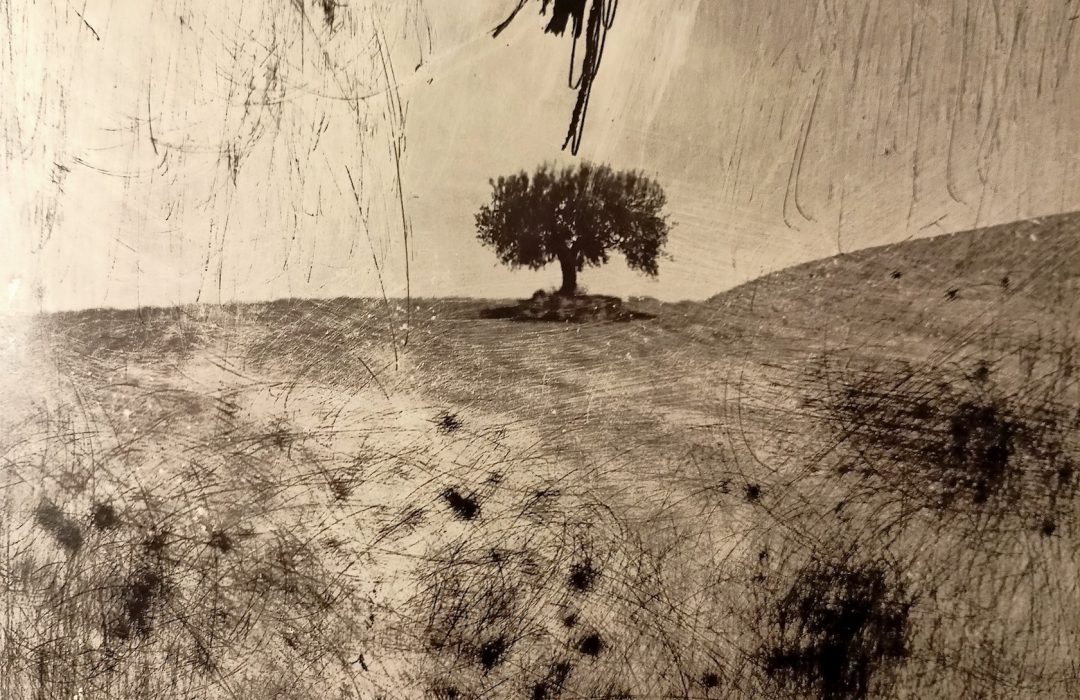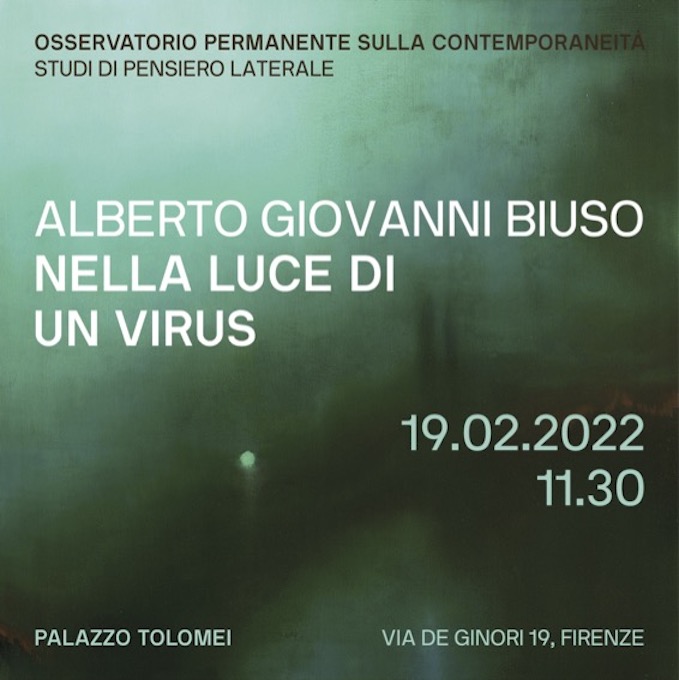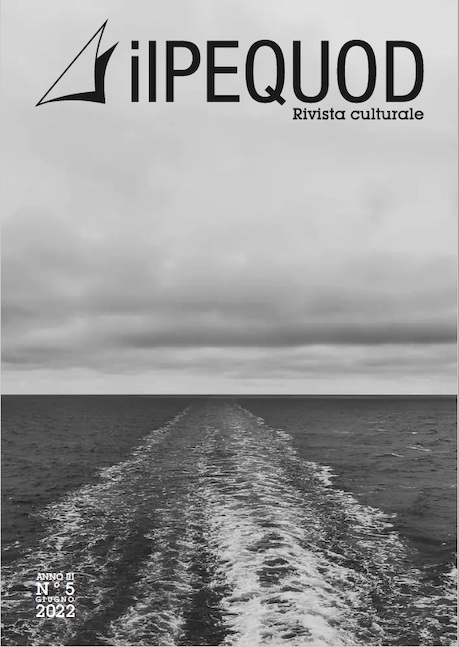
Nemesi e dismisura
in il Pequod , anno 3, numero 5, giugno 2022, pagine 7-14
Indice del saggio
-Tracotanza
-Nemesi
-Un conclusione politeistica
È accaduto che si sia invertito l’ordine naturale e logico del rapporto tra salute e malattia, è accaduto che si sia diventati tutti pazienti senza essere malati, è accaduto che «il cittadino, finché non si prova che è sano, si presume che sia malato. […] Risultato: una società morbosa che chiede una medicalizzazione universale, e un’istituzione medica che attesta una universale morbosità» (Ivan Illich); è accaduta un’aggressione del corpo collettivo verso se stesso, la metastasi di una parte tesa a consumare il tutto; è dilagata una malattia sociale, politica e civile.
E questo nonostante il fatto che «studiando l’evoluzione della struttura della morbosità si ha la prova che durante l’ultimo secolo i medici hanno influito sulle epidemie in misura non maggiore di quanto influivano i preti nelle epoche precedenti. Le epidemie venivano e se ne andavano, esorcizzate da entrambi ma non impressionate né dagli uni né dagli altri. Esse non vengono modificate dai riti celebrati nelle cliniche mediche più di quanto lo fossero dai tradizionali scongiuri ai piedi degli altari» (Illich).
Ciò che sta accadendo da due anni a oggi è dunque un esempio del concetto chiave dell’analisi di Illich: iatrogenesi.
Per millenni e sino alla fine dell’Ottocento il medico, o chi per lui, è stato addestrato e abituato a riconoscere la facies hippocratica, i segni della morte imminente e inevitabile, in base ai quali deve subentrare il rispetto per la persona che nel ciclo naturale e infinito lascerà il posto ad altre forme e ad altre vite. Lasciare andare il morente, accompagnarlo con l’abbraccio dei suoi cari, è stato un preciso dovere, sostituito ora dall’accanimento insensato che fa morire gli umani in una solitudine meccanica e ambientale che è il più atroce esito della nemesi medica.
Nel 1976 Illich enunciava un’affermazione icastica e feroce, che il tempo ha confermato, vale a dire «la servile subordinazione della classe medica italiana nei confronti dell’industria farmaceutica». Una subordinazione che è data certamente dalla secolare condizione di colonizzazione degli italiani, compresi i loro intellettuali e tecnici, e da un tessuto politico particolarmente corrotto ma che è anche e soprattutto espressione di un radicato e più generale rifiuto del πέρας, del limite, della consapevolezza della finitudine, che è – semplicemente – l’intelligenza del mondo.
=======
Tali sono alcune delle tesi che ho cercato di argomentare in questo saggio che esce in un numero assai ricco del Pequod, sul quale hanno scritto molti amici e allievi, a cominciare dal suo ideatore Enrico Palma. L’indice completo lo si trova anche nel pdf ma ricordo qui che tra i contributi ci sono quelli di Davide Amato, Nicoletta Celeste, Sarah Dierna, Stefano Piazzese, Mattia Spanò, del collega Antonio Sichera. Insieme ad alcuni di questi studiosi e ad altri, abbiamo anche scritto una riflessione collettiva dedicata alla messa in scena del’Edipo Re quest’anno a Siracusa: Edipo Re. Una nota filosofica, esperimento riuscito di pensiero collettivo, segno certo di salute.