
Teatro ABC – Catania
La roba
da Giovanni Verga
con Enrico Guarneri (Mazzarò), Rosario Marco Amato, Nadia De Luca, Alessandra Falci, Alice Ferlito, Francesca Ferro, Gianni Fontanarossa, Maria Chiara Pappalardo, Giuseppe Parisi, Giampaolo Romania
regia Guglielmo Ferro
Sino al 13 novembre 2022
La roba e il resto avrebbe dovuto intitolarsi questo spettacolo. Guarneri e Ferro mescolano infatti la scarna e perfetta novella che ha questo titolo con altri testi delle Novelle rusticane e di Vita dei campi; con altri personaggi quali Nedda, Janu, Jeli, Mara; con altre miserie, altri amori, altri tradimenti; con la disgrazia dell’esser nati poveri o d’avere molto danaro e farselo rubare o saper mantenere e moltiplicare la roba e poi dover morire; con la pazienza, la solitudine e la violenza a stento mascherata «d’indifferenza orientale che è la dignità del contadino siciliano» (Jeli il pastore, in Giovanni Verga, Tutte le novelle, Einaudi 2015, p. 130).
E poi le piogge che rovinano il raccolto e il sole tremendo che moltiplica l’arsura. E la diffidenza verso i potenti. E su tutto la morte. La morte che fa impazzire Mazzarò al pensiero che dovrà lasciare ad altri – a degli sconosciuti – quella roba che è diventata la sua sostanza stessa, per la quale ha commesso la stoltezza di continuare a mangiare pane e cipolle quando i suoi granai straboccavano, per la quale ha vissuto, respirato, faticato, odiato. Senza ottenere una pace diversa dalla consolazione di vedere «gli scimuniti» perdere la loro roba e lui acquistarla.
La messa in scena assai tradizionale ma piacevole di Guarneri-Ferro inizia con Mazzarò che recita l’incipit della novella, il suo canto del possesso nello spazio sconfinato della terra:
«Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristemente nell’immensa campagna e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: — Qui di chi è? — sentiva rispondersi: — Di Mazzarò —. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: — E qui? — Di Mazzarò —. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all’improvviso l’abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: — Di Mazzarò —. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l’erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell’acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. – Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell’assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra».
(Tutte le novelle, pp. 256-257)
La roba è parola tra i siciliani sacra, anche quando essa non riguarda direttamente dei beni economici ma il possesso di cariche politiche, amministrative, accademiche. La roba è il concetto materico per eccellenza. La roba è una droga capace di porre fine alla miseria e di dare senso al regime quotidiano della lotta. Greci e hobbesiani; solitari «sul cuor della terra» e splendenti d’ironia come il sorriso dell’ignoto di Antonello, i siciliani vivono la pienezza dell’assurdo mentre vengono inghiottiti dalle tenebre della storia e del tempo.



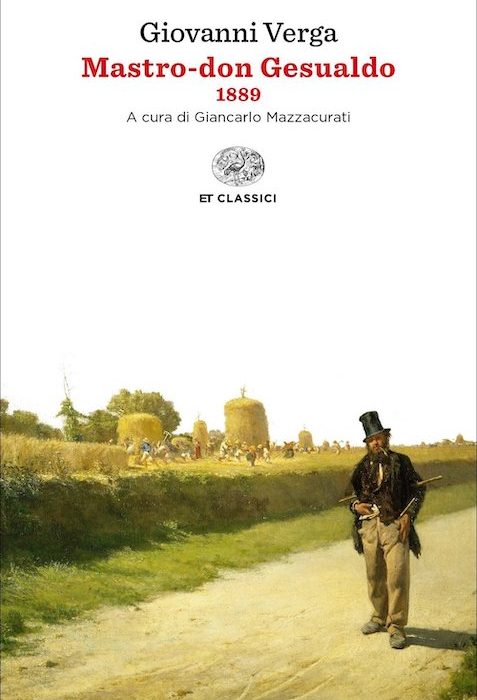


 Morte che i siciliani celebrano in varie forme. Come quella nella quale un San Lorenzo dal colore ormai spento rimane in ogni caso l’unica luce che riverbera nel buio insieme al rosso delle braci. L’autore del dipinto è Filippo Paladini, un toscano che venne a lavorare e morire nell’Isola. Il quadro si trova in una chiesa fortezza, l’imponente Chiesa Madre di
Morte che i siciliani celebrano in varie forme. Come quella nella quale un San Lorenzo dal colore ormai spento rimane in ogni caso l’unica luce che riverbera nel buio insieme al rosso delle braci. L’autore del dipinto è Filippo Paladini, un toscano che venne a lavorare e morire nell’Isola. Il quadro si trova in una chiesa fortezza, l’imponente Chiesa Madre di  È iniziato da questo edificio il percorso che l’accoglienza appassionata e disincantata di Enrico Palma e Pietro La Rocca ha reso un viaggio nel profondo della nostra storia. Abbiamo attraversato strade intitolate ad ‘Aristotile’ e ad Atene; abbiamo sostato davanti alle
È iniziato da questo edificio il percorso che l’accoglienza appassionata e disincantata di Enrico Palma e Pietro La Rocca ha reso un viaggio nel profondo della nostra storia. Abbiamo attraversato strade intitolate ad ‘Aristotile’ e ad Atene; abbiamo sostato davanti alle facciate di chiese barocche pronte a volare e di piccoli edifici religiosi immobili come scogli del mare; abbiamo sentito le parole e visto i gesti ambigui di Lola, Santuzza e compare Turiddu, che i racconti di Verga hanno reso perenni.
facciate di chiese barocche pronte a volare e di piccoli edifici religiosi immobili come scogli del mare; abbiamo sentito le parole e visto i gesti ambigui di Lola, Santuzza e compare Turiddu, che i racconti di Verga hanno reso perenni.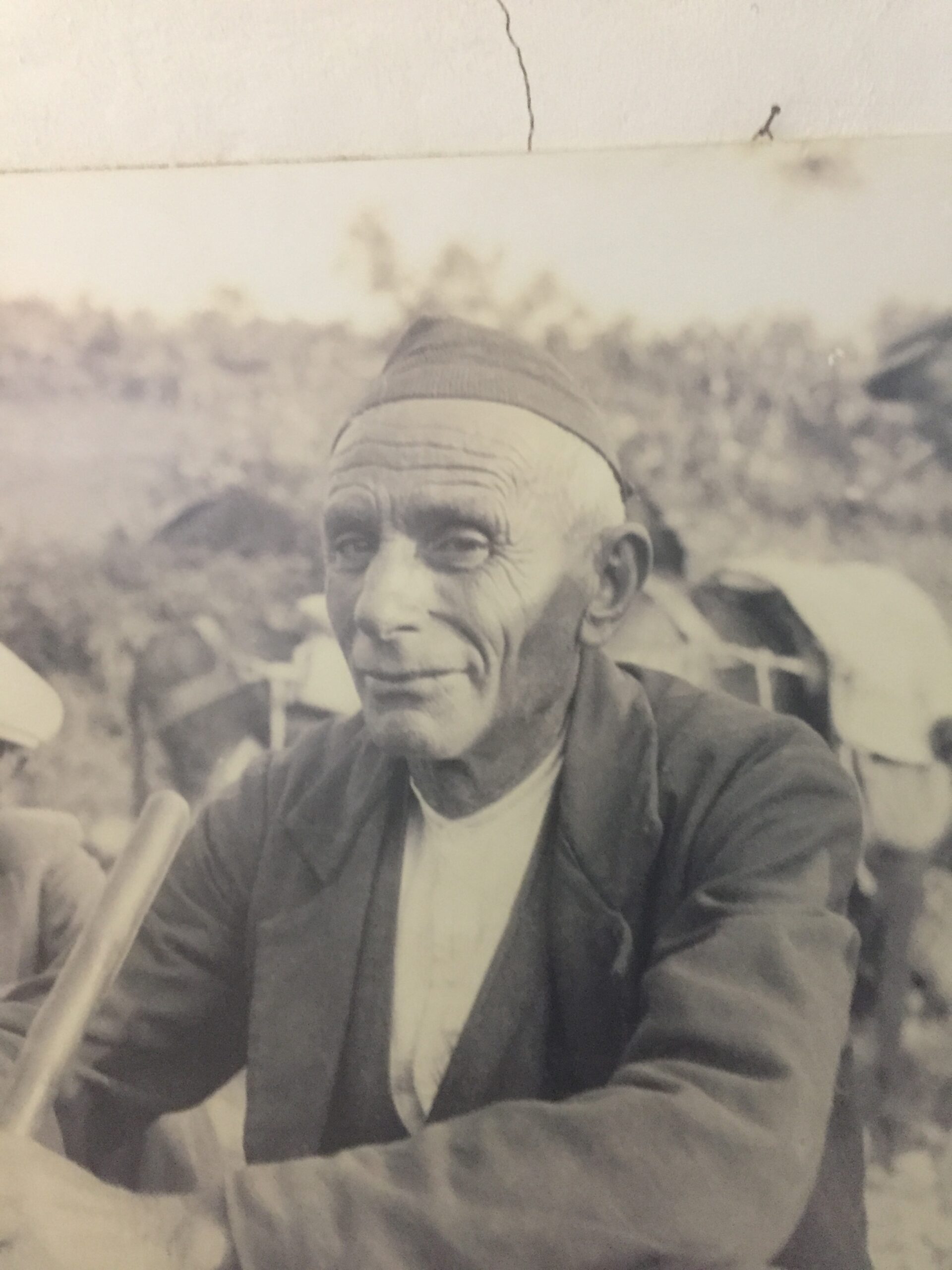 Il suo nome e la sua opera abitano ovunque, qui. In particolare nel Palazzo nobiliare dei Ventimiglia, diventati i Trao con i quali Mastro-Don Gesualdo Motta volle imparentarsi. Loro erano i discendenti della nobiltà più arrogante, lui era un uomo venuto dal nulla e diventato ricco con il lavoro incessante dei giorni. In questo Palazzo l’ambizione di un’impossibile mescolanza sociale sembra scandire stanza dopo stanza il delirio dei Trao decaduti, l’amarezza costante di Gesualdo.
Il suo nome e la sua opera abitano ovunque, qui. In particolare nel Palazzo nobiliare dei Ventimiglia, diventati i Trao con i quali Mastro-Don Gesualdo Motta volle imparentarsi. Loro erano i discendenti della nobiltà più arrogante, lui era un uomo venuto dal nulla e diventato ricco con il lavoro incessante dei giorni. In questo Palazzo l’ambizione di un’impossibile mescolanza sociale sembra scandire stanza dopo stanza il delirio dei Trao decaduti, l’amarezza costante di Gesualdo.

 mattina di gennaio del 1895, quando il capitano Alfred Dreyfus (qui a sinistra) viene pubblicamente degradato nel cortile dell’École Militaire di Parigi e subito dopo inviato come prigioniero all’isola del diavolo, uno scoglio nell’Atlantico. Dreyfus è stato infatti riconosciuto colpevole di spionaggio a favore della Germania. Tra gli inquirenti, il maggiore Georges Picquart (foto in basso), il quale condivideva l’ostilità verso gli ebrei che pervadeva la Francia della Terza Repubblica. Quando viene chiamato a dirigere i Servizi Segreti, Picquart comprende tuttavia che l’ebreo Dreyfus è innocente e che la spia è Jean Marie Auguste Walsin-Esterhazy, un soggetto assai corrotto, diventato ufficiale in maniera truffaldina. Ma i capi di Picquart rifiutano qualunque ipotesi di riapertura del processo e allontanano Picquart. Anche per questo Émile Zola il 13 gennaio 1898 pubblica il suo J’accuse contro lo Stato Maggiore dell’esercito francese. I poteri politico, militare e giudiziario reagiscono in modo scomposto, condannando sia Zola sia Picquart. Dopo alcuni anni, Picquart e Dreyfus vengono riconosciuti innocenti ma Esterhazy e i generali francesi non saranno mai condannati.
mattina di gennaio del 1895, quando il capitano Alfred Dreyfus (qui a sinistra) viene pubblicamente degradato nel cortile dell’École Militaire di Parigi e subito dopo inviato come prigioniero all’isola del diavolo, uno scoglio nell’Atlantico. Dreyfus è stato infatti riconosciuto colpevole di spionaggio a favore della Germania. Tra gli inquirenti, il maggiore Georges Picquart (foto in basso), il quale condivideva l’ostilità verso gli ebrei che pervadeva la Francia della Terza Repubblica. Quando viene chiamato a dirigere i Servizi Segreti, Picquart comprende tuttavia che l’ebreo Dreyfus è innocente e che la spia è Jean Marie Auguste Walsin-Esterhazy, un soggetto assai corrotto, diventato ufficiale in maniera truffaldina. Ma i capi di Picquart rifiutano qualunque ipotesi di riapertura del processo e allontanano Picquart. Anche per questo Émile Zola il 13 gennaio 1898 pubblica il suo J’accuse contro lo Stato Maggiore dell’esercito francese. I poteri politico, militare e giudiziario reagiscono in modo scomposto, condannando sia Zola sia Picquart. Dopo alcuni anni, Picquart e Dreyfus vengono riconosciuti innocenti ma Esterhazy e i generali francesi non saranno mai condannati.