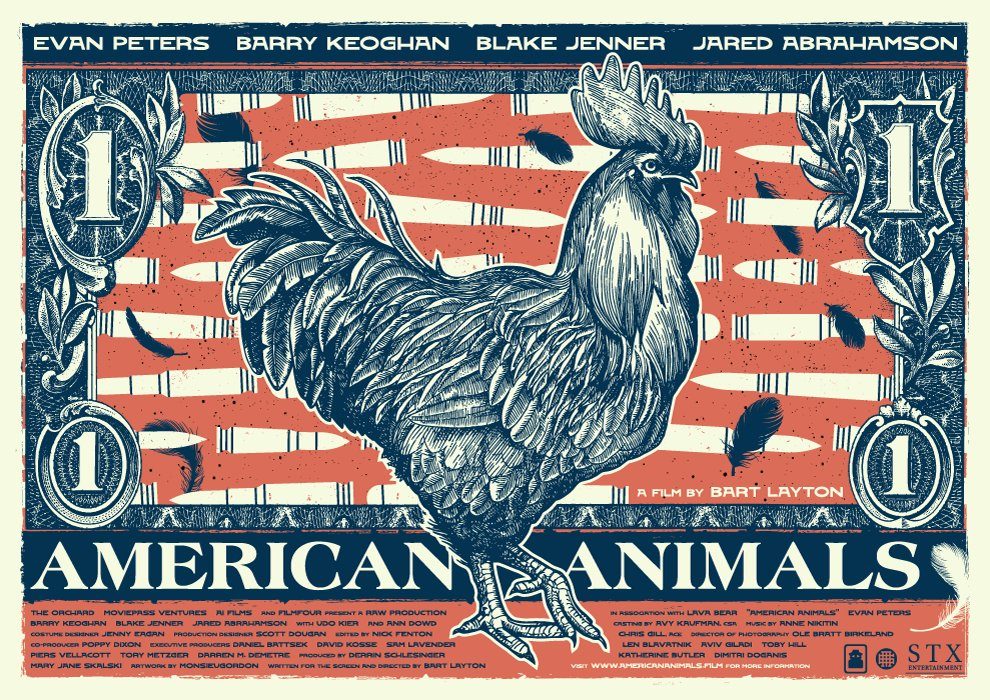The Godfather
(Il Padrino)
Parte I (1972) – Parte II (1974)
di Francis Ford Coppola
Con: Marlon Brando (Vito Corleone), Al Pacino (Michele Corleone), Robert De Niro (Vito Corleone da giovane), Robert Duvall (Tom Hagen), James Caan (Sonny Corleone), Diane Keaton (Kay Adams), John Cazale (Fredo Corleone), Talia Shire (Connie Corleone), Al Lettieri (Virgil, ‘il Turco’, Sollozzo), Corrado Gaipa (Tommasino), Lee Strasberg (Hyman Roth), Michael V. Gazzo (Frankie Pentangeli), Gastone Moschin (Fanucci), Maria Carta (la madre di Vito), Morgana King (mamma Corleone)
«Perciò tutto ciò che è conseguente al tempo di guerra in cui ogni uomo è nemico ad ogni uomo, è anche conseguente al tempo in cui gli uomini vivono senz’altra sicurezza di quella che la propria forza e la propria inventiva potrà fornire loro. […] E quel che è peggio di tutto, vi è continuo timore e pericolo di morte violenta, e la vita dell’uomo è solitaria, misera, sgradevole, brutale e breve» (Thomas Hobbes, Leviatano [1651], La Nuova Italia 1976, cap. XIII, p. 120).
Tale fu sin dall’inizio l’esistenza di Vito Andolini, diventato all’anagrafe statunitense Vito Corleone dopo essere sfuggito alla morte che il capomafia di Corleone, appunto, aveva inferto a padre, madre, fratello.
Onesto era Vito ma a Little Italy aveva dovuto imparare l’arroganza, l’umiliazione, la violenza. Ed era diventato Don Vito. Lo troviamo, ormai ricco, nel giorno del matrimonio della figlia; le cerimonie costellano infatti di sé l’intero film, lo scandiscono. Proprio quel giorno è venuto un uomo a chiedergli giustizia per la violenza subita da sua figlia e che i tribunali dello Stato gli hanno negato. Il film inizia con le parole di questo padre: «Io credo nell’America».
La stessa fede nutrita dal figlio minore e amatissimo di Don Vito, Michele, decorato al valore durante la Seconda Guerra mondiale e che al suo ritorno trova un’altra guerra costante, pervasiva, totale; trova il bellum omnium contra omnes e ne diventa il signore: malinconico, freddo, determinato, feroce. Sino alle scene conclusive delle due parti dell’opera: nella prima Michele riceve l’omaggio dei suoi uomini dopo essere diventato il capofamiglia; nella seconda ha ottenuto vendetta su tutti i suoi nemici, tra i quali anche un fratello, anche la moglie allontanata, anche un vecchio e potente ebreo che gli aveva portato la guerra in casa.
Lo sguardo di Michele è lontano, rassegnato, triste, interrogativo, silente. È lo sguardo del potente che domina su un regno di morti e lo sa: «Chi stermina tutti i nemici non ha più alcun nemico, e inoltre gode la vista dei loro mucchi ora inermi» (Elias Canetti, Massa e potere, Adelphi 1981, p. 543).
È lo sguardo di Cesare Borgia, unito a quello di Machiavelli: «È molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare dell’uno de’ dua»; «Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede [la parola data], quando tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E, se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma perché sono tristi [malvagi], e non la osservarebbano a te, tu etiam non l’hai ad osservare a loro» (Il Principe, capp. 17 e 18).
In quest’opera la morte arriva coniugata ai riti cattolici, lo sterminio si accompagna e si alterna alle professioni di fede, alla musica celeste, alla solennità della soteriologia cristiana. L’apice è raggiunto durante la cerimonia del battesimo, nella quale Michele fa da padrino al figlio di sua sorella, dichiarando che «rinuncia a Satana e alle sue opere» proprio mentre i suoi uomini uccidono uno a uno e in luoghi diversi i capi delle altre famiglie. Un montaggio magistrale, ironico e disperato. La cui efficacia si percepisce assai meglio vedendo i due film (come ho avuto di recente la possibilità di fare) nella versione originale con i sottotitoli, e potendo quindi apprezzare il continuo passaggio linguistico dall’inglese americano all’anglosiculo. Un originale linguisticamente e concettualmente più sobrio rispetto alla traduzione e al doppiaggio spesso ‘folcloristici’ della versione in italiano.
La seconda parte dell’opera è apertamente e fecondamente politica, con la Cuba del dittatore Fulgencio Batista finanziata sia dalle istituzioni sia dalla criminalità degli Stati Uniti d’America e con una commissione d’inchiesta contro la mafia nella quale i senatori americani sono in mano alle diverse famiglie mafiose, che li usano per reciproche accuse e vendette. Credo che solo il grande successo della prima parte abbia permesso a Coppola di poter essere così esplicito e libero nelle accuse rivolte al proprio Paese, che ne emerge per quello che è: una sentina di corruzione.
Su tutta l’opera domina, naturalmente, Shakespeare, del quale The Godfather è l’ennesima espressione. Riccardo III ma non solo. Il film è pervaso dall’antropologia di Hobbes, Machiavelli e Shakespeare.
Un’antropologia che in Sicilia conosciamo bene. La conosciamo bene a Catania, città dove forze non dissimili da quelle descritte nel Padrino vanno da tempo all’attacco dell’istituzione -l’Università- che pur con tutti i suoi limiti, anche territoriali e antropologici, può insegnare e praticare uno sguardo diverso rispetto a quello della legge del più forte; dove un’informazione comprata e venduta presenta il mondo e i suoi eventi in una chiave espressionistica e perennemente distorta; dove massonerie di tutti i generi stanno dentro le istituzioni che dovrebbero garantire i diritti, i doveri e l’eguaglianza dei cittadini; dove i più lontani dalla legge e dalle sue garanzie invocano continuamente la legge e le sue garanzie, ricevendo ascolto; dove un numero in fondo decisamente minoritario di soggetti riceve la stolta complicità, l’acquiescenza, l’ingenuità di coloro contro i quali operano: i giovani soprattutto.
In quest’ultimo caso la responsabilità è anche nostra: non abbiamo saputo fornire in modo adeguato ai nostri studenti gli strumenti per decifrare la realtà, comprenderne il male, guardarsi dai pericoli che si celano nella superficialità, nell’ignoranza, nei media tradizionali e digitali, nell’inganno ogni giorno perpetrato da molti, troppi, soggetti sociali. Non esiste, naturalmente, il Padrino. Esiste un oscuro tessuto di relazioni palesi e nascoste, istituzionali e private, locali e nazionali, individuali e di gruppo. Un tessuto rosso del sangue del futuro che i nostri giovani non avranno perché non hanno saputo e non abbiamo saputo liberarci dai Corleone che con altri nomi sono ancora i padrini di Catania.