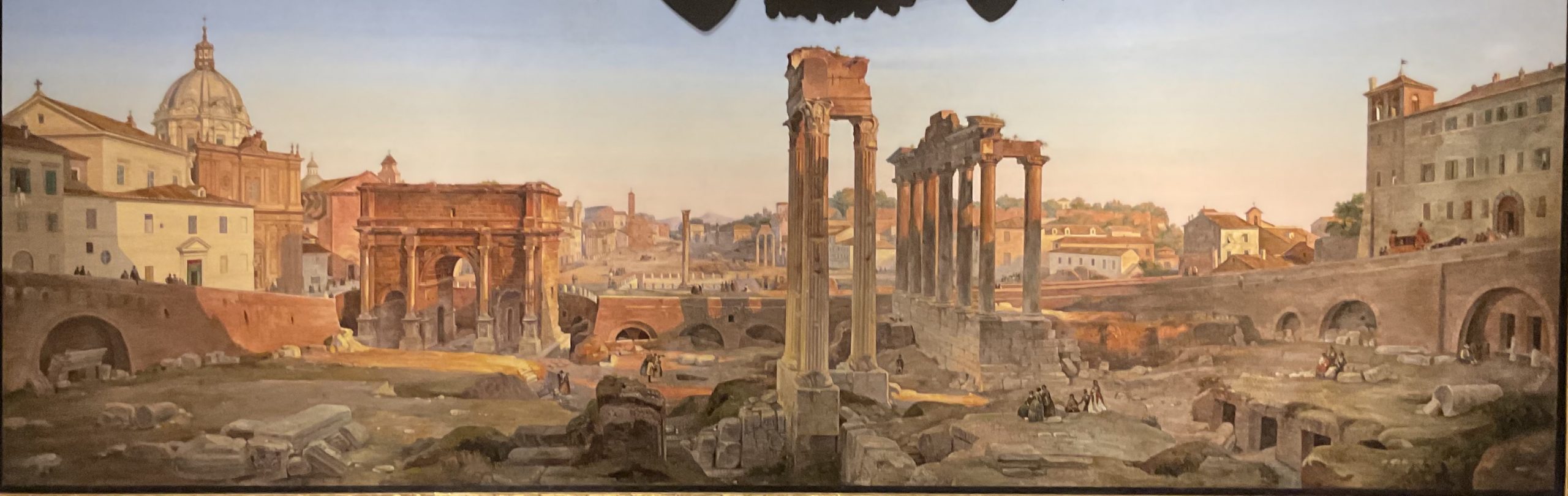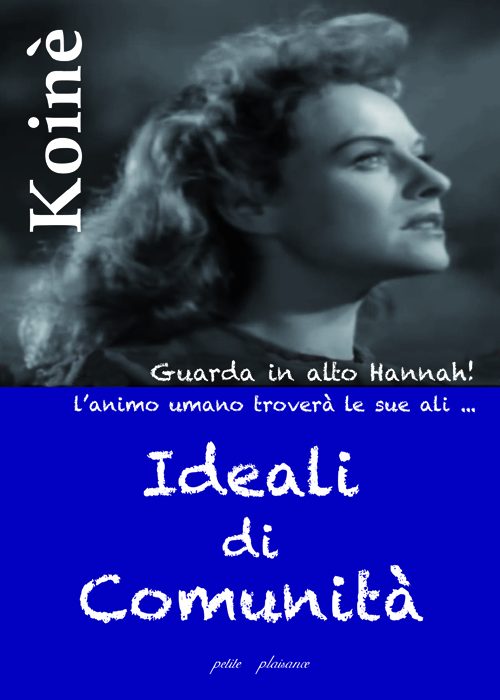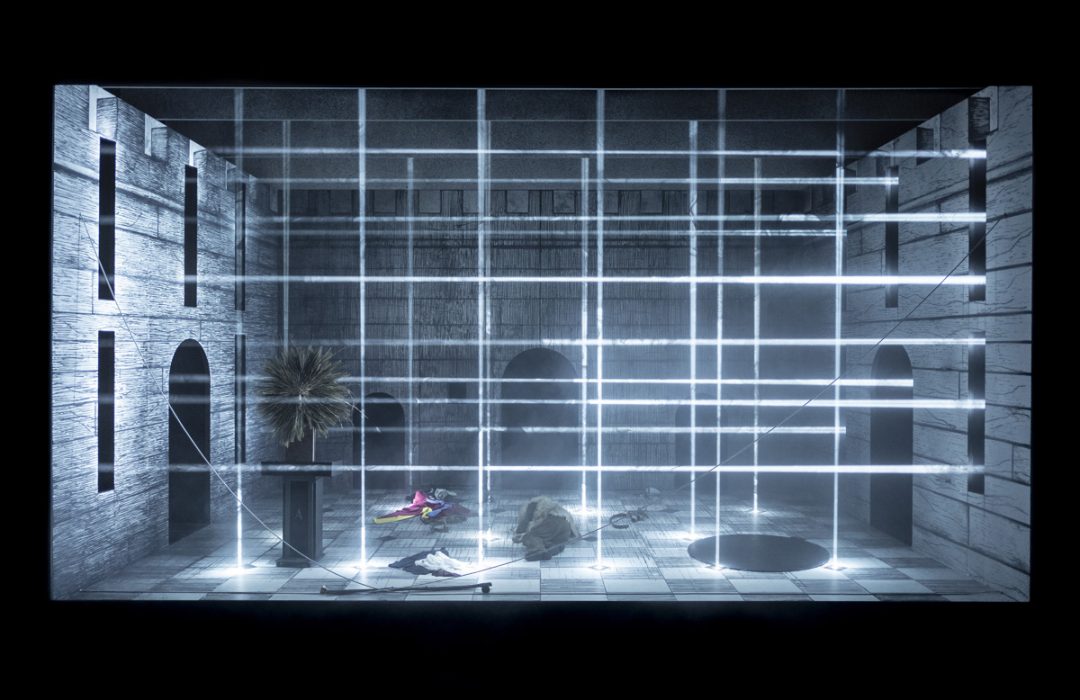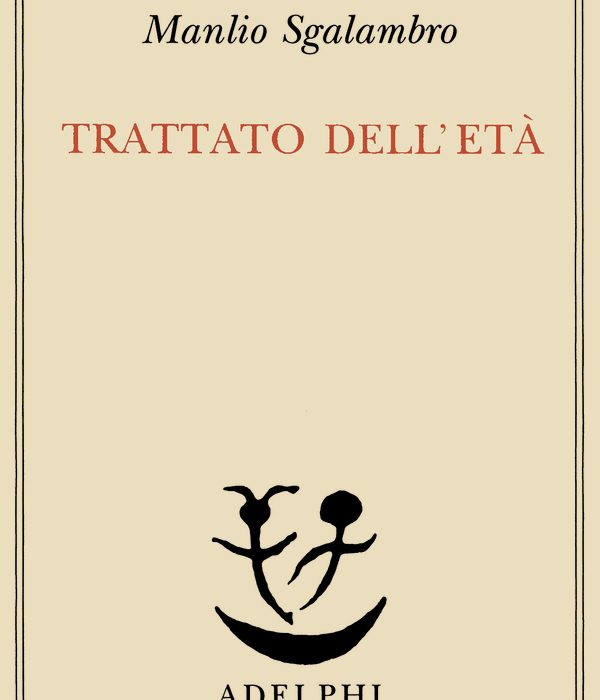Pietro Ingallina su Tempo e materia
Pietro Ingallina
Recensione a Tempo e materia. Una metafisica
in Acta Philosophica. Rivista internazionale di filosofia; Vol. 31 – anno 2022 – Fascicolo 1, marzo 2022; pp. 175-178.
L’editore di Acta Philosophica, rivista della Pontificia Università della Santa Croce che si pubblica dal 1992, non permette l’utilizzo di nessun pdf degli articoli e neppure delle recensioni. Riporto dunque qui alcuni brani dell’ampia analisi che Pietro Ingallina ha dedicato al libro:
«Tempo e materia. Una metafisica è un libro che si prefigge di superare ogni dualismo e ogni antropocentrismo, a favore non di un diniego della specificità dell’essere umano, bensì di un radicale ripensamento della sua posizione nell’essere. […]
Di fronte alla tradizionale opposizione tra il monismo parmenideo e il “tutto scorre” di matrice eraclitea, Biuso tenta una terza via. Se le teorie di ascendenza eleatica – filosofiche o scientifiche che siano – sono da rigettare, perché configurano una realtà ultima perennemente stabile e immutabile, che è lontana da ogni evidenza presentata dall’esperienza e, anzi, nega ogni consistenza ai fenomeni ; sono da valutare come altrettanto implausibili le ipotesi di una molteplicità originaria assolutamente caotica e incontrollata, perché priverebbero la realtà di ogni regolarità, rendendola un colpo di dadi la cui logica sarebbe imperscrutabile. Piuttosto, Biuso cerca di coniugare le due tradizioni, concependo identità e differenza quali principi ontologici equipollenti e imprescindibili l’uno dall’altro. Più in generale, l’essere è alternarsi di identità e differenza, è insieme uno e molteplice, al contempo immutabilità e mutamento. […]
Il divenire è il tratto temporale fondamentale dell’essere. A partire da questa tesi va compresa pure l’eternità, la quale non è l’atemporalità di una sostanza assoluta e separata dagli enti, dagli eventi e dai processi che sono presenti, accadono e fluiscono. […]
Gli enti esistono e si mostrano quali eventi, ma enti ed eventi non possono essere gli elementi primari dell’ontologia, in quanto hanno senso e consistenza se compresi all’interno dei processi. Senza i processi il mondo fenomenico sarebbe un puro niente, perché solo i processi insieme permangono mutando e mutano permanendo, mentre gli eventi accadono soltanto e gli enti a un tempo sono o divengono.
Nonostante la lettura di Biuso della Sostanza e dell’eternità [in Spinoza] sia coerente con la sua proposta di una metafisica temporale e materialistica, e sia pure supportata dall’interpretazione di Deleuze e dall’ontologia dei processi, tuttavia, essa risulta problematica perché non tiene conto di studi più aggiornati (ad esempio quelli di Yithzak Melamed), che offrono un’interpretazione atemporale dell’eternità e ne difendono la coerenza con l’esistenza del tempo e della durata all’interno del sistema di Spinoza».