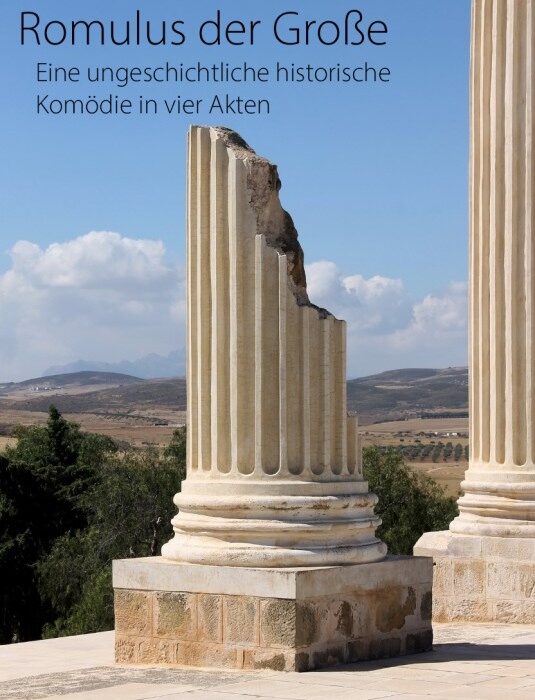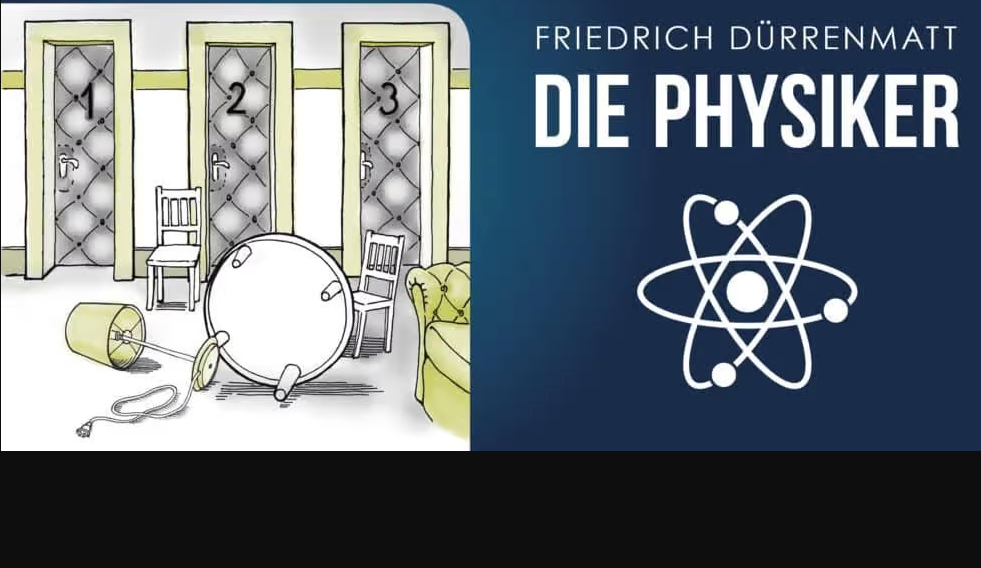Storia e specchi
Aldous, 11 dicembre 2024
Pagine 1-2
In questo articolo ho cercato di mostrare quanto feconda sia la critica di Friedrich Dürrenmatt ai poteri politici e al dogmatismo culturale, come essa si esprime anche nell’ultimo testo drammaturgico da lui creato: Achterloo (1983). Un’affermazione quale «oggi siamo in grado di costruire una gabbia da cui è impossibile evadere» è molto più vera per il presente virtuale/digitale del XXI secolo che per gli anni Ottanta del Novecento, così come l’intuizione dei processi futuri – e oggi presenti – di ibridazione tra il corpomente umano e i computer: «Il computer, liberato dall’uomo suo creatore, è il senso ultimo dell’uomo; in esso l’uomo trova il suo perfetto compimento. […] Il rosso sanguigno del tramonto verso il quale, divenuta ormai superflua, l’umanità si avvia barcollando, per dissolversi in esso, è nello stesso tempo il rosso di un’alba da cui, come da un bagno di fuoco, sorgerà la nuova umanità, l’umanità dei cervelli artificiali».
Ho posto queste tesi del drammaturgo svizzero a confronto con le analisi di uno dei più attenti sociologi contemporanei, secondo il quale l’ontologia della Rete consiste nel fatto che «le macchine IA non ‘pensano’, operano» (Renato Curcio, Sovraimplicazioni. Le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, 2024) e questo significa «che ciò che il dispositivo comunque e in ogni caso non può fare è proporre una risposta ‘intelligente’. E cioè una risposta creativa, non prevista o non desiderata nei magazzini in cui sono stoccati i suoi dati di riferimento o nei cloud di computo, assemblaggio e d’indirizzo. Una risposta che nasca da associazioni non consuete, improbabili, proiettate a suggerire un mutamento del sistema» e non a ribadire l’ineluttabilità dell’esistente attraverso il crisma algoritmico.
Strumento molto utile per ottenere tale passività del pensare (e dunque dell’agire) è la linguistica computazionale, la quale cerca di rimodellare e tradurre i linguaggi ordinari delle persone umane in linguaggi comprensibili e manipolabili dai software, in questo modo interferendo con i linguaggi e con i comportamenti che ne scaturiscono. Un esempio è il linguaggio politicamente corretto, definito da Curcio «l’ipocrisia istituzionalizzata», linguaggio che ha l’obiettivo di riprodurre l’esistente e rendere impossibile immaginare e organizzare «prospettive aperte, creative e istituenti».
I controlli linguistici che le piattaforme politicamente corrette operano contro parole, espressioni e concetti non coerenti con l’ideologia dominante del liberismo flussico costituiscono una delle più evidenti espressioni della società della sorveglianza nella quale siamo da tempo immersi.