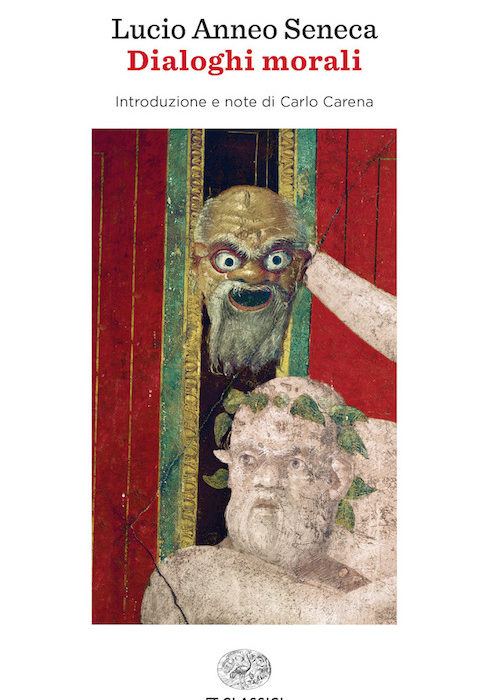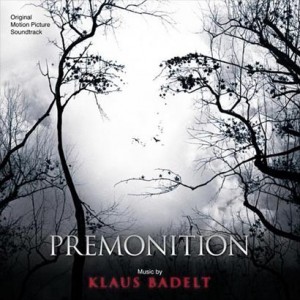Il primo giorno della mia vita
di Paolo Genovese
Italia, 2023
Con: Toni Servillo (Uomo), Valerio Mastandrea (Napoleone), Margherita Buy (Arianna), Sara Serraiocco (Emilia), Gabriele Cristini (Daniele)
Trailer del film
Di fronte alla volontà e alla prassi di un vivente che decide di porre fine alla propria esistenza, credo che debba valere soltanto un silenzio rispettoso e inquieto. Si tratta infatti di un gesto che sembra confliggere in modo clamoroso con il Wille zum Leben, con il desiderio di continuare a vivere che intrama ogni entità biologica, qualunque specie animale e vegetale. E tuttavia è un gesto che accade. E non poi così di rado. Chiedersi ‘perché?’ è insieme ozioso e tracotante, così diverse e così intime e oscure possono essere le ragioni che inducono a spegnere la propria vita. E diverse sono infatti le motivazioni e le modalità che hanno indotto Arianna, Emilia, Napoleone e Daniele a uccidersi. Arianna era una poliziotta che aveva perso la figlia sedicenne; Emilia una grande ginnasta che arrivava sempre seconda e che un incidente ha ridotto in carrozzina; Napoleone era un motivatore di successo, una specie di guru teso a convincere che la vita merita sempre di essere vissuta; Daniele era un ragazzino indotto dal padre a diventare un fenomeno social, nei cui video virali lo si vede divorare in pochi minuti decine e decine di dolci.
Tutti costoro erano o ancora sono? Non è chiaro. Un non meglio precisato personaggio sembra infatti convincerli all’ultimo istante di darsi ancora del tempo, ancora una settimana entro la quale potranno cambiare idea e annullare il gesto che li ha uccisi. Essi esistono dunque in una condizione nella quale nessuno li può vedere ma loro osservano tutto e constatano, tra le altre cose, quanto «vedere la vita senza di noi è doloroso sempre, e non perché è bella o brutta ma perché va avanti, va avanti comunque».
L’uomo che ha provvisoriamente sospeso il loro gesto non si sa chi e che cosa sia. È capace di aprire luoghi e situazioni con grande facilità; di far intravedere qualcosa del loro futuro, nel caso decidessero di averne uno; di mettere in atto alcuni poteri che attribuiremmo senz’altro a un dio ma che sono esercitati certamente da un umano che ha dei limiti oltre i quali non può andare.
Se il suicidio è un “crimine” perché infrange il corso delle cose voluto dalla potenza divina, allora secondo David Hume andrebbe giudicato altrettanto colpevole ogni e qualsiasi intervento sulla natura, le sue leggi, le sue manifestazioni: «Se disporre della vita umana fosse un diritto esclusivo dell’Onnipotente, tanto che fosse una violazione del suo ufficio per gli uomini disporre delle proprie vite, sarebbe ugualmente criminoso agire per la sua conservazione come per la sua distruzione» (Sul suicidio e altri saggi scelti, Villaggio Maori Edizioni, 2008, p. 15). Tra le altre argomentazioni humeane a difesa del suicidio ce n’è una la cui verità è evidente, quella per la quale «nessun uomo abbia gettato via la vita, finché essa era degna di essere conservata» (p. 20).
È questa attenzione alla qualità dell’esistere a essere del tutto disprezzata dal fanatismo e dalla superstizione che vogliono legare gli umani alla sofferenza come se essa fosse un valore da perseguire invece che un male da, sino a che è possibile, evitare. Superstizione che «rende gli uomini timorosi e sottomessi» (p. 24).
A tale superstizione Hume oppone la saggezza dei pagani, ben riassunta nelle parole di Seneca e di Plinio. Il primo ringrazia Dio «quod nemo in vita teneri potest» (Epist. 12), del fatto che nessuno può conservare per sempre la propria vita. Il secondo compiange il divino proprio perché non può, anche se lo volesse, darsi la morte: «Deus non sibi potest mortem consciscere, si velit, quod homini dedit optimum in tantis vitae poenis» (Nat. Hist. II, 5).
Un tema così profondo, delicato e controverso è affrontato in questo film in modo anche geometrico e freddo. Caratteristica che secondo alcuni critici e spettatori lo indebolisce. Io credo invece che sia una delle sua migliori qualità. Con i suoi primi piani e con un narrare sospeso, Paolo Genovese è capace di entrare a fondo nelle vicende umane e nella loro interiorità, come già accadeva in Perfetti sconosciuti (2016) e soprattutto in The Place (2017).