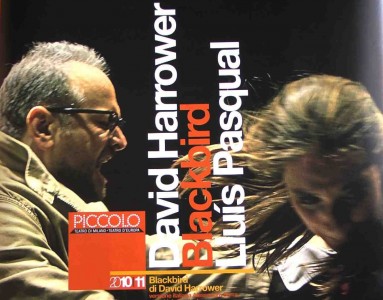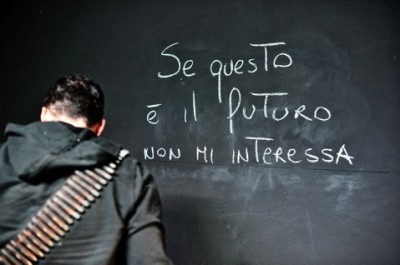Sul tempo. Una prospettiva teatrale
Teatro Strehler – Milano
La grande magia
di Eduardo De Filippo
con: Luca De Filippo (Otto Marvuglia), Massimo De Matteo (Calogero Di Spelta), Carolina Rosi (Zaira), Nicola Di Pinto (Arturo Recchia e Gennarino Fucecchia), Giovanni Allocca (il brigadiere di polizia e Oreste Intrugli), Gianni Cannavacciuolo (Gervasio Penna e Matilde)
Scene e costumi Raimonda Gaetani
Regia di Luca De Filippo
Produzione Compagnia di Teatro Luca De Filippo
Sino al 6 dicembre 2012
Video di presentazione
 Calogero Di Spelta è assai geloso della moglie Marta. In vacanza all’Hotel Metropole, questo suo sentimento diventa l’oggetto dei pettegolezzi dell’intero albergo. In effetti Marta ha un amante, che però non riesce mai a incontrare proprio a causa dell’attenta gelosia del marito. Ma arriva l’occasione, incarnata dal mago di provincia Otto Marvuglia, con il quale la donna si mette d’accordo in modo che durante un suo spettacolo «la faccia sparire per un quarto d’ora». Ma l’amante Mariano la porta via con sé a Venezia e Marta quindi sparisce per davvero. A Calogero che chiede al mago di restituirgli la moglie, Marvuglia risponde che in realtà è stato proprio lui a farla sparire e che Marta si trova in una cassettina che gli consegna. Se il marito la aprirà credendo fermamente nella fedeltà della donna ella riapparirà, in caso contrario la magia non avrà più fine. Calogero crede a tutto pur di non ammettere a se stesso il tradimento di Marta. Quando la donna tornerà da lui, dopo quattro anni, rifiuterà di riconoscerla, convinto ormai che nessuno potrà separarlo da quella cassettina che non ha ancora aperto e dentro la quale è racchiusa tutta la sua passione.
Calogero Di Spelta è assai geloso della moglie Marta. In vacanza all’Hotel Metropole, questo suo sentimento diventa l’oggetto dei pettegolezzi dell’intero albergo. In effetti Marta ha un amante, che però non riesce mai a incontrare proprio a causa dell’attenta gelosia del marito. Ma arriva l’occasione, incarnata dal mago di provincia Otto Marvuglia, con il quale la donna si mette d’accordo in modo che durante un suo spettacolo «la faccia sparire per un quarto d’ora». Ma l’amante Mariano la porta via con sé a Venezia e Marta quindi sparisce per davvero. A Calogero che chiede al mago di restituirgli la moglie, Marvuglia risponde che in realtà è stato proprio lui a farla sparire e che Marta si trova in una cassettina che gli consegna. Se il marito la aprirà credendo fermamente nella fedeltà della donna ella riapparirà, in caso contrario la magia non avrà più fine. Calogero crede a tutto pur di non ammettere a se stesso il tradimento di Marta. Quando la donna tornerà da lui, dopo quattro anni, rifiuterà di riconoscerla, convinto ormai che nessuno potrà separarlo da quella cassettina che non ha ancora aperto e dentro la quale è racchiusa tutta la sua passione.
Il paradosso e la tristezza dei sentimenti umani si esprimono qui al di là del dramma e della commedia. La gelosia è l’occasione per una complessa meditazione sul mondo interiore nel quale ciascuno vive, pensa, ama, soffre. Tutto è possibile all’immaginazione. Ciascuno si rinchiude nelle stanze della propria solitudine e da questo castello alto e desolato cerca di amministrare i feudi della disperazione. L’ipotesi che Otto Marvuglia presenta a Calogero Di Spelta è la stessa del film Matrix. Che cos’è realtà, che cosa è illusione? Apri la cassetta, prendi la pillola rossa, e ti troverai nel mondo vero. Tieni chiusa la cassetta, prendi la pillola azzurra, e continuerai a vivere in quell’illusione che tu chiami la verità del mondo.
Ma la svolta dentro questa vicenda tragica e grottesca è data dal tempo. Il mago, infatti, convince Calogero che il fluire degli istanti, delle ore, degli anni è soltanto «la traccia mnemonica di immagini ataviche»; che la sensazione dello scorrere dei giorni, l’imbiancare dei capelli, il raggrinzirsi della pelle è un inganno; che si trovano tutti sempre là, in quella serata all’hotel Metropole nella quale è cominciato il gioco dell’illusione, ha avuto inizio la grande magia.