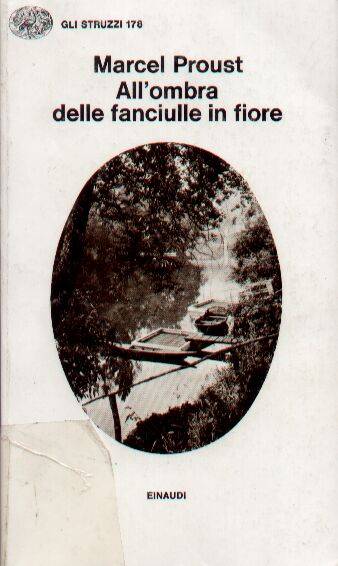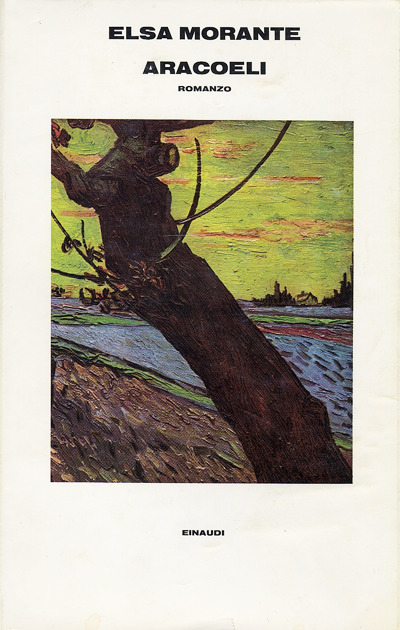All’ombra delle fanciulle in fiore
di Marcel Proust
(À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919)
Trad. di Franco Calamandrei e Nicoletta Neri
Einaudi, 1978 (1949)
Pagine XX- 604
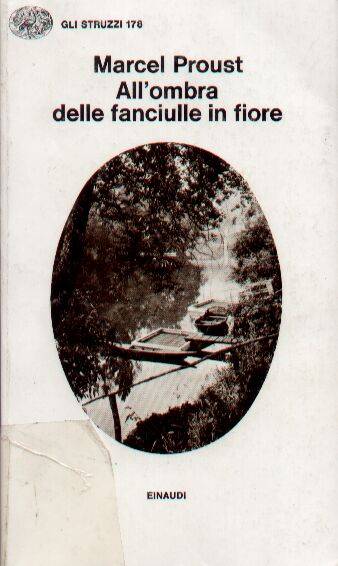 L’adolescenza, «quell’adolescenza che –come scrive Proust in una variante- pur restringendosi, riducendosi ad un esile filo d’acqua spesso asciutto, si prolunga tuttavia talvolta per tutto il corso della vita» (pag. 563), è uno dei temi che percorre il secondo volume della Recherche.
L’adolescenza, «quell’adolescenza che –come scrive Proust in una variante- pur restringendosi, riducendosi ad un esile filo d’acqua spesso asciutto, si prolunga tuttavia talvolta per tutto il corso della vita» (pag. 563), è uno dei temi che percorre il secondo volume della Recherche.
Il Narratore adolescente si introduce alla vita di società, ai salotti mondani, ai “bagni di mare”, ai primi amori, alla solitudine profonda della sua natura, una solitudine tanto naturale quanto necessaria:
Nello stare in sua compagnia, nel conversare con lui non provavo –e, certo, sarebbe stato lo stesso con chiunque altro- nulla di quella felicità che mi era invece possibile raggiungere quando ero senza compagno (336) 1
Ma, in mancanza di una compagnia sopportabile, [Elstir] viveva nell’isolamento, con una selvatichezza che le persone della società chiamavano posa e cattiva educazione, i poteri pubblici spirito di contraddizione, i suoi vicini follia, la sua famiglia egoismo ed orgoglio (431) 2
Noi non siamo simili a costruzioni cui si possano aggiungere pietre dall’esterno, ma a piante che traggono dalla loro propria linfa il nodo successivo del loro fusto, il piano superiore del loro fogliame (512) 3
E, sempre a proposito del pittore Elstir, «la pratica della solitudine gliene aveva dato l’amore» (431) 4 . Anche l’apertura al mondo misterioso, dolce e terribile dei sentimenti è pervasa di un profondo costruzionismo gnoseologico ed esistenziale: «Quell’Albertine era soltanto una sagoma; tutto quel che vi si era sovrapposto era opera mia» (462) 5 ; «Certamente pochi capiscono il carattere puramente soggettivo di quel fenomeno che è l’amore, e com’esso sia una specie di creazione d’una persona supplementare, distinta da quella che porta lo stesso nome in società, una persona di cui la maggior parte degli elementi sono opera nostra» (45) 6
Quando siamo innamorati di una donna proiettiamo semplicemente in lei uno stato della nostra anima; di conseguenza, l’importante non è il valore della donna, ma la profondità dello stato d’animo; e le emozioni che una ragazza mediocre ci dà possono permetterci di far risalire alla nostra coscienza parti più intime di noi stessi, più personali, più lontane, più essenziali, di quanto non farebbe il piacere che ci dà la conversazione di un uomo superiore o anche la contemplazione ammirata delle sue opere (436) 7
Quando si ama, l’amore è troppo grande perché possa trovar posto tutto quanto in noi; s’irradia verso la persona amata, incontra in lei una superficie che lo arresta, lo costringe a tornare verso il punto di partenza, e questo rimbalzo della nostra stessa tenerezza noi lo chiamiamo i sentimenti dell’altro, lo troviamo tanto più dolce di quanto fosse all’andata, perché non sappiamo che proviene da noi (196) 8
In Proust una saggezza immensa svela gli enigmi, le meschinità, lo splendore della società umana, i suoi meccanismi più nascosti, i dolori e le speranze più potenti.
E mentre Odette de Crécy, ormai diventata Madame Swann, così incede nello spazio della pagina e del mondo: «Non meno che dall’apice della sua nobile ricchezza, era dal glorioso colmo della sua estate matura ed ancora così saporita che la signora Swann, maestosa, sorridente e buona, inoltrandosi lungo l’avenue del Bois, vedeva, come Ipazia, sotto il lento incedere dei suoi piedi, volgersi i mondi» (229) 9, “la petit brigade des jeunes filles en fleurs” sboccia di una vita indeterminata e collettiva, voluttuosa e sorridente, sensuale e candida.
Note
1. «Je n’éprouvais à me trouver, à causer avec lui -et sans doute c’eût été de même avec tout autre- rien de ce bonheur qu’il m’était au contraire possible de ressentir quand j’étais sans compagnon» (À la recherche du temps perdu, Gallimard, Paris 1999, p. 582).
2. «Mais faute d’une société supportable, il vivait dans un isolement, avec une sauvagerie que les gens du monde appellaient de la pose et de la mauvaise éducation, les pouvoirs publics un mauvais esprit, ses voisins de la folie, sa famille de l’égoïsme et de l’orgueil» (p. 651).
3. «Nous ne sommes pas comme des bâtiments â qui on peut ajouter des pierres du dehors, mais comme des arbres qui tirent de leur propre sève le nœud suivant de leur tige, l’étage supérieur de leur frondaison» (p. 710).
4. «La pratique de la solitude lui en avait donné l’amour» (p. 651)
5. «Cette Albertine-là n’était guère qu’une silhouette, tout ce qui s’y était superposé était de mon cru» (p. 674)
6. «Sans doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu’est l’amour, et la sort de création que c’est d’une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde, et dont la plupart des élements sont tirés de nous-même» (p. 375)
7. «Je m’étais mieux rendu compte depuis, qu’en étant amoureux d’une femme nous projetons simplement en elle un état de notre âme; que par conséquent l’important n’est pas la valeur de la femme mais la profondeur de l’état; et que les émotions qu’une jeune fille médiocre nous donne peuvent nous permettre de faire monter à notre conscience des parties plus intimes de nous-même, plus personelles, plus lointaines, plus essentielles, que ne ferait le plaisir que nous donne la conversation d’un hommes supérieur ou même la contemplation admirative de ses œuvres» (p. 655).
8. «Quand on aime, l’amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous; il irradie vers la personne aimée, rencontre en elle une surface qui l’arrête, le force à revenir vers son point de départ et c’est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l’autre et qui nous charme plus qu’à l’aller, parce que nous ne reconnaissons pas qu’elle vient de nous» (pp. 482-483).
9. «Or, autant que du faîte de sa noble richesse, c’était du comble glorieux de son été mûr et si savoureux encore, que Mme Swann, majestueuse, souriant et bonne, s’avançant dans l’avenue du Bois, voyait comme Hypatie, sous la lente marche de ses pieds, rouler les mondes» (p. 506).