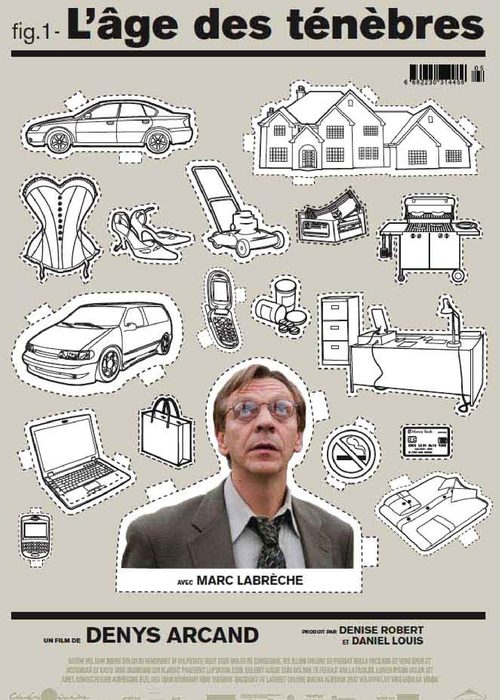L’umanità è nomade, plurale, meticcia; è Differenza. L’umanità è spazi, legami, comunità; è Identità. Non è possibile comprendere le vicende della nostra specie, la loro complessità, se non si è consapevoli di questa dinamica incessante di «interscambi etnoculturali» e della loro «cristallizzazione in forme solide e persistenti per lunghi periodi» (M. Tarchi, in Diorama Letterario, n. 344, luglio/agosto 2018, p. 2).
Le relazioni tra gruppi umani non sono riducibili alla semplificazione sentimentale e mercantile dei manifesti Benetton di Oliviero Toscani o delle lacrimevoli immagini che invadono i Social Network. Lo spazio e il tempo sono strutture fondamentali. Lo spazio fa sì che, come sostiene Paul Collier -docente di Economics and Public Policy a Oxford- nel suo Exodus. I tabù dell’immigrazione (Laterza, 2015)-, «grandi paesi dalle molte risorse e bassa densità come Stati Uniti, Canada ed Australia, hanno marcate capacità di accoglienza, e la politica delle porte aperte potrebbe rivelarsi benefica, quantomeno a livello economico; al contrario, la capacità di accogliere dei paesi europei ad alta densità demografica è assai limitata sicché una tale politica a lungo termine sarebbe poco lungimirante, conducendo a probabili esiti pesantemente negativi» (sintesi di G. Ladetto, ivi, p. 24). Il tempo è costruttore di legami, stratificatore di costumi, creatore di gesti, facitore di culture. L’umano è questo spazio e questo tempo che si incarna nei singoli e nelle collettività. L’umano è socialità, politica, simboli e non soltanto «l’immaginario tipicamente capitalistico del carattere centrale dell’economia e della produzione di merci» (A. De Benoist, p. 8).
In questo magma materiale e culturale si radicano i popoli e le classi. Essersi illusi di sostituire la centralità di queste strutture e di tali dinamiche con un’omologazione multietnica moralistica e quindi superficiale ha segnato «l’involuzione borghese della sinistra [che] non poteva non staccarla da chi sta in basso nella scala sociale» (Tarchi, p. 10). Stanno soprattutto qui le ragioni del successo in tutta Europa del populismo, nonostante gli eserciti mediatici e le risorse finanziarie che tentano di criminalizzare tale prospettiva sociale e politica.
A generare l’esodo contemporaneo dall’Africa all’Europa è stata «decisiva la sciagurata lotta per la supremazia nell’Africa sub-sahariana che ha impegnato negli anni Novanta del secolo scorso la Francia e gli Stati Uniti, e che resta nella memoria collettiva collegata ai massacri ruandesi degli Hutu. Guerra poi rovinosamente persa dalla Francia (e vinta dalla Cina), ma che, in epoca d’integralismo islamico, ha fatto deflagrare una buona parte del continente (uno schema che a Parigi sembrano portati a replicare, se si pensa a quanto accaduto in Libia)» (A. Callaioli, p. 18).
Per capire il fenomeno migratorio, la sua funzionalità all’ordine liberista e al capitale, sarebbe necessaria la lucidità che emerge ad esempio da un intervento di Carlo Freccero sul manifesto del 12.6.2018:
«Temo che la sinistra, privata dalla sua classe di riferimento, il proletariato, abbia fatto dei migranti una sorta di foglia di fico per dimostrare di essere ancora dalla parte dei più deboli.
Ma i migranti non sono il nuovo proletariato perché la loro coscienza identitaria non è qui ma altrove. Hanno diritto a non essere culturalmente sradicati, a meno che non si tratti di una loro libera scelta. Viceversa gli abitanti dei quartieri più poveri in Europa, hanno diritto a non essere sradicati dalle loro usanze da parte di un’immigrazione culturalmente eterogenea. I migranti non risiedono in via Montenapoleone e non portano via lavoro agli amministratori delegati. Decidere come fanno le élites che il popolo è brutto sporco e cattivo perché non vuole accoglierli è ingiusto. È il popolo che porta il peso dell’immigrazione con la perdita di valore del lavoro manuale.
La svalutazione del lavoro in questi anni di ordoliberalismo e di euro è stata possibile solo grazie all’esercito di riserva costituito dai migranti. È logico che le élites economiche siano favorevoli all’immigrazione. Le libera dall’incombenza di delocalizzare dove c’è disperazione, portando la disperazione direttamente qui».
Ancora una volta è necessario tener conto di spazio, tempo, numero. Nella Grecia antica gli stranieri erano protetti dalla divinità più importante, da Zeus. E dunque gli obblighi di ospitalità erano inderogabili, tanto che lo straniero «poteva restare nella casa che lo aveva accolto per il tempo che desiderava, e prima di andarsene riceveva ricchi doni. In futuro avrebbe ricambiato l’ospitalità, qualora se ne fosse presentata l’occasione. La posizione degli stranieri cambiò quando, con lo sviluppo delle polis, si pose il problema di chi far rientrare nella categoria dei cittadini. Gli stranieri di passaggio non potevano essere inclusi, ma non lo furono neppure coloro che, nati altrove, si erano trasferiti stabilmente in città. La vita degli immigrati era condizionata dai rapporti che la città ospite aveva con la loro terra d’origine. I barbari, spesso di origine mediorientale e persiana, erano considerati degli inferiori» (M. Fronte, Gli esclusi, in «Focus Storia. Antica Grecia», settembre 2018, p. 61).
Sia a Sparta sia ad Atene, come in ogni altra città, si cercava soprattutto di garantire l’equilibrio tra gli indigeni e i richiedenti ospitalità. La concessione della cittadinanza era esclusa in partenza, se non per particolari meriti civili, e ad essere accolti erano singoli o famiglie, non interi popoli. Nei rapporti tra gli esseri umani il numero conta perché è anche il numero che crea l’equilibrio tra identità e differenza.
Le parole di Giulia, una mia amica che vive a Friburgo e della quale riportai lo scorso anno una testimonianza, emergono in tutta la loro drammatica verità anche a proposito della recente tragedia di San Lorenzo a Roma e del massacro di Desirée Mariottini. Leggere in modo moralistico e sentimentale una dinamica sociale significa essere «marxisti immaginari», come anni fa scrisse Vittoria Ronchey. La compassione cristiana e gli interessi del capitale convergono e contribuiscono al dramma dell’Europa.