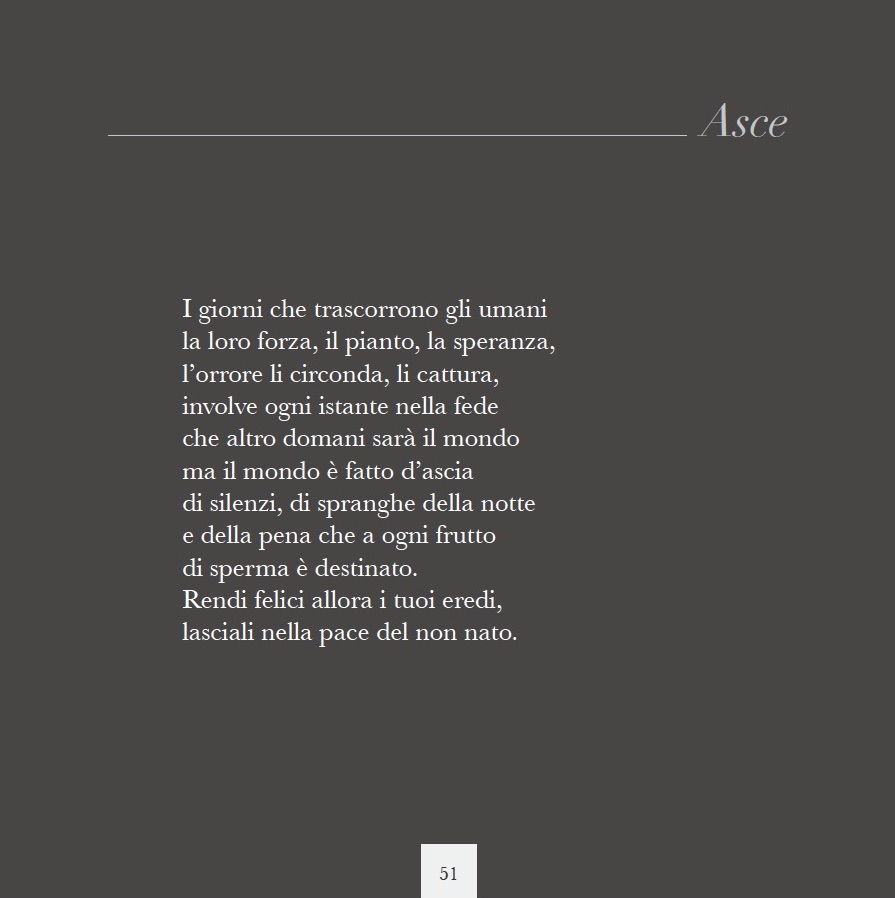Teatro Greco – Siracusa
Agamennone
di Eschilo
Traduzione di Walter Lapini
Scene di Davide Livermore, Lorenzo Russo Rainaldi
Video design: D-Wok
Musici: Diego Mingolla, Stefania Visalli
Con: Laura Marinoni (Clitennestra), Sax Nicosia (Agamennone), Linda Gennari (Cassandra), Stefano Santospago (Egisto), Spettro di Ifigenia (Carlotta Messina, Maria Chiara Signorello), Corifea (Gaia Aprea)
Regia di Davide Livermore
Sino al 5 luglio 2022
La cifra stilistica è naturalmente sempre quella che lo scorso anno caratterizzò Coefore / Eumenidi, anche se la declinazione è un poco diversa, più sobria. Sobria compatibilmente con le intenzioni di Livermore, che anche in questo caso travalica non soltanto Eschilo ma proprio l’idea greca del teatro. Nel preciso senso che la presenza del regista diventa preponderante e la formula registica potrebbe essere applicata a qualunque testo di qualsiasi epoca. Una notte, insomma, in cui tutti gli spettacoli sono uguali. Il coro è formato, tra gli altri, da generali più o meno paralitici e in ogni caso vecchissimi. I gesti sono meccanici, artificiosi, esagerati. Compaiono ovunque fantasmi, una figura evidentemente cara a Livermore. In questo caso nelle fattezze di due bambine che rappresentano il fantasma della Ifigenia sacrificata dal padre Agamennone e della cui morte la madre Clitemnestra appunto si vendica massacrando il marito e la nuova schiava/concubina Cassandra.
Coerente e interessante è invece l’idea di accompagnare l’intero spettacolo con la musica. Si parte da livelli alti, dai più alti, vale a dire da Bach ma si conclude con gli attori che eseguono una canzone accettabile ma che ancora una volta nulla c’entra. Se questo regista ama il musical perché non mette in scena dei musical?
Ma ancora una volta la parola di Eschilo sopravvive e vince.
Vince nel comprendere che «ἐγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων, si risveglia sempre il dolore dei morti» (v. 346, questo e gli altri versi vengono citati nella traduzione di Monica Centanni), che coloro che non sono più possiedono ancora la forza di legare a sé il destino dei vivi, nell’infinita serie di cause e legami che costituisce l’esistere.
Vince nel pieno splendore della Necessità, ben conscia che quanto sta accadendo è «μοῖρα μοῖραν ἐκ θεῶν, Moira contro Moira» (v. 1026), è l’inno originario di Ἄτη, «πρώταρχον ἄτην», le sue parole che -«ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν, cantano il canto della colpa originaria» (v. 1192).
Vince dicendo con chiarezza dall’inizio alla fine che la stirpe degli Atridi, «κεκόλληται γένος πρὸς ἄτᾳ, questa stirpe è legata con le catene di Ate» (v. 1566) e che pertanto tutto accadrà di ciò che deve accadere: infanticidio, matricidio, vendetta, giustizia. Nulla sfugge all’occhio gorgogliante di Erinni.
[Aggiungo queste poche parole stimolate dall’Agamennone di Livermore a quelle che la lettura del testo mi indusse a pensare: Distruzione a distruzione]