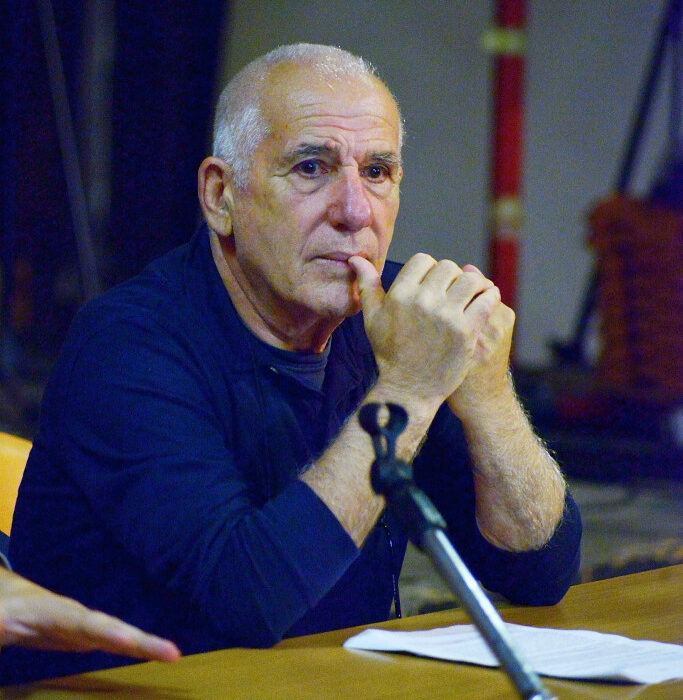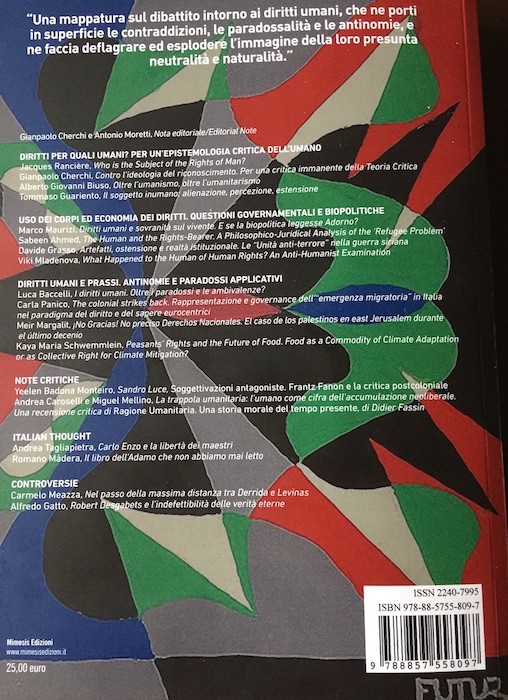«Quando al negro capita di guardare il Bianco con ferocia, il Bianco gli dice: ‘Fratello, non c’è differenza fra noi’. Eppure il negro sa che vi è una differenza»
(Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, ETS, 2015)
Più che opportuno, un approccio critico all’idea e all’ideologia dei diritti umani è proprio necessario in un’epoca che sembra vedere in essi una nuova religione. È questa la prospettiva del numero 2/2018 del «Giornale critico di storia delle idee. Rivista internazionale di filosofia / Critical Journal of Ideas. International Review of Philosophy», che ha come titolo Dell’uomo e dei diritti / On Human and Rights (Mimesis, 2019; vi è è stato pubblicato anche un mio contributo dal titolo Oltre l’umanismo, oltre l’umanitarismo).
L’obiettivo metodologico, scrivono i due curatori del volume, «era quello di fornire una mappatura sul dibattito intorno ai diritti umani con il fine di portarne in superficie le contraddizioni, le paradossalità e le antinomie, per far deflagrare ed esplodere l’immagine della loro presunta neutralità e naturalità. […] Compito della storia critica delle idee è infatti quello di porre in discussione e ripensare i ‘diritti dell’uomo’ al di là tanto della loro presunta naturalezza, nella forma dell’evidenza della loro definizione, quanto della presunta neutralità della loro applicazione» (Gianpaolo Cherchi e Antonio Moretti, Nota editoriale, pp. 7-8).
L’origine borghese di questi diritti li caratterizza ab ovo non soltanto come puramente formali e quindi adattabili a qualsiasi autorità, istituzione e scopo -emblematica una formula quale «guerra umanitaria»– ma soprattutto come falsamente universali. Dietro e dentro la loro formulazione abita infatti (come è ovvio) una certa e determinata idea di umano, quella dell’Occidente cristiano, che è una delle molte possibili ma che si presenta e si impone come l’unica pensabile.
La relatività, il particolarismo, la cangiabilità, la funzionalità a determinati obiettivi della teoria dei diritti umani sono mostrate in modo evidente e plastico dal plesso semantico terrorismo/terrorista. Nel suo saggio -uno dei più interessanti del volume– dal titolo Artefatti, ostensione e realtà istituzionale. Le ‘Unità anti-terrore’ nella guerra siriana, Davide Grasso analizza le ragioni per le quali individui, gruppi e istituzioni vengono definiti e si definiscono anche reciprocamente ‘terroristi’ e pertanto la grave debolezza epistemologica di questa caratterizzazione, che acquista senso soltanto in una prospettiva di propaganda politica:
L’alone semantico del termine ‘terrorismo’ è estremamente oscuro tanto nel linguaggio giuridico che nel linguaggio ordinario. […] Il termine terrorismo è quindi da considerarsi, nei fatti, uno strumento concettuale utilizzato da attori differenti per squalificare questa o quella manifestazione di potere, che si origini contro le istituzioni o da parte di istituzioni considerate illegittime. Questo spiega in gran parte la difficoltà giuridica, e ancor più metafisica, di definire il terrorismo. […] Una qualifica attribuita dagli stati, da almeno un secolo, alle organizzazioni armate che promuovono o difendono istituzioni alternative a quelle esistenti (136-137).
I diritti umani sono, anche e specialmente, un dispositivo del tutto impolitico e per questo molto pericoloso. Hannah Arendt, filosofa di acuta intelligenza sulle cose umane, nelle Origins of Totalitarianism ha sostenuto che «i Diritti dell’Uomo sono i diritti di coloro che sono solo esseri umani, che non hanno altra proprietà rimasta loro se non quella di essere umani. In altre parole, sono i diritti di chi non ha diritti, la mera parodia del diritto» (Jacques Rancière, Who is the Subject of the Rights of Man?, p. 27).
Una parodia del diritto che fa da fondamento alla sostituzione dell’elemento politico con quello morale e psicologico. Sostituzione che giustifica ogni struttura oppressiva. Un esempio tratto da un ambito apparentemente lontano ma spero chiaro è il concetto francescano di povertà. Esso favorisce la rassegnazione alla diseguaglianza economica perché giustifica la condizione di povertà, addirittura esaltandola come veicolo di santità, e permette a chi non è povero di mostrarsi solidale e umanitario dando parte della propria ricchezza a chi sta peggio. A condizione che questo scambio volontaristico e personale non intacchi le strutture economiche e sociali che generano povertà e ricchezza: «i poveri li avrete sempre con voi; e quando volete, potete far loro del bene», come disse il Rabbi galileo (Mc., 14,7, trad. Nuova Diodati).
Significativo sino a risultare fondamentale è anche lo slittamento semantico che ha in pratica cancellato dalla saggistica e dal discorso pubblico la parola sfruttamento sostituita dal termine discriminazione. «Sfruttamento» si riferisce infatti a una struttura socioeconomica, «discriminazione» a un atteggiamento psicologico-giuridico. La prima parola implica la necessità di un cambiamento oggettivo, per la seconda è sufficiente una modifica formale dei rapporti di potere.
La «recensione critica» che Andrea Caroselli e Miguel Mellino hanno dedicato al libro di Didier Fassin Ragione umanitaria. Una storia morale del tempo presente (Gallimard 2010; trad. it. DeriveApprodi 2018) si intitola La trappola umanitaria: l’umano come cifra dell’accumulazione neoliberale. Ne riporto alcuni brani che non hanno bisogno di commento.
Le molteplici ‘emergenze’ degli ultimi anni mostrano come il discorso umanitario, che trasforma l’appello a una medesima condizione umana nella sostanza stessa della politica, necessiti non solo di mostrare la presenza di soggetti sofferenti, mobilitando un immaginario caritatevole, ma, ancor più significativamente, di spostare l’attenzione dalla struttura a un soggetto, costruito in termini morali, nel quale sarebbe possibile riconoscerci perché garantiti da una presunta unità del genere umano. Un’economia dello sguardo, dunque, nella quale all’analisi delle cause si sostituisce una cura degli effetti (242-243).
[…]
Il dispiegamento della logica umanitaria, difatti, non fa che spogliare gli eventi di qualsiasi specificità di ordine storico-politico-economico e, nella ripetizione senza differenze di eventi drammatici, riafferma continuamente sia lo stato di emergenza da cui è legittimata, sia i rapporti di disuguaglianza entro cui si iscrive (243).
[…]
Ed è qui che risiede l’essenza e la forza (ideologica) della ‘ragione umanitaria’ come nuovo dispositivo egemonico di governo: nella sostituzione del vecchio lessico della politica organizzato attorno a espressioni come lotta, sfruttamento, dominio, diritti, giustizia, con una nuova grammatica discorsiva in cui a prendere il sopravvento sono nozioni di tipo morale come compassione, sofferenza, solidarietà (243).
[…]
Tuttavia, se è chiaro che ci troviamo permeati da un ordine del discorso politico dominato dall’empatia e dai sentimenti morali, è ormai altrettanto chiaro, a nostro avviso, come, per quanto riguarda le migrazioni, ‘il governo umanitario’ sia indissociabile dalla mercificazione progressiva del sistema dell’accoglienza, ovvero dai processi neoliberali di valorizzazione economica e di messa al lavoro di quegli stessi soggetti descritti attraverso la figura del ‘bisognos* d’aiuto’. Descrivere i dispositivi di governo umanitario senza metterne in evidenza né gli aspetti di rendita e di profitto, né la loro centralità nella produzione ’istituzionale’ di una forza lavoro precarizzata e semi-servile, equivale a de-politicizzare quella stessa critica alla de-politicizzazione che è la tesi forte dell’autore (244-245).
[…]
Per quanto la lotta per cercare di salvare vite umane sia assolutamente importante, ci sembra necessario che essa si rifletta all’interno di un’analisi che tenga conto della complessità del presente. Un’accettazione acritica del paradigma umanitario rischia infatti non solo di non rivelarsi all’altezza della sfida, ma di produrre effetti politici perversi (247).
Analisi come queste segnano la differenza tra una prospettiva economico/politica -e quindi strutturale ed emancipatrice dallo sfruttamento– e una prospettiva soltanto morale e sentimentale, limitata alla discriminazione formale e quindi reazionaria.