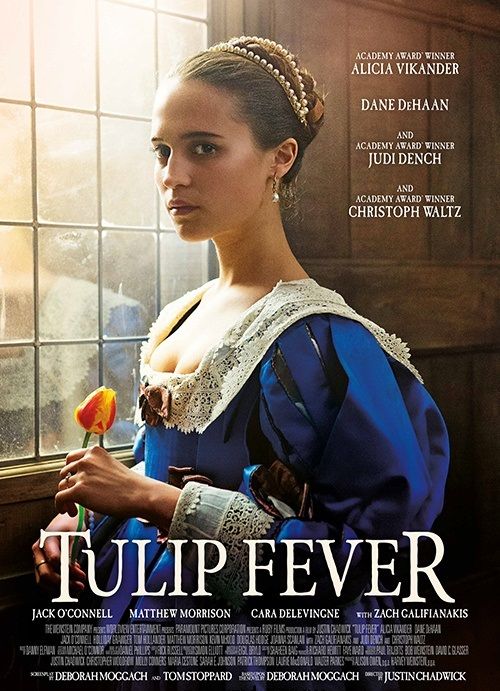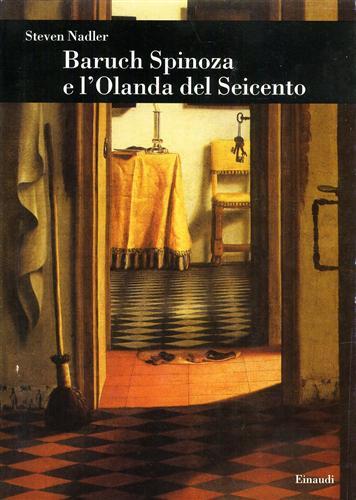Baruch Spinoza e l’Olanda del Seicento
(Spinoza. A Life, 1999)
di Steven Nadler
Trad. di Davide Tarizzo
Einaudi, 2009 (2002)
Pagine XV-410
Più l’Olanda del Seicento che Spinoza in questo libro. Per esplicita ammissione del suo autore, l’oggetto è non tanto la filosofia spinoziana quanto la vita e l’epoca, e soprattutto l’ambiente ebraico, alla cui storia, credenze, usi, costumi sono dedicati i primi sei capitoli, vale a dire metà dell’intero libro, la cui tonalità è chiaramente filosemita nel ripetuto tentativo di spiegare e giustificare i rabbini (Mortera, in particolare) e la comunità sefardita di Amsterdam. Giustificarli rispetto all’inaudita violenza del cherem che i capi religiosi e laici della comunità pronunciarono il 27 luglio 1656 contro il ventiquattrenne Spinoza, senza e prima che questi avesse pubblicato alcun testo. «Non esiste nessun altro documento di cherem emesso dalla comunità in quel periodo da cui trasudi la stessa collera» (p. 141). Una delle ragioni di tanto odio starebbe secondo Nadler nel fatto che un simile bando «oltre ad avere una funzione disciplinare interna, aveva pure il senso di un messaggio diretto alle autorità olandesi: gli ebrei erano una comunità in ordine, che -come previsto dagli accordi presi con la città- non tollerava infrazioni della condotta o della dottrina ebraiche. […] E forse la singolare animosità del bando contro Spinoza si spiega proprio con la volontà del ma’ amad di non dare l’impressione di proteggere individui che negavano non tanto i principî della fede ebraica, quanto quelli della religione cristiana» (167).
Le comunità ebraiche erano comunque abituate all’utilizzo costante e ripetuto delle scomuniche contro i propri membri. Le ragioni potevano essere le più varie e minuziose, visto che erano e sono migliaia i precetti disobbedendo ai quali si commette peccato. Ma è l’intera esistenza quotidiana di tali comunità a essere permeata di un formalismo totale ed esasperante, contro il quale si era infatti già pronunciato l’ebreo fondatore del cristianesimo e nei cui confronti anche Spinoza ritiene che «i seicentotredici precetti della Torah non hanno nulla a che fare con la virtù e la beatitudine» (303).
Dopo la scomunica Spinoza cessò di considerarsi un ebreo e parlò dei suoi antichi correligionari come di un’alterità con la quale nulla aveva a che fare. Non presentò ricorso -come sarebbe pur stato suo diritto- alle autorità civili della città «e neppure chiese aiuto a un’altra congregazione, come fece Prado. In effetti, non domandò neppure alla congregazione di rivedere il proprio giudizio. Abbandonò semplicemente la comunità» (171).
Forse anche per questo il testo di Nadler è percorso da una sottile avversione nei confronti del suo oggetto e verso la stessa filosofia intesa come esercizio di assoluta libertà razionale. Numerose potrebbero essere le conferme. Ad esempio, quasi a giustificare ancora una volta il cherem, «se Spinoza andava a dire cose simili […] e a stranieri per giunta! […] stava davvero giocando con il fuoco» (151-152); «Il suo scopo è nientemeno che la completa desacralizzazione e naturalizzazione della religione e dei suoi concetti […] Perfino l’immortalità dell’anima è considerata niente più che una ‘durata eterna’» (211); «Le parole di Spinoza [nell’Appendice alla I parte dell’Ethica] sono assai pesanti, ed egli non era del resto inconsapevole dei rischi che correva» (258); «Ma nessun altro filosofo ha mai neppure identificato Dio con la Natura» (262), affermazione non rispondente al vero, dato che la concezione immanentistica del divino è un’antica posizione filosofica, pur variamente declinata, e sostenuta qualche decennio prima di Spinoza pure da Giordano Bruno (anch’egli scomunicato e la cui morte rimarrà per sempre uno dei peggiori crimini della chiesa papista).
Le fonti di Spinoza furono assai varie: la mistica ebraica; forse l’eretico (anch’egli bandito con un cherem) Uriel da Costa; il suo maestro di latino e di varia umanità Franciscus Van den Enden; certamente Descartes; Euclide; gli stoici; e anche -è una delle affermazioni più interessanti di Nadler- l’intera comunità della città dove nacque: «Ex gesuiti radicali in politica, collegianti con tendenze sociniane, ebrei apostati, forse persino quaccheri e pensatori libertini -se si dovesse davvero accusare qualcuno di essere stato il ‘corruttore’ di Spinoza forse bisognerebbe a questo punto accusare la città di Amsterdam nel suo complesso, una città liberale, in cui fiorirono di continuo idee eterodosse» (163).
Furono naturalmente il suo carattere e la sua intelligenza a renderlo immune da qualunque tentativo di corruzione -«gli erano stati offerti mille fiorini ‘per fare presenza in sinagoga di tanto in tanto’. Spinoza, a quanto pare, rispose che ‘potevano anche offrirgli diecimila fiorini’ ma lui non avrebbe comunque mai accettato una simile ipocrisia, ‘poiché si preoccupava solo della verità, e non delle apparenze’» (170)-; a farlo vivere con grande frugalità e in profonda coerenza con le proprie idee -rifiutando sia gli onori sia le polemiche- e a rimanere sempre sereno, come testimonia Jean Maximilian Lucas uno dei suoi primi biografi: «A qualunque ora lo si trovava sempre di ottimo umore…Possedeva una grande e penetrante intelligenza, e trasmetteva un senso di appagamento» (218).
Anche alla luce di questo carattere equilibrato e sicuro di sé, la ‘solitudine’ di Spinoza è davvero una leggenda priva di fondamento, come Nadler suggerisce quando sottolinea le ottime relazioni dal filosofo intrattenute con una varietà di soggetti sia in presenza sia per corrispondenza; il suo tornare spesso ad Amsterdam anche dopo essersi trasferito a Rijnsburg prima e all’Aia poi; il grande numero di persone che seguì il suo feretro il 24 febbraio 1677, quattro giorni dopo la morte. «Lungi dall’essere quell’antipatico e misantropo recluso di cui si è tramandata leggenda, Spinoza era invece, una volta messo da parte il lavoro, una persona di compagnia, moderata e piacevole, sempre calma -come ci si poteva aspettare del resto dall’autore dell’Etica. Era gentile e pieno di riguardi, e si divertiva molto in compagnia degli altri così come gli altri si divertivano con lui» (319). Ovunque vivesse, Spinoza venne cercato da molti, o di persona o per lettera. Il suo Epistolario è uno dei filosoficamente più densi che si possano leggere, un vero specchio della mente e del carattere di quest’uomo.
Avversato sino all’odio, giudicato, empio, blasfemo, sovversivo, depravato, pericolosissimo (anche da Leibniz) e persino «di essere un agente di Satana, se non addirittura l’Anticristo in persona» (324), Spinoza ha offerto una delle più plausibili interpretazioni dell’essere e del posto che ogni ente -umani compresi- occupa in esso. Lo fece in tutte le sue opere e nell’Epistolario ma specialmente nel Tractatus Theologico-Politicus, che «è uno dei manifesti più eloquenti che siano mai stati scritti a favore di uno Stato democratico e laico» (315) e nell’Ethica ordine geometrico demonstrata, «un’opera ambiziosa e sfaccettata. Un testo davvero audace per la critica spietata e sistematica cui vengono sottoposte le correnti nozioni filosofiche di Dio, dell’uomo e dell’universo, con tutte le credenze teologiche e morali allegate. Nonostante la scarsità di riferimenti a pensatori del passato, il libro dà prova di una grande erudizione e di una approfondita conoscenza degli autori classici, medievali, rinascimentali e moderni -pagani, cristiani ed ebrei. Platone, Aristotele, gli Stoici, Maimonide, Bacone, Cartesio e Hobbes (tra i tanti) appartengono tutti allo sfondo culturale dell’opera, che rimane comunque, ciononostante, uno dei trattati più originali dell’intera storia della filosofia» (250-251).
Il disincanto sulle vicende umane si coniuga alla certezza di una razionalità invincibile che intride gli eventi. Per Spinoza la filosofia è il tentativo di comprendere questo significato e, una volta compreso, lasciarsene attraversare.





 di tutto il sempre vivace e ammaliante van Honthorst, con una splendida Vanitas (1618, qui a destra, anche se la foto -ahimè- non rende) nella quale la bellezza di una donna diventa specchio, morte, giustizia, arcano; poi un pittore senza nome, chiamato Maestro del Lume di Candela, poiché una candela è sempre il centro dal quale si dipartono i corpi, gli eventi, le situazioni; infine altri artisti nelle cui tele si diffonde una polvere di luce.
di tutto il sempre vivace e ammaliante van Honthorst, con una splendida Vanitas (1618, qui a destra, anche se la foto -ahimè- non rende) nella quale la bellezza di una donna diventa specchio, morte, giustizia, arcano; poi un pittore senza nome, chiamato Maestro del Lume di Candela, poiché una candela è sempre il centro dal quale si dipartono i corpi, gli eventi, le situazioni; infine altri artisti nelle cui tele si diffonde una polvere di luce. geometriche, astratte dallo spaziotempo, dentro la luce che si fa struttura. Queste opere e Giobbe deriso dalla moglie (1650, a sinistra) stanno al confine tra la pittura italiana e quella dell’Europa del Nord. Nel Giobbe una figura grande, dominante sino al divino, surclassa un uomo nudo e vago, il cui sguardo è, rispetto alla potenza di lei, una lacrima tenace. Uno degli ultimi dipinti – San Giovanni Battista nel deserto (sotto)– raffigura una solitudine ai confini delle tenebre, del nulla.
geometriche, astratte dallo spaziotempo, dentro la luce che si fa struttura. Queste opere e Giobbe deriso dalla moglie (1650, a sinistra) stanno al confine tra la pittura italiana e quella dell’Europa del Nord. Nel Giobbe una figura grande, dominante sino al divino, surclassa un uomo nudo e vago, il cui sguardo è, rispetto alla potenza di lei, una lacrima tenace. Uno degli ultimi dipinti – San Giovanni Battista nel deserto (sotto)– raffigura una solitudine ai confini delle tenebre, del nulla.