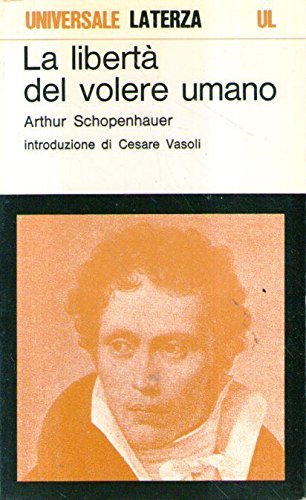Nel recensire questa Rivista dedico ogni volta uno spazio consistente a malattie, sindromi, sciagure di vario genere. È forse triste ma anche inevitabile, visto che il corpomente è “na scarfoglia i cipulla”, vale a dire (la definizione è della mia nonna paterna -Giuseppa-, donna davvero straordinaria) una foglia di cipolla, fragile e sottile, pronta dunque a sbriciolarsi. Mi sono ricordato di quella definizione leggendo la risposta che Leonardo Tondo dà a un lettore che delinea un vero e proprio «ritratto di una depressione»; lo psichiatra scrive infatti che «la depressione si infila spesso nei gangli vitali di una persona, e talvolta è difficile mandarla via perché sembra più congeniale alle nostre emozioni della felicità» (p. 7). Ciò vuol dire che c’è qualcosa che ci attira verso il baratro dello star male, che la prospettiva di esser felici ci spaventa a volte più di una condizione di profonda tristezza. Perché? Rispondere a tale domanda significherebbe comprendere una parte consistente dell’enigma umano. E sospetto che la risposta coinvolga anche quel particolare -e distruttivo- sentimento che è il senso di colpa, il quale secondo molti psicologi ha degli effetti positivi o addirittura necessari per evitare atti di ferocia e di crudeltà. E tuttavia penso che il senso di colpa debba rimanere sempre a livelli bassissimi poiché alla lunga distrugge le relazioni umane, la serenità, le vite. Una ragione di questa sua pericolosa caratteristica sta nel fatto che la colpa è -in modo solo apparentemente paradossale- «un’emozione narcisistica» in quanto «chi si sente in colpa tende a mettere le proprie azioni al centro del mondo» (P.E. Cicerone, 76), attribuendo sempre a se stesso la responsabilità di ogni male, credendosi insomma onnipotente. Ma non basta: provare sensi di colpa verso qualcuno ci autorizza a detestarlo con il conforto di una buona coscienza. In definitiva nutrire eccessivi sensi di colpa vuol dire essere essenzialmente egoisti. Ecco perché chi -come ad esempio Nietzsche- invita a sbarazzarsi di questa orrida zavorra lo fa anche come atto d’amore verso se stessi e verso gli altri. Se ne deduce che le religioni che sul senso di colpa fondano gran parte del loro potere -a partire dall’ebraismo, con la sua storiella di Adamo ed Eva- sono nemiche di ogni concordia.
Nel recensire questa Rivista dedico ogni volta uno spazio consistente a malattie, sindromi, sciagure di vario genere. È forse triste ma anche inevitabile, visto che il corpomente è “na scarfoglia i cipulla”, vale a dire (la definizione è della mia nonna paterna -Giuseppa-, donna davvero straordinaria) una foglia di cipolla, fragile e sottile, pronta dunque a sbriciolarsi. Mi sono ricordato di quella definizione leggendo la risposta che Leonardo Tondo dà a un lettore che delinea un vero e proprio «ritratto di una depressione»; lo psichiatra scrive infatti che «la depressione si infila spesso nei gangli vitali di una persona, e talvolta è difficile mandarla via perché sembra più congeniale alle nostre emozioni della felicità» (p. 7). Ciò vuol dire che c’è qualcosa che ci attira verso il baratro dello star male, che la prospettiva di esser felici ci spaventa a volte più di una condizione di profonda tristezza. Perché? Rispondere a tale domanda significherebbe comprendere una parte consistente dell’enigma umano. E sospetto che la risposta coinvolga anche quel particolare -e distruttivo- sentimento che è il senso di colpa, il quale secondo molti psicologi ha degli effetti positivi o addirittura necessari per evitare atti di ferocia e di crudeltà. E tuttavia penso che il senso di colpa debba rimanere sempre a livelli bassissimi poiché alla lunga distrugge le relazioni umane, la serenità, le vite. Una ragione di questa sua pericolosa caratteristica sta nel fatto che la colpa è -in modo solo apparentemente paradossale- «un’emozione narcisistica» in quanto «chi si sente in colpa tende a mettere le proprie azioni al centro del mondo» (P.E. Cicerone, 76), attribuendo sempre a se stesso la responsabilità di ogni male, credendosi insomma onnipotente. Ma non basta: provare sensi di colpa verso qualcuno ci autorizza a detestarlo con il conforto di una buona coscienza. In definitiva nutrire eccessivi sensi di colpa vuol dire essere essenzialmente egoisti. Ecco perché chi -come ad esempio Nietzsche- invita a sbarazzarsi di questa orrida zavorra lo fa anche come atto d’amore verso se stessi e verso gli altri. Se ne deduce che le religioni che sul senso di colpa fondano gran parte del loro potere -a partire dall’ebraismo, con la sua storiella di Adamo ed Eva- sono nemiche di ogni concordia.
L’articolo filosoficamente più interessante di questo numero di Mente & cervello è dedicato a un breve resoconto sulla questione del libero arbitrio [il testo si può leggere per intero in inglese sul sito di Nature]. Gli esperimenti neurologici di Libet e di Haynes hanno mostrato come ancora prima «che il soggetto fosse consapevole di aver preso una decisione il suo cervello aveva già scelto» e che dunque «la consapevolezza di aver preso una decisione potrebbe essere nient’altro che un’appendice biochimica, priva della pur minima influenza sulle azioni della persona» (K.Smith, 96). Il dibattito su queste ricerche è amplissimo e intenso; per farsene un’idea consiglio la lettura di Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il problema del libero arbitrio, a cura di De Caro, Lavazza e Sartori, Codice edizioni, 2010. Qui mi limito a rilevare -con l’autrice dell’articolo- che bisogna prima di tutto mettersi d’accordo su che cosa si intenda con l’espressione libero arbitrio: «Alcuni filosofi lo definiscono come la capacità di prendere decisioni razionali in assenza di coercizione. Altre definizioni lo situano in un contesto di natura cosmica: al momento della decisione, e considerando come dato tutto ciò che è accaduto in passato, sarebbe stato possibile giungere a una decisione diversa. Altri restano legati all’idea che ci sia un’ “anima” di natura non fisica a governare le decisioni» (99). Si aggiunga a questo il problema metodologico che nasce dal fatto che gli esperimenti di Libet, di Haynes e di altri neurologi si riferiscono a situazioni di estrema semplicità: «Premere un pulsante o giocare a un videogioco è ben lontano dal preparare una tazza di tè, candidarsi alla presidenza della Repubblica o commettere un delitto» (100). L’ostacolo più grave al dialogo tra filosofi e neuroscienziati è comunque un altro e consiste nel fatto che questi ultimi si attardano spesso -ed è certo singolare- su una concezione dualistica dell’umano. Parlare infatti di una precedenza dell’attività neuronale su quella mentale o viceversa significa rimanere in un ambito nel quale mente e cervello sono distinti; il paradigma cartesiano si mostra così assai più potente e pervasivo di quanto anche i suoi avversari pensino.
La successione cronologica individuata da Libet e Haynes costituisce un importantissimo contributo tecnico sulle dinamiche dell’encefalo ma non può essere assunta a metodo di soluzione di una questione che va molto oltre la scansione cerebrale e che ha bisogno invece di tutta l’attenzione fenomenologica che soltanto la filosofia può offrire. Bisogna dunque con tranquillità affermare che sul problema del libero arbitrio continuano a dare una plausibile soluzione le argomentazioni di Spinoza e di Schopenhauer. Queste sì capaci di togliere fondamento all’illusione del libero arbitrio.