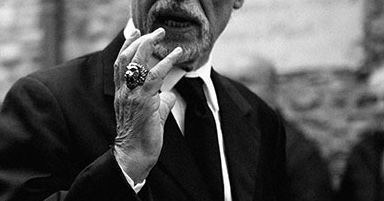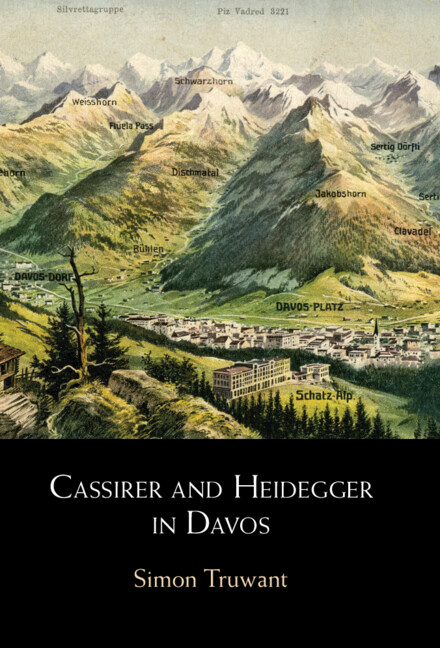Pensieri da Quarantena è il titolo di una mail che ho ricevuto da un mio allievo. L’ho ricevuta con lo stupore che ogni docente prova quando vede che le proprie parole sono diventate vita di un essere umano.
Nelle riflessioni che Ivan D’Urso mi ha rivolto c’è una saggezza antica, la saggezza di chi è stato forgiato dalla sofferenza, dal rischio, dalla differenza. Unite all’intelligenza, queste forme contribuiscono a fare di Ivan una persona libera, nonostante una situazione esistenziale non facile. Lo ringrazio per aver autorizzato la pubblicazione della sua testimonianza insieme filosofica e civile.
Ho scelto come immagine una tra le più famose e potenti incisioni di Albrecht Dürer, Il cavaliere, la morte e il diavolo (1513). Nietzsche si riferì a quest’opera nella Nascita della tragedia, dove scrisse: «Ein solcher Dürerscher Ritter war unser Schopenhauer: ihm fehlte jede Hoffnung, aber er wollte die Wahrheit. Es giebt nicht Seinesgleichen», ‘Un tale cavaliere di Dürer fu il nostro Schopenhauer; gli mancò ogni speranza, ma volle la verità. Non esiste il suo pari’ (trad. di S. Giametta, in «Opere», vol. III/1, Adelphi 1972, § 20, p. 136). Anche Husserl teneva nel suo studio una riproduzione dell’incisione, vedendo nel cavaliere un simbolo della fenomenologia e quindi della filosofia.
Mi sembra dunque che questa immagine possa ben sintetizzare il senso delle parole di Ivan e aiutarci ad attraversare il tempo che siamo
==============
Gentile Professore,
tra qualche giorno i miei account social mi ricorderanno del giorno della mia laurea, dei festeggiamenti, del traguardo ed inevitabilmente di ciò che è cambiato da allora.
Le scrivo perché, anche se a livello formale non sono più un suo studente, mi sento nel profondo ancora un suo allievo.
Oggi, come succede dal mio ventiduesimo mese di vita, ho ricevuto la terapia che mi tiene in vita.
Quella che fa di me un Cyborg-Freak come ho avuto modo di scrivere altrove.
Ho ricevuto tre sacche di sangue, e tanto basterà se il cielo lo desidera, per tenere la mia “batteria” carica per altri venti giorni.
[…]
Le confesso che è un periodo incerto ed anche un po’ pauroso per essere un malato cronico, forse, avendo dentro le mie vene centinaia di vite mescolate insieme, avverto in modo più acuto il timore collettivo.
Eppure non mi riesce proprio di comprendere la rassegnazione.
Una volta lei disse che la Filosofia:
“è ciò che ci permette di affrontare lo sguardo di Medusa: PER RENDERE LEI una statua di pietra”
Di affrontare dunque le nostre paure con determinazione, curiosità, amore per la conoscenza.
Gentile Professore, temo che nei prossimi mesi vedremo compiere delle scelte che ci faranno sperimentare in modo diretto “La banalità del male” ed i limiti (aimè) della democrazia.
Allo stesso tempo sento che fino a quando potrò scegliere di capire, sino a quando avrò la forza di porre delle domande, non importa in quale condizione: sarò vivo.
Sarò tempo pulsante che si interroga sulla propria natura.
Questo momento storico ha mietuto molte più vittime di quelle che risultano nei conteggi ufficiali.
Poiché ho visto brillanti studenti, aspiranti ribelli, cedere con tanta, troppa, velocità al loro diritto di libertà e di porre domande.
Ed essi vivono il tempo subendolo, come se la vita si limitasse a una serie di azioni da apprendere nei decreti mentre i libri di Filosofia e di Sociologia prendono polvere su di un comodino.
La mia parte logica comprende. Il mio lato umano in questo si dispera.
Solo nella Filosofia trovo conforto.
Soltanto in essa (e nei visi dei miei cari) trovo un senso.
Ed è in questi giorni di grande incertezza che l’Essere Per La Morte del maestro Heidegger assume un significato sublime.
E sento il dovere di vivere pienamente, sento che posso farlo davvero.
Perché ho visto la Medusa divenire di pietra.
E questo grazie anche a lei, caro Professore, e mi sembrava il minimo condividere queste righe e questi pensieri perché, nonostante tutto, ci siamo ancora.
E siamo liberi.
Con affetto e devozione
Ivan D’Urso