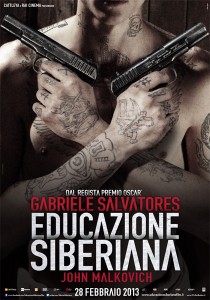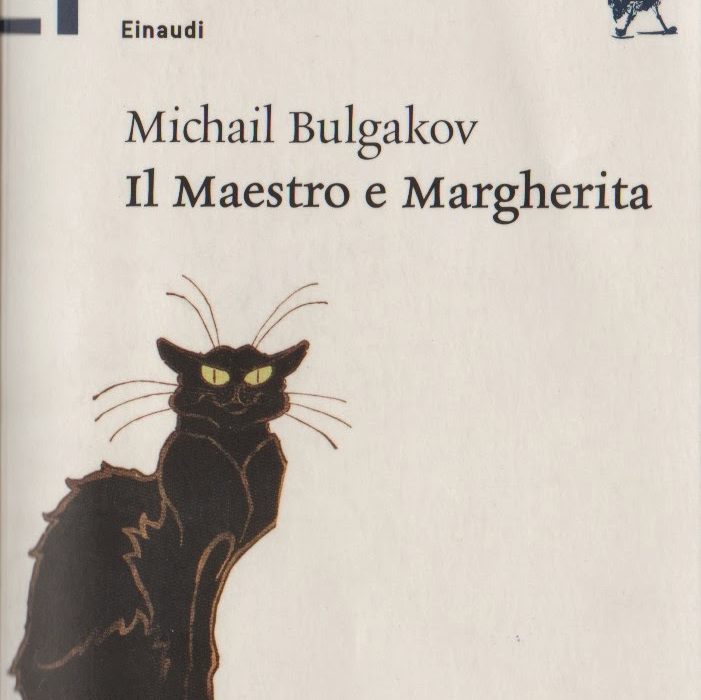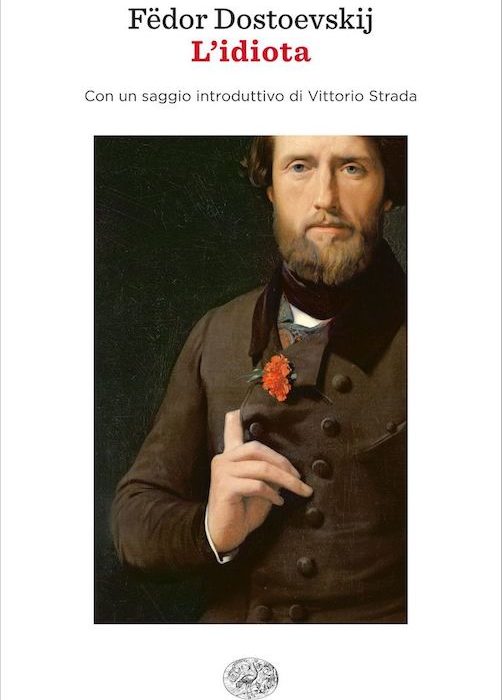Ringrazio Pasquale D’Ascola per avermi segnalato un’analisi geostrategica che mi sembra del tutto plausibile. Si intitola Il chiarimento del caos. Perché gli USA usano l’ISIS per conquistare l’Eurasia. È stata pubblicata l’8.9.2014 su Informare per resistere. Lettere dalla Resistenza.
È un testo che sistematizza concetti e ipotesi che formulo anch’io da tempo. Qualche traccia -a proposito di Pasolini, della ‘sinistra’ istituzionale, del dominio statunitense sulla società dello spettacolo- l’avevo elaborata già nel 1998 in Contro il Sessantotto.
L’analisi inizia con un riferimento ai corsari dell’età moderna, incipit tanto esatto quanto illuminante.
Per il resto, basti ricordare -cosa che i media mainstream hanno di botto dimenticato (con qualche interessante eccezione)- che l’ISIS -lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante– cominciò ad apparire ufficialmente in Siria, nella guerra civile contro il regime di Assad organizzata e sostenuta degli USA, dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Queste potenze sono state quindi alleate dei terroristi tagliatori di teste.
A chi è scettico sulla possibilità che «la maggiore democrazia del mondo» si spinga a tanto, l’articolo ricorda che «il regista Oliver Stone e lo storico Peter Kuznick con molto acume hanno fatto notare che con Hiroshima e Nagasaki gli USA non solo volevano dimostrare al mondo di essere superpotenti, ma anche –cosa ancor più preoccupante- che non avrebbero avuto alcuno scrupolo nella difesa dei propri interessi: erano pronti a incenerire in massa uomini, donne e bambini». La totale spregiudicatezza degli Stati Uniti nella creazione e conservazione del loro potere mondiale non è una fantasia degli antiamericanisti ma una realtà storica documentata in molti modi dalla II Guerra mondiale in avanti. L’elenco allungherebbe inutilmente questa nota; per rendersene conto basta conoscere un poco di storia contemporanea.
Ma l’elemento più interessante è il reale obiettivo del terrorismo sostenuto in modo così ambiguo ma anche così convinto dagli Stati Uniti d’America: neutralizzare la Russia (tutta la vicenda Ucraina ha questo pericolosissimo scopo, assolutamente autolesionistico per l’Europa) e minacciare la Cina, il vero nemico futuro -economico e politico- degli States, quello che porterà a un conflitto totale, al compimento di ciò che l’autore chiama giustamente la «Terza Guerra Mondiale a Zone», iniziata l’11 settembre 2001 e da allora sempre più capillare, estesa, violenta, apparentemente oscura nella sue modalità anche finanziarie ma in realtà evidente nei suoi obiettivi. Non aver compreso tale dinamica geopolitica è stata ed è (anche questo viene ben chiarito nell’articolo) una delle principali cause del tramonto politico e culturale di ciò che dal 1848 è stato chiamato «sinistra».