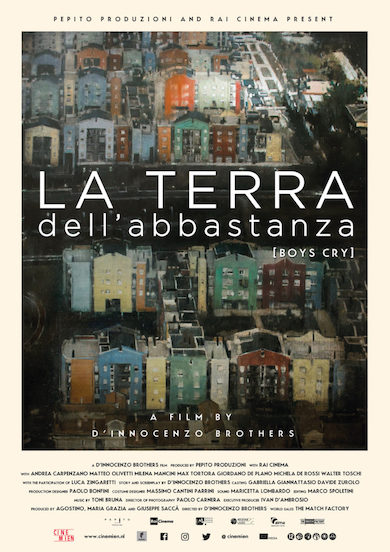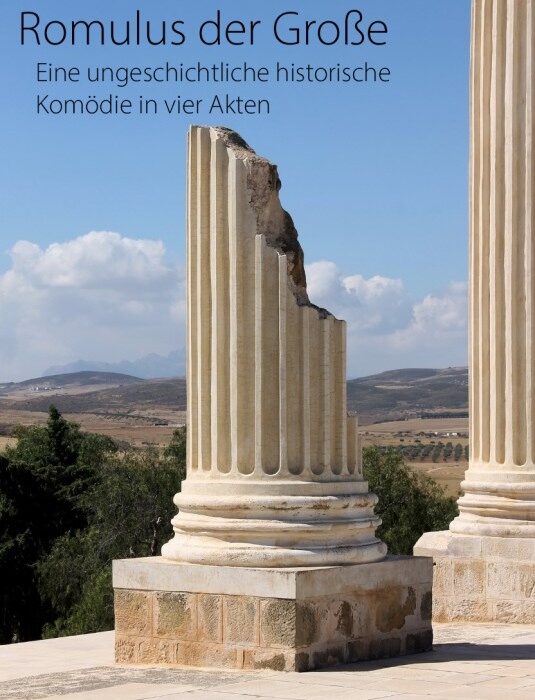Conclave
di Edward Berger
USA, 2024
Con: Ralph Fiennes (il cardinal Lawrence), John Lithgow (il cardinal Tremblay), Stanley Tucci (il cardinal Bellini), Lucian Msamati (il cardinal Adeyemi), Sergio Castellitto (il cardinal Tedesco), Isabella Rossellini (Suor Agnes)
Sceneggiatura di Robert Harris (II) e Peter Straughan
Fotografia di James Friend e Stéphane Fontaine
Trailer del film
La Chiesa cattolica romana è un’istituzione millenaria. Come tutte le istituzioni, è animata dalle passioni, dagli interessi, dagli inganni, dalle malvagità, dalle generosità e dagli ideali degli esseri umani.
Un momento fondamentale nell’esistenza di questa struttura teologico-politica è il passaggio dalla dichiarazione di «sede vacante», quando il Papa regnante muore, al proclama: «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!», allorquando il suo successore è stato eletto. È in quel momento, che può durare giorni o settimane, che converge a Roma il più antico ed esclusivo gruppo di potere del mondo, quello dei prelati che costituiscono il cardine della Chiesa romana. È del tutto ovvio e naturale che nei giorni del conclave si manifestino e confliggano visioni assai diverse dell’umano e della storia. E dunque visioni assai diverse della Chiesa.
Il romanzo di Robert Harris Conclave racconta questo evento in un momento indefinito ma assai delicato, intriso di tensioni politiche e belliche internazionali. Il Papa è morto all’improvviso e a guidare i cardinali è chiamato il Decano del Sacro Collegio, il cardinale britannico Thomas Lawrence. Un uomo sensibile, profondo, poco incline alla politica ma molto attento a uomini e circostanze. Dovrà guidare un Collegio ideologicamente diviso nel quale le ambizioni personali esprimono modelli assai diversi di Chiesa.
Molti sono i colpi di scena ma sono secondari rispetto allo splendore dei luoghi, all’eleganza degli abiti, alla antichità delle formule, alla solennità del latino nei momenti decisivi. Il cuore della Chiesa romana è la Cappella Sistina, sede del Conclave, perché il cuore luminoso della Chiesa romana è la bellezza, è l’arte, è il sapere, è il rito. È quella dimensione profonda e sacra che le chiese e le sette riformate hanno perduto perché a essa hanno esplicitamente rinunciato, stoltamente convinte che il luogo della fede sia ‘il cuore e l’interiorità’ degli umani, vale a dire quanto di più aleatorio e miserabile ci sia.
Il pericolo reale, non inventato o narrativo, che la Chiesa Romana corre da tempo è la tentazione di diventare come i riformati, vale a dire di morire in quanto Chiesa e continuare a vivacchiare come insieme di associazioni filantropiche. Una tendenza ben presente nell’attuale pontificato, che sembra guidato più da un sociologo che da un uomo sacro. Dato che l’unica forma decente di cristianesimo è quella cattolica, e in parte quella ortodossa, mi dispiacerebbe se essa dovesse scomparire, sostituita da un insieme di gruppi che credono di essere loro la chiesa e sono invece composti, come tutte le sette, da soggetti problematici e del tutto incentrati su di sé, sul loro ‘cuore’, sulle loro certezze etiche, sui loro ‘valori’.
Il film è elegante e fascinoso. Ha un solo grave difetto: negli ultimi dieci minuti si inceppa in modo implausibile e bizzarro con un finale in clamoroso ed evidente contrasto con tutto ciò che lo precede, un finale politicamente ultracorretto. Peccato, è il caso di dire. Come ha commentato una mia amica, questa faccenda del politicamente corretto non soltanto va deturpando anche le migliori opere letterarie, teatrali e cinematografiche ma «ormai sta diventando un requisito patetico, come i titoli di coda».
In Conclave gli ultimi dieci minuti sono banali e del tutto trascurabili. Il film si conclude davvero, avrebbe dovuto concludersi, con l’elezione di un cardinale che aveva pensato di prendere il nome di Giovanni, evidentemente XXIV. Un film realistico, splendidamente fotografato, coinvolgente, godibile.