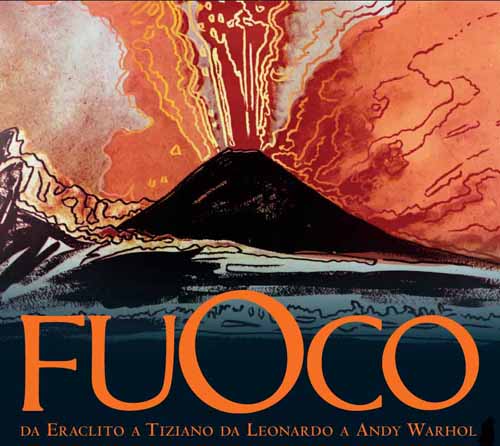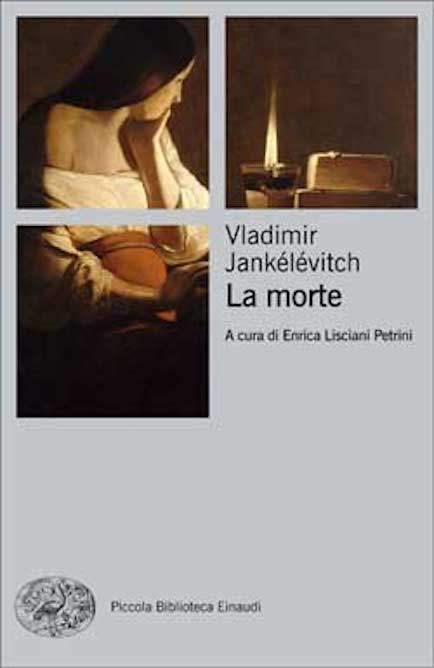La morte
di Vladimir Jankélévitch
(La Mort, Flammarion, Paris 1977 [1966] )
Trad. di Valeria Zini
A cura di Enrica Lisciani Petrini
Einaudi, Torino 2009
Pagine XXXVI-474
Tra le tante sciagure dell’esistenza, almeno una ci è stata risparmiata: nessuno conosce con certezza la data del proprio morire. I Greci attribuiscono a Prometeo questo dono. Lo attribuiscono non a caso al titano che regalò agli umani la tecnica. Due modi questi -tecnica e ignoranza del morire- che consentono alla specie di affrontare ogni giorno l’esserci. Di questo mito Jankélévitch afferma che esso «ci concede (…) una modalità del futuro illusoria» (pag. 142).
È un particolare, un veloce passaggio all’interno del fiume di parole che è il libro. Ma è un particolare significativo. L’Autore rifiuta le tante forme di consolazione che cultura, filosofia, scienze hanno inventato per rendere sensata l’insensatezza del non essere più dopo essere stati. Obiettivo polemico continuamente tornante è il Fedone, la tesi che il morire sia un passaggio, tesi che poi diventa -in altre culture- transito verso una pienezza ontologica assai più densa dell’ombra del presente.
No, la morte non è in alcun modo una trasformazione; né una trasformazione minuscola, né una trasformazione più grande, né una trasformazione minore, né una trasformazione maggiore e nemmeno, propriamente parlando, una trasformazione suprema! La morte non è l’abbandono di queste o quelle determinazioni, ma l’abbandono di ogni forma; e non solo è l’abbandono totale della forma, ma anche l’abbandono della sostanza stessa che supporta questa forma e del rapporto stesso di questo supporto, e così via all’infinito. (241)
Per Jankélévitch nel fatto del morire ontologia ed epistemologia convergono sino al punto da costituire, semplicemente, l’impensabile, il nulla, ciò di cui non c’è né esperienza, né parola. «Evento unico e incomprensibile, l’istante mortale elude ogni concettualizzazione» (229), tanto che «la scienza della morte è morta a sua volta nell’istante della sua nascita. Mai ci sarà stato possibile pensare la morte simultaneamente a essa» (371). Perché e come, allora, scrivere quasi cinquecento pagine sulla morte?
Partendo da tali presupposti, esse non possono che oscillare tra la ripetizione prolissa delle stesse tesi; riferimenti all’intuizione letteraria e musicale più che alla teoresi (citato e amato più di ogni altro è Tolstoj, «il più grande genio dell’oggettività» [462], e in particolare il denso e struggente racconto sulla Morte di Ivan Il’ič); antropocentrismi sentimentali che vedono nella nostra specie una sorta di entità privilegiata che dovrebbe essere salvaguardata dalla propria fine; invenzioni lessicali a volte di dubbia utilità; descrizioni banali anche se espresse in modo lirico; svelamenti conclusivi che attribuiscono alla tragedia del morire uno statuto di “semplicità” che tutto il resto del libro sembra negare: «semplice come bere un bicchier d’acqua, così semplice che ci domanderemo, il giorno in cui sapremo, come mai non ci abbiamo pensato prima» (463). Un oscillare tra la morte come necessario attrito della vita e la morte come disperazione, «nero assoluto» (81). E tutto in un tono che vorrebbe essere lucido ma che appare più spesso lugubre.
Non mancano, certo e per fortuna, elementi più interessanti e più spendibili in sede teoretica e quindi esistenziale. Tra questi una efficace sintesi concettuale secondo cui
avendo trattato, a proposito della vita, del mortalis che esprime una proprietà astratta, e del moriturus che designa un futuro e una vocazione, poi, a proposito dell’istante, del moribundus «sul punto di» morire e del moriens «che sta per morire», dovremmo trattare adesso del mortuus, che designa uno «stato» (372-373);
una esatta riflessione sul legame che unisce il morire alle concezioni dualistiche dell’umano, poiché è vero che «se noi vedessimo solo l’uomo vivo in stato di veglia, senza dubbio non avremmo alcuna ragione per distinguere in lui due sostanze da pensare separatamente, o per considerarlo come un composto psicosomatico: infatti, immediatamente noi vediamo un corpo significante, un senso incorporato, un volto espressivo, ma non vediamo mai né un’anima, né una dualità di anima e corpo» (395).
Fecondi sono alcuni passaggi dedicati alla temporalità, argomento evidentemente inseparabile da quello del morire. Jankélévitch individua uno degli elementi peculiari del tempo -rispetto anche allo spazio- nella sua irreversibilità, nel non offrirsi per intero allo sguardo ma nel dover essere percorso in una successione vissuta. E soprattutto Jankélévitch conosce la pervasività del tempo, simile a quella della luce su ogni ente che l’occhio possa percepire:
Ma il tempo non si trascura impunemente: il tempo è quel non-so-che che nessuno vede con gli occhi o tocca con le mani, di cui lo stesso orecchio non percepisce direttamente il fluire, che non ha né forma, né colore, né odore, che nessun pensiero concepisce, che non è né una dimensione, né una forma, né una categoria, che è dunque quasi-inesistente e che è, nonostante questo, la cosa più essenziale di tutte. Se non si prende in considerazione questo fattore invisibile e impalpabile oltre che ineffabile, ci si espone ai più gravi disinganni. (293)
E tuttavia per Jankélévitch -come per numerosi altri filosofi- il tempo rimane un nemico dell’umano, invece che esserne -come è- la sostanza stessa. La conseguenza è che anche Jankélévitch cerca e trova una qualche consolazione al morire. E la individua in una peculiare forma di opposizione alla temporalità: l’eternità dell’essere stati.
In ogni caso, questa è la rivincita, la consolazione e la speranza dei mortali: la morte distrugge il tutto dell’essere vivente, ma non può nichilizzare il fatto di aver vissuto; la morte riduce in polvere l’architettura psicosomatica dell’individuo, ma la quoddità della vita vissuta sopravvive a queste rovine. (…) Si potrebbe dunque dire che la vita eterna, vale a dire il fatto indelebile di essere stato, è un regalo che la morte fa alla persona vivente. (…) Il baleno più fragile, fragile come un fuoco fatuo nella notte, fonda la più incancellabile quoddità: se infatti la vita è effimera, il fatto di aver vissuto una vita effimera è un fatto eterno. (454-456)
Quale sia la differenza tra questa consolazione e quelle che Jankélévitch aspramente condanna non è dato sapere. Da questo libro si esce avendo meglio compreso il senso dell’invito spinoziano: «Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitæ meditatio est» (Ethica, parte IV, prop. LXVII), che non è un invito a nascondere ma a comprendere il senso del morire nel tessuto inarrestabile e potente della materia/mondo.