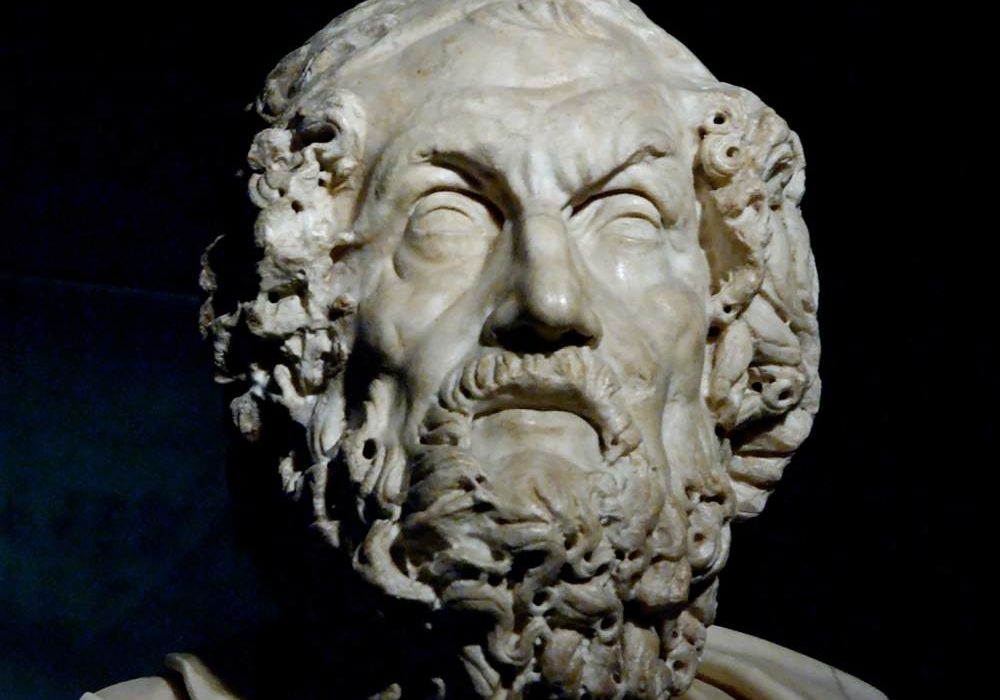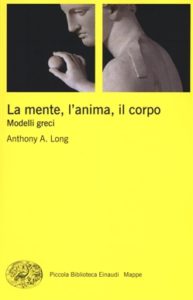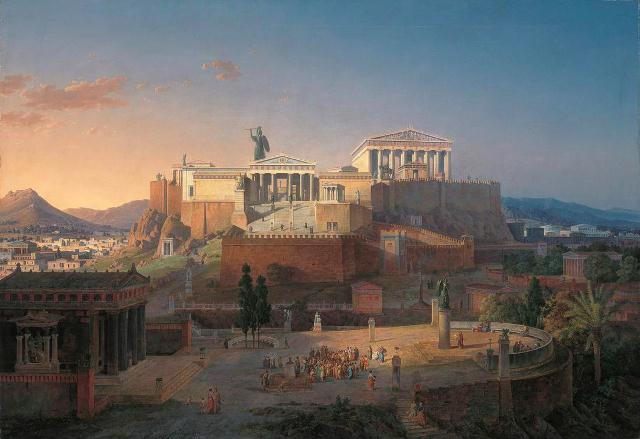«Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt, 5, 43-48).
Quanti cercano di seguire davvero queste massime di Jeshu-ha-Notzri perdono una delle gioie della vita. Essa consiste nel vedere soffrire chi ci ha fatto soffrire; nel gustare la caduta di quanti produssero in noi lacrime, umiliazioni o tristezza; nel godere sino in fondo e con un sorriso della malattia, dell’abbandono, della rovina che afferra chi ci ha procurato dolore. A coloro che mi hanno ingannato, tradito, voluto del male -come costui, come uomini e donne che non hanno meritato il mio amore e la mia amicizia, come alcuni indegni soggetti incontrati in contesti professionali-, io auguro ogni sofferenza.
Ma in realtà i cristiani provano di frequente la gioia che qui sto cercando di descrivere. Loro che ben lontani dall’“amare i nemici” sono sempre stati i primi a massacrarli. Guerre di religione, roghi (Giordano Bruno sarà per sempre la maledizione dei papisti e Michele Serveto lo sarà per i protestanti), persecuzioni di streghe ed eretici, colonialismo, benedizione di tutte le guerre, complicità con i mafiosi e i pedofili, conflitti interni per il potere, sostegno a ogni sorta di tiranni, crimini vasti e di varia natura, costituiscono il contrappasso che condanna tali ipocriti. I cristiani negano la natura umana e però la praticano (e che altro potrebbero fare?), i pagani la seguono senza mentire, in primo luogo a se stessi:
«καὶ τὸ τοὺς ἐχθροὺς τιμωρεῖσθαι καὶ μὴ καταλλάττεσθαι (e vendicarsi dei nemici è più bello anziché riconciliarsi)»
(Aristotele, Retorica A, 9, 1367 a, 24).
«Ma ho forse torto a lamentarmi… la prova, io sono ancora vivo… e perdo dei nemici tutti i giorni!… di cancro, … di apoplessia, di ludreria… è un piacere come che si svuota il sacco!… non insisto… un nome!… un altro! ci sono dei piaceri nella natura…»
(Céline, Da un castello all’altro, in «Trilogia del Nord», Einaudi 2010, p. 24).
«οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν ἐχθρῶν κακοῖς οὔτ᾽ ἄδικον οὔτε φθονερόν ἐστι τὸχαίρειν (gioire dei mali dei nemici non è né ingiusto né invidioso)»
(Platone, Filebo, 49 D).
«εἰ κεινόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’Ἄϊδος εἴσω / φαίνην κε φρέν ἀτερπου ὀιζύος ἐκλελαθέσθαι» [Se lo vedessi discendere dentro i recessi di Ade, / direi che un brutto malanno avrebbe scordato il mio cuore]. Questo dice Ettore di Paride, suo fratello, in Iliade, VI, 284-285.
Così fanno i pagani.