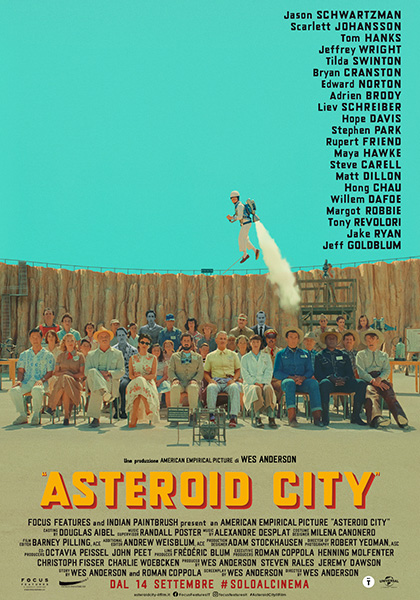Teatro Biondo – Palermo
La grande magia
di Eduardo De Filippo
Con: Natalino Balasso (Calogero di Spelta), Michele Di Mauro (Otto Marvuglia), Veronica D’Elia (Amelia Recchia), Gennaro Di Biase (Mariano d’Albino e brigadiere), Christian di Domenico (Arturo Recchia e Gregorio Di Spelta), Maria Laila Fernandez (Signora Marino e Rosa Di Spelta), Alessio Piazza (Gervasio e Oreste Intrugli), Manuel Severino (cameriere dell’albergo e Gennaro Fucecchia), Sabrina Scuccimarra (moglie di Otto Marvuglia), Alice Spisa (Marta Di Spelta), Anna Rita Vitolo (Signora Zampa e Matilde, madre di Calogero)
Scene di Roberto Crea
Regia di Gabriele Russo
Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
Sino al 15 dicembre 2024
I sentimenti umani, gli inquieti e tristi sentimenti umani. Tra di essi, uno dei più potenti e distruttivi è la gelosia. Marcel Proust più di ogni altro ha mostrato come e quanto la gelosia non sia soltanto potente, non sia soltanto distruttiva ma sia anche necessaria. Necessaria quando un altro umano (amante, marito, moglie, figlio, amico e così via) occupa per intero lo spazio interiore di qualcuno, quando vale a dire si è innamorati.
È tale necessità a dare a Calogero di Spelta il potere distruttivo di far sparire la sua bella moglie. Certo, non è lui direttamente a farlo ma è un illusionista miserabile eppure abilissimo, Otto Marvuglia, il quale viene pagato dall’amante della moglie per distrarre per un quarto d’ora Calogero. E però questo breve tempo diventa un abbandono. I due amanti fuggono da Napoli a Venezia e al mago non resta che far credere al marito che si trovano tutti dentro un grande gioco, una grande illusione, nella quale la moglie sparita è ora dentro una cassettina. Se Calogero aprendola avrà fede, la signora ricomparirà, in caso contrario sparirà per sempre. L’uomo non apre la cassetta, la porta sempre con sé nel trascorrere degli anni, nell’invecchiare, nella disperante speranza – che diventa ambigua certezza – di trovarsi dentro un gioco il quale tra pochi momenti avrà fine per restituire lui e la moglie al tranquillo cortile dell’albergo dove Otto Marvuglia ha iniziato la sua magia.
Pirandello, indubbiamente. Ma molto oltre Pirandello, verso la dimensione che fa dire a Marvuglia che lui è soltanto un piccolo mago, che sopra di lui c’è un mago più grande e poi ancora un altro, «fino alla perfezione». «Il mondo è un’illusione» afferma il trattato gnostico Sulla resurrezione (NHC I,4, 48) a organizzare la quale è il grande mago che assume vari nomi, tutti malvagi, tutti immersi nel non sapere, tutti fatti di tristezza. La tristezza profonda di una commedia/dramma che il regista Gabriele Russo riesce a rendere plausibile e leggera ma mai superficiale, mai ovvia.
La grande magia è infatti un testo che va oltre, molto oltre, la gelosia e altri sentimenti umani, dai quali pure sono partito. Le scene colorate, quotidiane e insieme esotiche, di Roberto Crea suggeriscono che questa magia è la nostra vita di tutti i giorni, intrisa di certezze e di illusioni, di speranze e di abbandoni, di cassette dentro le quali racchiudiamo i nostri slanci.