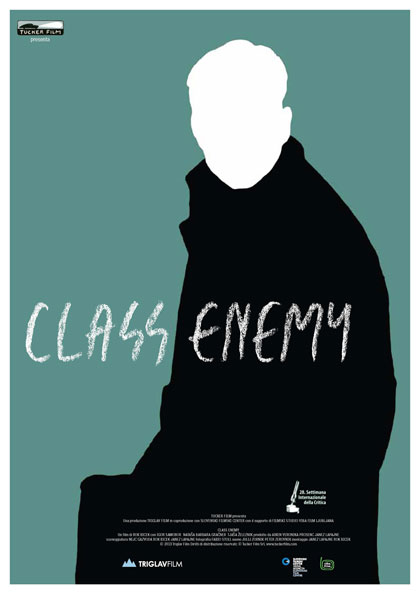«Quell’antica luce risplende ancora»
Werner Jaeger
PAIDEIA. La formazione dell’uomo greco.
Vol. III Il conflitto degli ideali di cultura nell’età di Platone
(Paideia. Die Formung des griechiscen Menschen, Walter de Gruyter e Co., 1947)
Trad. di Alessandro Setti
La Nuova Italia, 1990
Pagine 540
Il grande affresco sulla παιδεία si chiude (dopo il volume I e volume II) confermando la complessa unitarietà della cultura e dell’antropologia greca nella quale etica, medicina, politica e arte fanno tutt’uno, pur rimanendo distinti nella conoscenza. Anche per questo l’immagine di Platone come puro dialettico è certamente errata. Già vecchio, egli si sottopone alla fatica di un terzo viaggio a Siracusa per confermare la praticabilità del progetto politico della Repubblica. Diversamente da quanto spesso si ripete, per Platone il corpo non è soltanto σῆμα della mente ma anche elemento imprenscindibile nella formazione dell’essere umano. La medicina greca non si compone di una molteplicità di saperi specialistici, dedicati alla cura di morbi particolari ma guarda all’armonia del corpomente. La malattia consiste precisamente nello spezzarsi di tale armonia. «In questo senso superiore l’ideale greco della cultura umana può definirsi anche come l’ideale dell’uomo sano» (pag. 76). Platone pone sempre l’accento sull’azione, sul vivere, su una corrispondenza stretta e costante fra il pensare e l’essere.
Jaeger difende l’autore delle Leggi dalle accuse che questo dialogo ha ricevuto di eccentricità, pedanteria o -con Popper- di totalitarismo. Egli mostra come anche nell’ultimo suo dialogo Platone avversa l’accentramento del potere nelle mani di uno solo. Lo studioso esorta a paragonare la teocrazia platonica non agli stati moderni ma a quell’impresa educativa che è la chiesa cattolica. Emerge qui la dimensione religiosa della lettura di Jaeger, vicina a quella di Eric Voegelin, il quale in Order and History fa anch’egli di Platone una sorta di profeta del cattolicesimo. Quella lettura di Voegelin non mi convinse e non mi persuade neppure questa parte dell’interpretazione di Jaeger, per numerose ragioni. La principale è che Platone vuole fondare un’istituzione educativa -lo stato- in questo mondo e non una chiesa rivolta per definizione a preparare alla trascendenza. Le forme ideali platoniche sono l’essenza degli enti mondani, non la fase propedeutica alla santità del cielo.
Ma Platone è solo uno dei protagonisti di questo volume. Gli si affiancano Isocrate, Senofonte, Demostene. Nella diversità e persino nel conflitto delle loro posizioni politiche –basti pensare al filomacedone Isocrate contrapposto all’intransigenza di Demostene verso le imprese di Filippo- pulsa la stessa dimensione educativa del sapere e la medesima visione aristocratica del mondo e della παιδεία.
Come per i Sofisti, anche per Isocrate sono tre i fondamenti dell’azione educativa: la natura, l’apprendimento e l’esercizio. Se uno dei tre viene a mancare, essa non può che fallire. Indispensabile è dunque l’insegnamento, ma esso risulta efficace solo dove la natura -e cioè il biologico- ha predisposto un terreno adeguato all’impresa. Si deve anche a questa realistica consapevolezza se in Atene, «città incomparabile» (85), «si raggiunse una media culturale così alta» (75). Isocrate ebbe il merito di sostituire alla antica nobiltà di nascita «una nuova aristocrazia intellettuale» (264). La perennità della παιδεία ellenica è inseparabile da un sentimento elitario della vita.
Se «quell’antica luce risplende ancora» (513) si deve anche a un legame fortissimo con la dimensione naturale dell’uomo. Da qui nasce un’antropologia del possibile e del raro, un umanesimo tanto pervasivo ed esigente quanto lontano dal pregiudizio umanistico dei moderni.