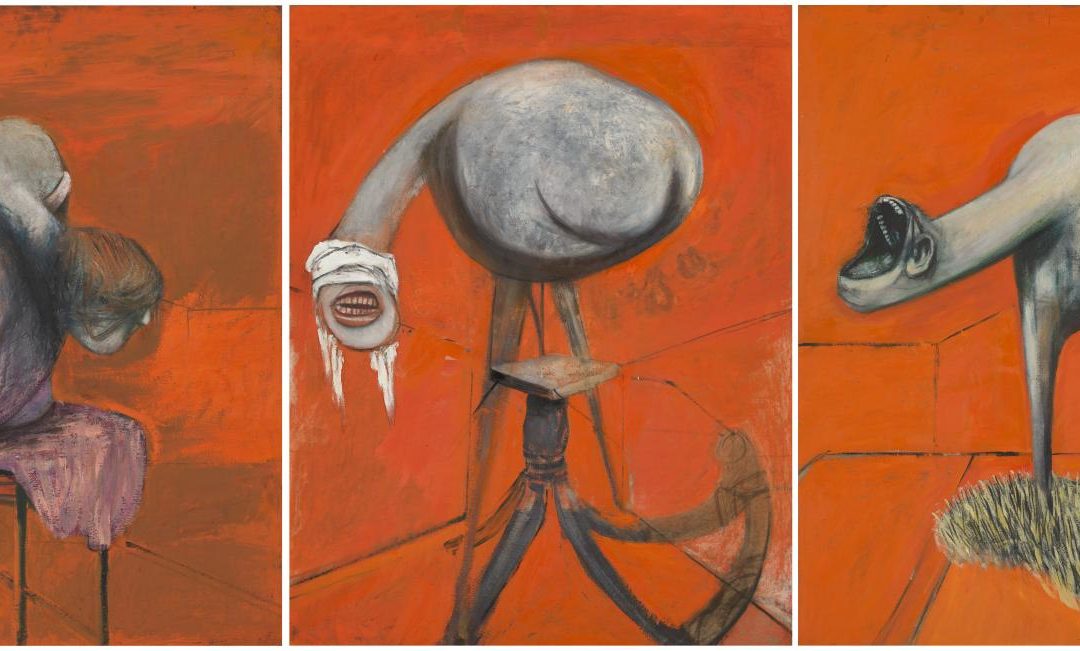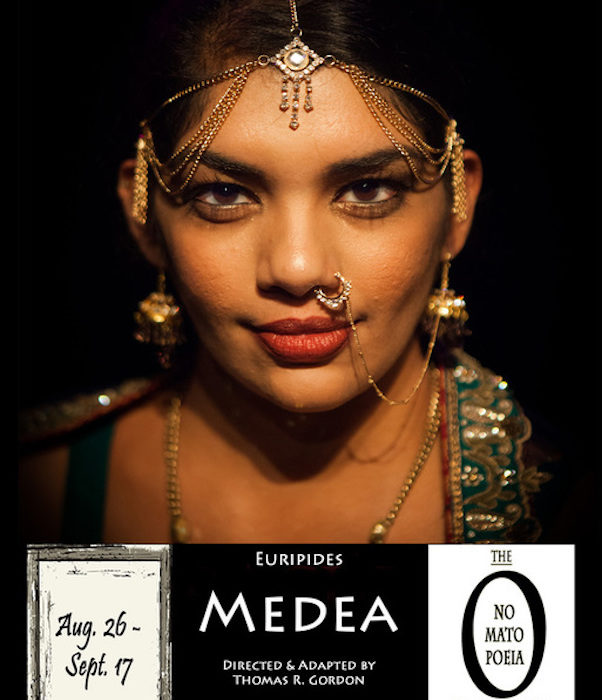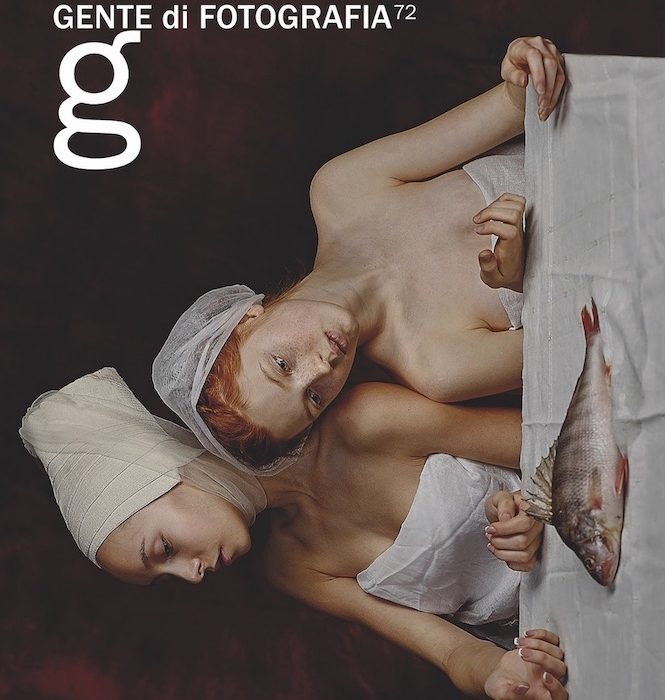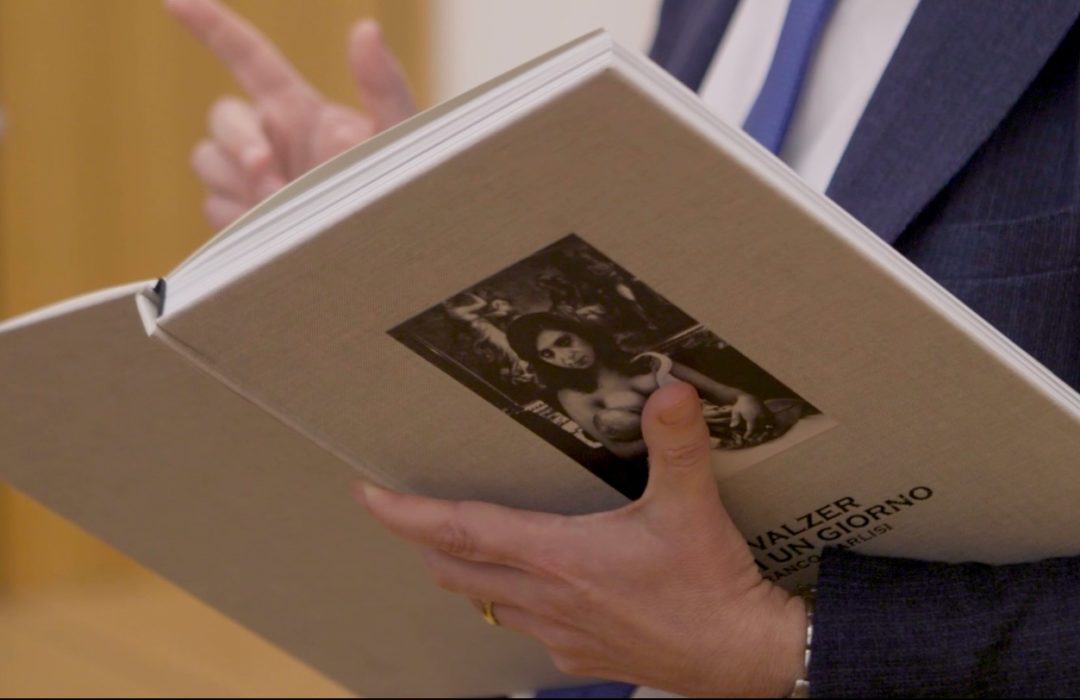Per i Greci c’è nell’umano una suprema innocenza. Essi sanno e accettano che la nostra natura sia intrisa di limite, tempo, balbettio, tramonto. Assai più grande è infatti la forza degli dèi rispetto alla fragilità di una condizione finita. Se «la sorte dell’uomo è patire»1, questo è dovuto alla volontà dei Numi, che sono anch’essi passione e materia che brama. Una passione che spinge Afrodite a vendicarsi del disprezzo che le arreca il troppo casto Ippolito. La dea colpisce ponendo nel cuore di Fedra «una brama violenta, per volere mio» (114) poiché stolto è stato Ippolito a pensare di potersi, lui solo, affrancare dall’universale autorità del desiderio. Di se stessa infatti Afrodite canta la forza: «Tutti quelli che vedono la luce entro i confini del Ponto Eusino e dei monti d’Atlante, io li tengo in onore se s’inchinano al mio potere, mentre abbatto quanti sono verso di me sprezzanti e alteri» (113).
Da una tale potenza discende il piano inclinato dell’innamoramento di Fedra per il figlio di suo marito; delle ingenue trame che la nutrice organizza per dare compimento al desiderio della donna; dell’orrore che agli occhi di Ippolito tutto questo rappresenta; della vergogna e della vendetta di Fedra che morendo lo accusa; della troppo rapida maledizione scagliata da Teseo contro il figlio; della morte straziata di lui.
Artemide nulla può per salvare il proprio devoto, poiché «vige fra gli dèi questa legge: nessuno vuole opporsi al volere di un altro dio, ciascuno si ritira» (156), senza che però questo escluda la vendetta di Artemide che colpirà Afrodite nel più profondo degli amori di lei, quello verso Adone.
Accomunati sono quindi umani e divini nella passione. E se «non c’è per l’uomo una vita che trista non sia, né tregua c’è dell’affanno» (121) -tanto che «la cosa migliore, però, è, senza coscienza, morire» (123)-, agli umani Euripide offre lo strumento supremo della parola che accusa gli immortali dell’impotenza degli dèi di fronte al male profondo. Se, dichiara Artemide, «è normale che l’uomo sbagli, se gli dèi lo vogliono» (160), Ippolito giunge a dire -morendo- «potesse l’uomo maledirli, i numi» (159). Un coraggio filosofico e cosmico che a nulla si piega, se non ad Ἀνάγκη, signora di tutti, umani o divini che siano
Ben conoscendo tale realtà, nella mia vita ho onorato Afrodite e Dioniso, senza seguire la misurata e miserabile saggezza della nutrice: «Dovrebbero amarsi fra loro non più di tanto i mortali, non giungere mai a un affetto che tocca le viscere, sì da allentare o serrare i legami che crea l’amore, senza difficoltà» (123). Lascio un simile equilibrio, lascio tale distanza, ai contabili e preferisco immergermi nella luce della dea venuta dal mare, nella spuma potente del cosmo.
1. Euripide, Ippolito, in «Le tragedie», trad. di Filippo Maria Pontani, Einaudi 2002, p. 121.