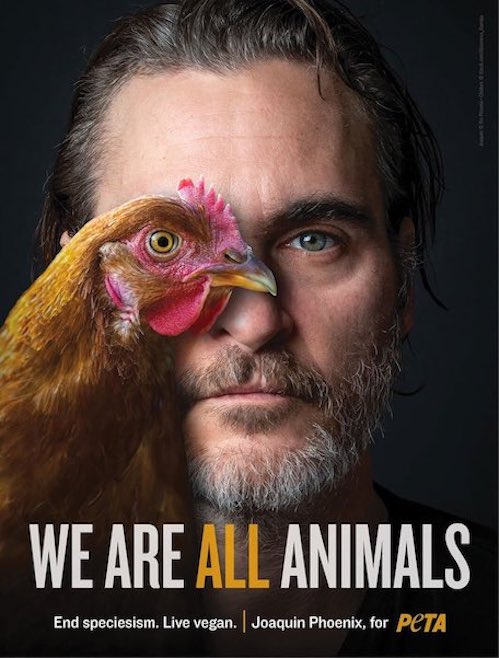
Corpo e anima
(A teströl és a lélekröl)
di Ildikò Enyedi
Ungheria, 2017
Con: Alexandra Borbély (Mária), Morcsányi Géza (Endre), Ervin Nagy (Sanyi)
Orso d’Oro al Festival di Berlino 2017
Trailer del film
L’animalità è la calunnia che l’umano esprime in forme molteplici. L’animalità è la paura di vedere ciò che siamo e sempre rimarremo, al di là delle distopie transumaniste, fondate sul volontarismo della psiche e sulle tecnologie al servizio dell’individualismo liberista. L’animalità è la potenza della materia organica che ci costituisce. L’animalità è il desiderio, il timore, l’amore.
 È la dolorosa e invincibile ricchezza dell’animalità umana che questo film racconta nella forma di una singolare storia d’amore ambientata in un macello di Budapest. Il maturo direttore Endre e la giovane dottoressa Mária – incaricata del controllo di qualità sulle carni – sono entrambi solitari e riservati, pur se in modi diversi. Mária è silenziosa, precisissima sul lavoro e – si scopre a poco a poco – dotata di una memoria formidabile che declina in modi infantili. La distanza di lei da ogni altro collega di lavoro sembra inoltrepassabile sino a quando Endre e Mária scoprono di fare tutte le notti lo stesso sogno, di essere due cervi che in un paesaggio innevato e solitario si incontrano, si annusano, si toccano, insieme corrono. Una scoperta che cambierà a fondo le loro vite.
È la dolorosa e invincibile ricchezza dell’animalità umana che questo film racconta nella forma di una singolare storia d’amore ambientata in un macello di Budapest. Il maturo direttore Endre e la giovane dottoressa Mária – incaricata del controllo di qualità sulle carni – sono entrambi solitari e riservati, pur se in modi diversi. Mária è silenziosa, precisissima sul lavoro e – si scopre a poco a poco – dotata di una memoria formidabile che declina in modi infantili. La distanza di lei da ogni altro collega di lavoro sembra inoltrepassabile sino a quando Endre e Mária scoprono di fare tutte le notti lo stesso sogno, di essere due cervi che in un paesaggio innevato e solitario si incontrano, si annusano, si toccano, insieme corrono. Una scoperta che cambierà a fondo le loro vite.
Gli animali nella solitudine arcaica del loro mondo fatto di betulle, di laghi, di foglie, i cervi. Gli animali nella solitudine tecnologica di un mattatoio che in pochi minuti trasforma delle pulsanti vite in carne per i supermercati, le mucche. Cervi, mucche, umani sono la stessa animalità libera e oppressa, sovrana e schiava, sacra e squartata. Un’animalità fatta di desiderio, clamori, silenzio, morire.
Corpo e anima racconta e descrive tutto questo attraverso la poesia dei particolari, dei riflessi, degli occhi delle mucche e dei cervi, delle scarpe di Mária, degli sguardi umani, delle lampadine al soffitto, del cibo continuamente assunto e toccato. Lo racconta attraverso un eros intenso e delicato. Dal quale emerge la luce della materia, la luce che la materia è: E=mc2. L’animalità è parte di questa energia, materia, luce.





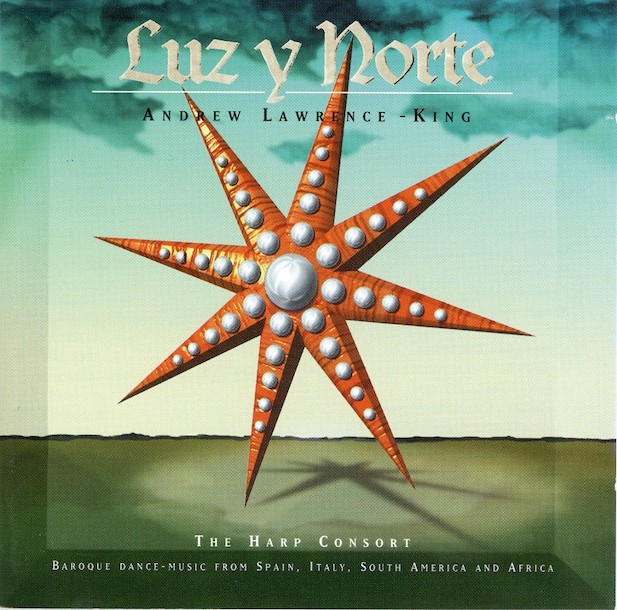

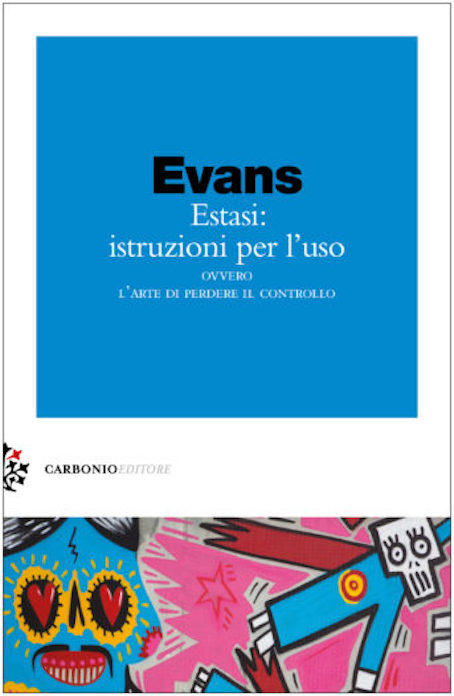

 Si tratta di un dispositivo che agisce nell’opera fondamentale di Canetti,
Si tratta di un dispositivo che agisce nell’opera fondamentale di Canetti,