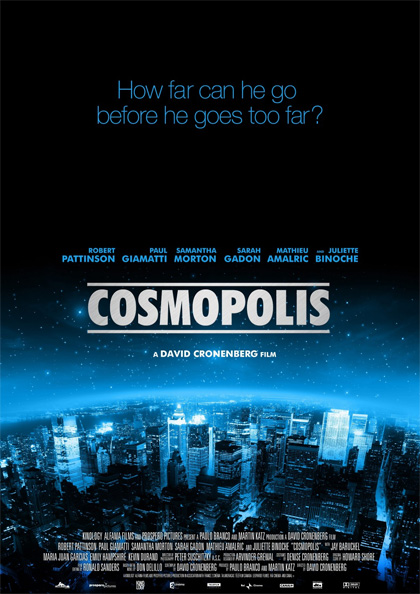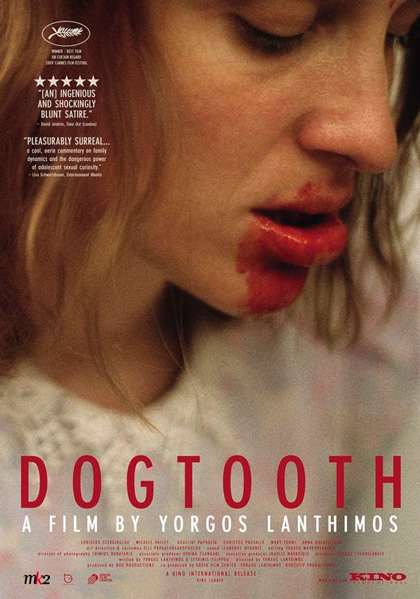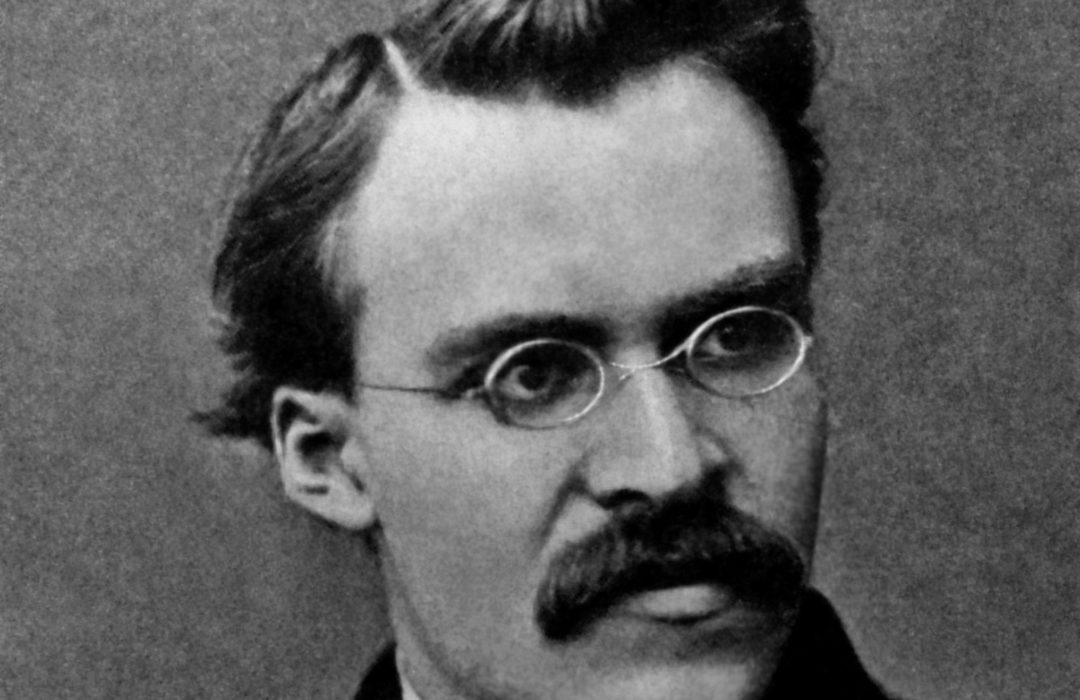Il primo dogma dell’amore è l’esistenza dell’altro, il suo primo errore è credere che tale esistenza sia reale. E invece la realtà è una molteplicità frammentata, sfaccettata, irriducibile allo sguardo, al concetto e all’azione: «Così il breve tragitto delle sue labbra verso la guancia di Albertine crea dieci Albertine, e trasforma un banale essere umano in una dea dalle molte teste» (Beckett, Proust, SE 2004, p. 37), tanto che quando l’avrà perduta il Narratore dice a se stesso che «pour me consoler, ce n’est pas une, c’est d’innombrables Albertine que j’aurais dû oublier» (À la recherche du temps perdu, Gallimard 1999, p. 1693).
Perché accade questo? Che cosa fa dei corpi altrui, posti davanti a noi, aperti al nostro sguardo, pronti alla conversazione, a volte intrecciati nelle mani, nella bocca, negli organi genitali, che cosa li mantiene sideralmente distanti? Non lo spazio, è evidente, ma il tempo. Analizzando la natura temporale dell’amore Proust disvela, come nessun altro artista o filosofo ha mai fatto, la ragione per la quale si tratta di un sentimento tragico.
«Et je comprenais l’impossibilité où se heurte l’amour. Nous nous imaginons qu’il a pour objet un être couché devant nous, enfermé dans un corps. Hélas! Il est l’extension de cet ètre à tous les points de l’espace et du temps que cet être a occupés et occupera. Si nous ne possédons pas son contact avec tel lieu, avec telle heure, nous ne le possédons pas. Or nous ne pouvons toucher tous ces points» (Recherche, p. 1677). E ancora: «Et pourtant, je ne me reandais pas compte qu’il y avait longtemps que j’aurais dû cesser de voir Albertine, car elle était entrée pour moi dans cette période lamentable où un être, disséminé dans l’espace et dans le temps, n’est plus pour nous une femme, mais une suite d’événemets sur lequels nous ne pouvons faire la lumière, une suite de problèmes insolubles, une mer que nous essayons ridiculement, comme Xerxès, de battre pour la punir de ce qu’elle a englouti. Une fois cette période commencée, on est forcément vaincu» (Recherche, p. 1680). E definisce l’amore come «l’espace et le temps rendus sensibles au cœur» (Recherche, p. 1893).
L’altro è una meta irraggiungibile, foriera di angoscia, gettata nell’attesa, intessuta di gelosia, sciolta nell’acido di quei sospetti nei quali immergiamo ogni evento ricordato. Questo è il lavoro della mente amorosa, l’incessante attività di un’ermeneutica della diffidenza che nessuna certezza potrà mai conseguire poiché tale sicurezza ha come condizione l’intero temporale nel quale l’altro distende il proprio corpo negli anni. Il ricordo incessante della persona che amiamo diventa così l’abitudine all’angoscia che la sua inevitabile distanza rappresenta. Abitudine che è una delle figure temporali più potenti e pervasive dell’esistenza umana.
Per Proust la via d’uscita, l’unica, non è etica né psicologica. È la parola. La scrittura ci libera dall’assurdo dei giorni e dei sentimenti assurdi per trasfigurare giorni e sentimenti nella parola che salva: «Comment a-t-on le courage de souhaiter vivre, comment peut-on faire un mouvement pour se préserver de la mort, dans un monde où l’amour n’est provoqué que par le mensonge et consiste seulement dans notre besoin de voir nos souffrances apaisées par l’être qui nous a fait souffrir?» (Recherche, p. 1673).
[A Proust, in particolare alla lettura beckettiana della Recherche, è dedicato uno degli articoli del numero 14 -marzo 2012- di Vita pensata, dove si trovano anche le traduzioni dei brani citati.
A questo tema sarà dedicato il corso di Filosofia della mente del prossimo anno accademico. Argomento specifico e testi in programma saranno resi noti quando il Dipartimento ufficializzerà i corsi dell’a.a. 2012-2013]