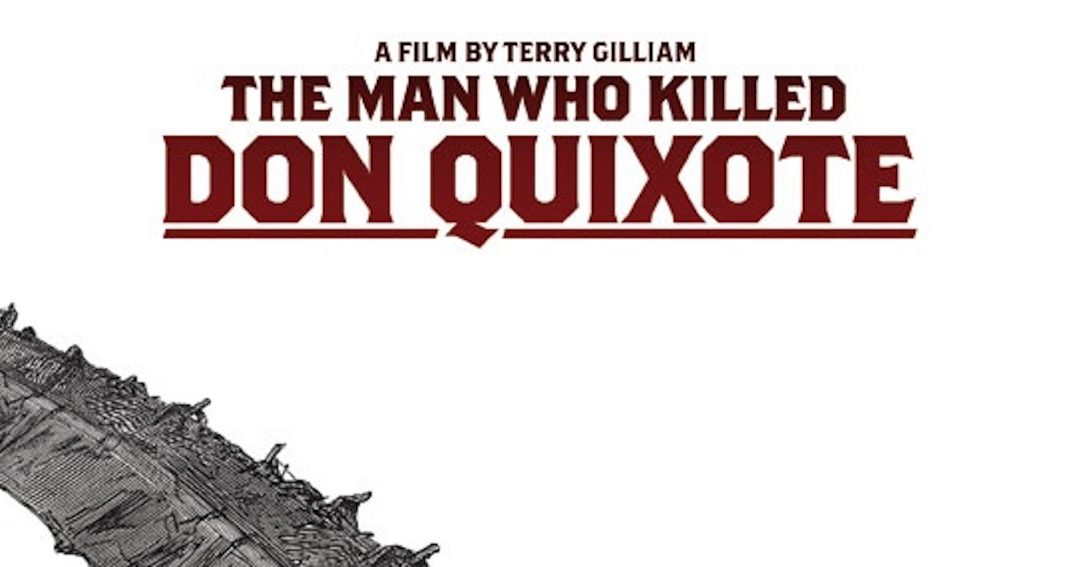«O tenebris tantis tam clarum extollere lumen / qui primus potuisti inlustrans commoda vitae, / te sequor, o Graiae gentis decus». Così Lucrezio si rivolge al suo maestro nell’incipit del terzo libro del De rerum natura (1-3): «O tu, che in mezzo a così grandi tenebre primo potesti / levare una luce tanto chiara, illuminando le gioie della vita, / io seguo te, o onore della gente greca» (trad. di Francesco Giancotti).
Gioia della vita è la libertà, che per Epicuro significa assenza di timori sul presente e sul futuro, significa serenità. Il mondo fisico è per questo filosofo il presupposto scientifico dell’etica. Si tratta di un universo atomistico, quantitativo, in cui il movimento degli atomi nel vuoto costruisce e dissolve mondi. La casualità fisica e la libertà del volere sono le conseguenze della παρέγκλισις e ἔγκλισις -il «clinamen principiorum» di Lucrezio (De rerum natura, Liber II, v. 292)-, la piccola ma decisiva deviazione e spostamento degli atomi nel loro movimento dentro lo spaziotempo.
Gli strumenti metodologici di cui Epicuro si serve per delineare questo universo sono l’inferenza, l’analogia, la spiegazione multipla. Da una esperienza nota, mediante accostamenti e deduzioni, si perviene a formulare varie ipotesi su ciò che non è possibile cogliere empiricamente.
In questo mondo pervaso di razionalità, gli dèi costituiscono una comunità felice, imperturbabile, che non distribuisce premi o castighi e che in nulla deve preoccupare i mortali. Tanto più che la persona umana è composta di due elementi tra di loro inseparabili, è un indissolubile «complesso di ψυχή e σῶμα, dotato di determinati moti» (A Erodoto, §§ 65-66, p. 171, in Opere, a cura di Margherita Isnardi Parente, Utet 1983; le successive citazioni sono tratte da questo volume) e dunque «non bisogna temere le pene degli inferi perché le anime con la morte si dissolvono né vi sono inferi di sorta» (Testimonianze, Lattanzio, Div. inst., III, 17,42; p. 364).
Se così è, neppure il morire può diventare causa d’angoscia. Esso rappresenta infatti il momento di dissoluzione del composto umano, che nasce dalla materia e alla materia è destinato a tornare. Della morte è dunque impossibile fare esperienza «dal momento che, quando noi ci siamo, la morte non c’è, e quando essa sopravviene noi non siamo più» (A Meneceo, § 125, p. 198). E dunque il saggio «del tempo cerca di godere non il più lungo, ma il più dolce» (Ivi, § 126, p. 199).
Avendo compreso come è fatto il mondo e quali forze lo determinano, eliminata la paura degli dèi, della morte e di ciò che la segue, ci si può volgere a un piacere che è frutto di moderazione, libertà dalle passioni, rifiuto di ogni ὕβρις: «La saggezza è sobrietà e ordine nei desideri», come sintetizza Plutarco nel Gryllus (6, 989 b; p. 449). «Quando dunque diciamo che il piacere è un bene, non alludiamo affatto ai piaceri dei dissipati che consistono in crapule, come credono alcuni che ignorano il nostro insegnamento o lo interpretano male; ma alludiamo all’assenza di dolore nel σῶμα, all’assenza di perturbazione nella ψυχή» (A Meneceo, § 131, p. 201).
La serenità è possibile, da essa nasce e a essa mira la filosofia. Serenità, ἀρετή e sapere sono inseparabili; è questo il tratto socratico di Epicuro. E bisogna pertanto, quando è necessario, saper rinunciare, saper capire, essere padroni di se stessi. Per questo «il saggio è sempre felice» (Testimonianze, Cicerone, Tusc. disp., V, 10,31; p. 499).
E dunque la più esatta definizione di Epicuro l’ha forse data Cicerone quando lo definisce non soltanto «inventore veritatis» -scopritore della verità- ma anche «architecto beatae vitae», architetto della vita felice (De finibus, I, 32; p. 413).





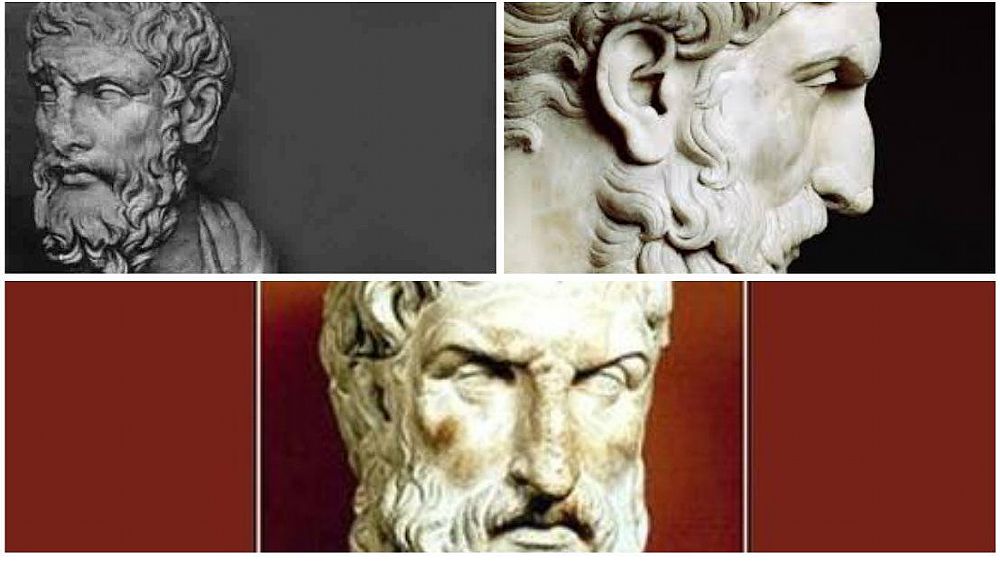

 «Tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andato. E anche lei, tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andata. Ma il rischio per lei era troppo grande. Lo sapeva. Glielo aveva anche detto mentre lo abbracciava: ‘immenso è il tuo orgoglio, lo so. Sei capace di stare senza respiro pur di non dire il bisogno che hai di me. Sei capace di morderti la vita prima che la morte del tuo io ti si pari innanzi nell’umiliazione della supplica. Lo sapevo già, dio della mia vita, dai tuoi racconti di chi non hai più amato dopo essere state per te tutto l’universo. Non le hai più volute neppure leggere negli inutili fogli della loro speranza. Per questo ogni volta che l’impulso mi è nato di lasciarti, ho messo le guardie alla mia follia e ho taciuto’. Così diceva, impaurita sorridente e forte del suo incanto. Ma alla fine era caduta nell’errore che pure conosceva. Ed era stata sintesi di tutto, lei, un riassunto dell’abbandono nel quale avevano tentato di costringerlo e che invece ogni volta e matematicamente si trasfigurava in gloria».
«Tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andato. E anche lei, tante volte dentro di sé e nella realtà che chiamano oggettiva se ne era andata. Ma il rischio per lei era troppo grande. Lo sapeva. Glielo aveva anche detto mentre lo abbracciava: ‘immenso è il tuo orgoglio, lo so. Sei capace di stare senza respiro pur di non dire il bisogno che hai di me. Sei capace di morderti la vita prima che la morte del tuo io ti si pari innanzi nell’umiliazione della supplica. Lo sapevo già, dio della mia vita, dai tuoi racconti di chi non hai più amato dopo essere state per te tutto l’universo. Non le hai più volute neppure leggere negli inutili fogli della loro speranza. Per questo ogni volta che l’impulso mi è nato di lasciarti, ho messo le guardie alla mia follia e ho taciuto’. Così diceva, impaurita sorridente e forte del suo incanto. Ma alla fine era caduta nell’errore che pure conosceva. Ed era stata sintesi di tutto, lei, un riassunto dell’abbandono nel quale avevano tentato di costringerlo e che invece ogni volta e matematicamente si trasfigurava in gloria».