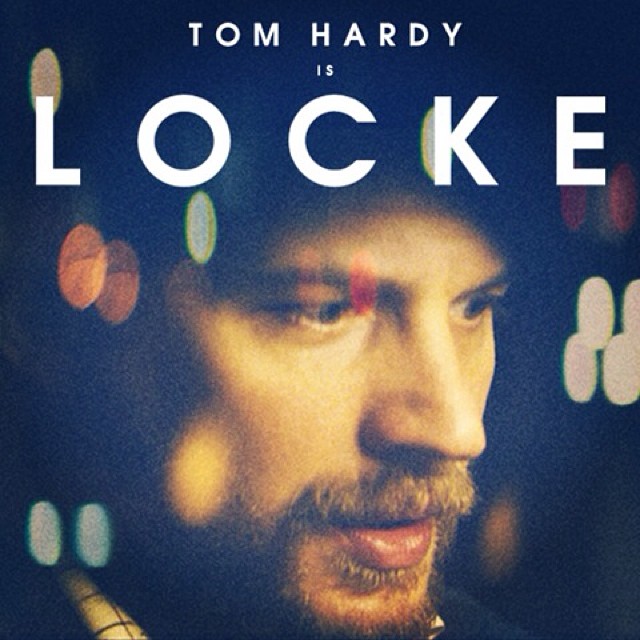Piccolo Teatro Strehler – Milano
Pinocchio
da Carlo Collodi
Drammaturgia di Antonio Latella, Federico Bellini, Linda Dalisio
Con Michele Andrei, Anna Coppola, Stefano Laguni, Christian La Rosa, Fabio Pasquini, Matteo Pennese, Marta Pizzigallo, Massimiliano Speziani
Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Regia di Antonio Latella
Sino al 12 febbraio 2017
«Fare un figlio non vuol dire amarlo. Ora prenditi la tua vita e lasciami in pace una volta per tutte, burattino».
«Non chiamarmi più così, non farlo mai più. Hai capito, porco di un padre? Come hai solo potuto pensare di mettermi al mondo? Cosa hai voluto dimostrare? Che eri un uomo vero vero?».
Così si avvia a conclusione la storia di Pinocchio, che Latella mette in scena come un sogno malato, una tragedia elisabettiana, una discesa là dove «si va, si va…». Il balbettio del burattino giunge infine all’atteso compimento implicito in queste sillabe. Nascendo infatti «si va nella città dolente / nell’etterno dolore / tra la perduta gente». Al pescatore che gli ricorda questo destino, il bambino Pinocchio risponde -inconsapevole, superficiale, sciocco- «Bello. Allora vado».
E va va, continuando a correre da quando prese forma in quel pezzo di legno che si porta sempre addosso, in quel pezzo di legno che rimane. Corre verso il fuori della casa fredda e affamata. Corre verso la scuola con il suo enorme abbecedario. Corre verso il carcere e la truffa. Corre verso il Paese dei barbagianni, dei citrulli, dei balocchi. Fedele a ciò che da sempre è -un pezzo di legno nelle mani della Necessità-, l’umano Pinocchio mostra il destino che attende lo zigote diventato burattino, bambino, adulto, mortalis.
Il corpo di Pinocchio permea la scena; la sua voce scardillina (sicilianismo per acuta) si fa eco delle voci adulte che lo inseguono; il suo correre e il suo andare somigliano a quelli di Sisifo.
L’idea è dunque molto profonda ma il limite di questo spettacolo sta nel caricare il testo di numerosi materiali linguistici e cerebrali, che stemperano il calore della tragedia nel gelo di un progetto troppo consapevole. Il limite sta soprattutto in un eccesso di psicoanalisi che spalma sulla densità del mito la superficialità della psicologia (uccidiamo infine questo padre, questo mosè, questo freud e la sua teoria; liberiamoci una buona volta da questa fissazione del profondo).
In ogni caso, un Pinocchio nero, un Pinocchio tragico.