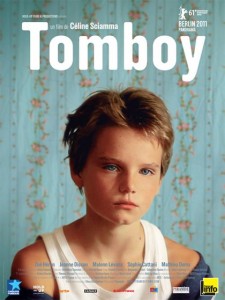Sodoma e Gomorra
di Marcel Proust
(Sodome et Gomorrhe, 1921-22)
Trad. di Elena Giolitti
Einaudi, 1978 (1949)
Pagine XVII – 631
 Dalla lucida descrizione della “stirpe” di Sodoma e Gomorra alla sofferenza di vederne discendere Albertine, si compie la fase di vita del Narratore prima della drammatica rivelazione che muterà la sua esistenza. Dentro questo tempo la mondanità si rivela sempre più superficiale e insulsa decadendo, tra l’altro, dai Guermantes di Parigi alla «setta» dei Verdurin alla Raspelière.
Dalla lucida descrizione della “stirpe” di Sodoma e Gomorra alla sofferenza di vederne discendere Albertine, si compie la fase di vita del Narratore prima della drammatica rivelazione che muterà la sua esistenza. Dentro questo tempo la mondanità si rivela sempre più superficiale e insulsa decadendo, tra l’altro, dai Guermantes di Parigi alla «setta» dei Verdurin alla Raspelière.
Se la protagonista dei timori del Narratore è Albertine, dall’altro lato della stirpe maledetta trionfa nel suo fascino complesso e profondo la figura del Barone di Charlus, il capolavoro di Proust, una scultura fatta di intelligenza e di lussuria, di smisurato orgoglio e di affettuosa umiltà, di malvagità e di cortesia.
Il Desiderio mostra come l’Altro sia sempre un essere di fuga, poiché il destino di chi ama è «quello d’inseguire solo fantasmi, esseri la cui realtà per buona parte dimorava nella mia fantasia; vi sono infatti esseri [che] rinunciano a tutto il resto, mettono tutto in opera, si servono d’ogni cosa per incontrare un fantasma»1, desiderio che è parte e forma della potenza stessa della Natura, dell’energia eternamente ritornante del «querulo avo della terra», il mare, «che proseguiva ancora, come nel tempo in cui non esistevano esseri viventi, il suo demente e immemore tumulto»2 (pag. 439).
Il quarto volume della Recherche si chiude con il presentimento tragico e fatale di inaudite sofferenze future ma anche con la percezione di una nuova vita, che sarà dedicata all’Adoration perpétuelle, al Tempo. Il giorno in cui ha scoperto l’omosessualità e quindi la distanza della sua donna, precipitato nel gorgo della peggiore forma di gelosia, quella retrospettiva, il Narratore scrive:
Com’è ingannevole il senso della vista! Un corpo umano, anche amato, com’era quello di Albertine, ci sembra, a pochi metri, a pochi centimetri di distanza, lontano da noi. Ed egualmente l’anima che gli appartiene […]. Mai non avevo veduto cominciare una mattina così bella, né così dolorosa. Pensando a tutti i paesaggi indifferenti che si sarebbero illuminati tra poco, e che il giorno prima ancora non mi avrebbero colmato che del desiderio di visitarli, non potei trattenere un singhiozzo quando, in un gesto d’offertorio meccanicamente compiuto e che mi parve simboleggiare il sacrificio sanguinante ch’io stesso stavo per fare d’ogni gioia, ogni mattina, fino al termine della mia vita, rinnovellamento celebrato solennemente ad ogni aurora del mio dolore quotidiano e del sangue della mia piaga, l’uovo d’oro del sole, come propulsato dalla rottura d’equilibrio determinata al momento della coagulazione da un cambiamento di densità, dentato di fiamme come nei quadri, squarciò d’un balzo la cortina dietro la quale lo si sentiva, da un minuto, fremente e pronto ad entrare in scena e a slanciarsi avanti, e di cui si dissolse sotto fiotti di luce la porpora misteriosa e rappresa.3 (561-562)
È qui, nel nucleo geometrico dell’opera, che Proust disvela in modo impareggiabile ed esatto l’essenza dell’amore, la struttura del desiderio, la natura sacra e ironica delle passioni, l’illusione suprema che ci spinge verso l’Altro:
Del resto, le amanti che più ho amate non hanno mai coinciso con il mio amore per loro. […] Quando le vedevo, quando le udivo, non trovavo nulla in loro che somigliasse al mio amore e potesse spiegarlo. Eppure, la mia sola gioia era di vederle, la mia sola ansia di aspettarle. […] Sono incline a credere che in questi amori (lascio in disparte il piacere fisico che d’altronde s’unisce abitualmente a essi ma non basta a costituirli), sotto l’apparenza della donna, ci rivolgiamo in realtà alle forze invisibili accessoriamente unite a lei, come a oscure divinità. È la loro benevolenza a esserci necessaria, è il loro contatto quello che cerchiamo, senza trovarvi nessun piacere vero. 4 (560-561)
In ogni caso l’amore è «un sentimento che (qualunque ne sia la causa) è sempre erroneo».5 (214)
Note
1.«de ne poursuivre que des fantômes, des êtres dont la réalité pour une bonne part était dans mon imagination»» (À la recherche du temps perdu, Gallimard, Paris 1999, p. 1517)
2. «plaintive aïeule de la terre, poursuivante comme au temps qu’il n’existait pas encore d’êtres vivants sa démente et immémoriale agitation» (Ivi)
3. «Comme la vue est un sense trompeur! Un corps humain, même aimé comme était celui d’Albertine, nous semble à quelques mètres, à quelques centimètres distant de nous. Et l’âme qui est à lui de même. […] Je n’avais jamais vu commencer une matinée si belle ni si douloureuse. En pensant à tous les paysages indifférents qui allaient s’illuminer et qui la veille encore ne m’eussent rempli que du désir de les visiter, je ne pus retenir un sanglot quand, dans un geste d’offertoire mécaniquement accompli et qui me parut symboliser le sanglant sacrifice que j’allais avoir à faire de toute joie, chaque matin, jusqu’à la fin de ma vie, renouvellement solennellemente célébré à chaque aurore de mon chagrin quotidien et du sang de ma plaie, l’œuf d’or du soleil, comme propulsé par la rupture d’équilibre qu’amènerait au moment de la coagulation un changement de densité, barbelé de flammes comme dans le tableaux, creva d’un bond le rideau derrière lequel on le sentait depuis un moment frémissant et prêt à entrer en scène et à s’elancer, et dont il effaça sous des flots de lumière la pourpre mystérieuse er figée» (1602-1603)
4. «J’incline même à croire que dans ces amours (je mets de côté le plaisir physique qui les accompagne d’ailleurs habituellement, mais ne suffit pas à les constituer), sous l’apparence de la femme, c’est à ces forces invisible dont elle est accessoirement accompagnée que nous nous adressons comme à d’obscures divinités. C’est elles dont la bienveillance nous est nécessaire, dont nous recherchons le contact sans y trouver de plaisir positif» (1602)
5. «L’amour, sentiment qui (quelle qu’en soit la cause) est toujours erroné» (1358)