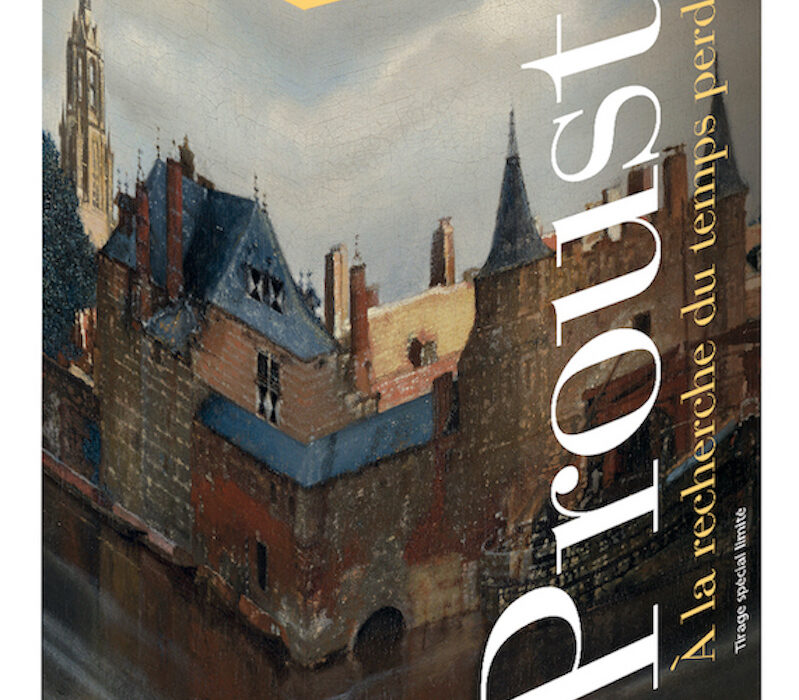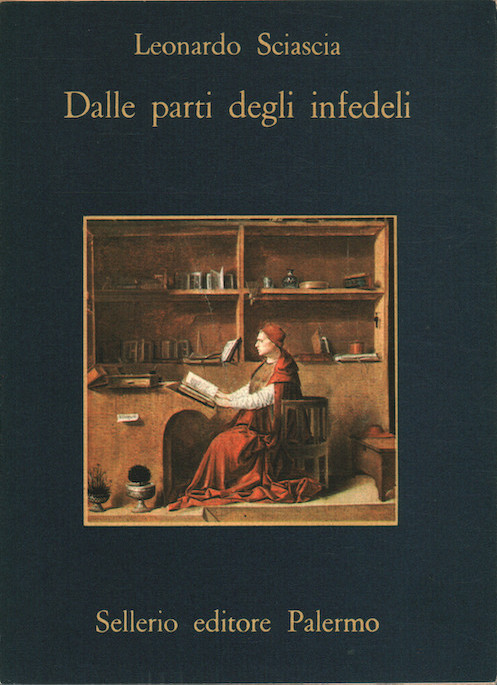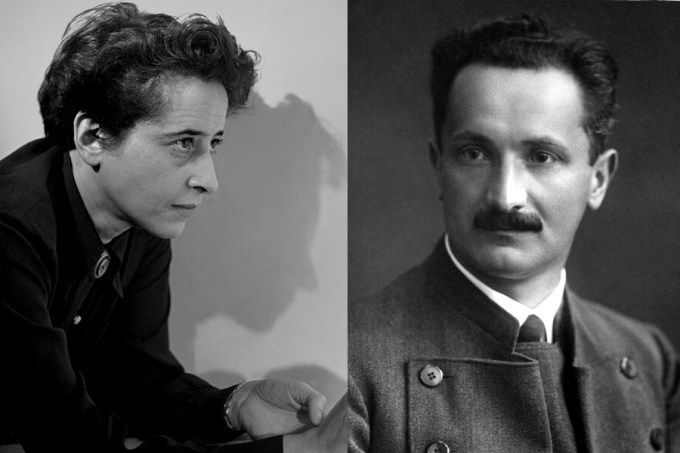Libero Elio Romano 1909-1996
Palazzo della Cultura – Catania
A cura di Vittorio Ugo Vicari ed Enrico La Rosa
Sino al 20 gennaio 2023
Elio Romano ha attraversato il Novecento di una Sicilia sempre uguale e di un’Italia inquieta. È stato amico di altri artisti; ha ospitato pittori e amici nella sua casa museo di Morra, vicino ad Assoro nell’ennese; ha ricevuto committenze da istituzioni pubbliche e private, creando affreschi al modo dei rinascimentali. Ha plasmato le tele, la carta, il gesso, il bronzo. I suoi quadri, e i filmati che ne testimoniano il divenire, mostrano un uomo che sembra aver avuto la fortuna di fare ciò che ha voluto di sé e del proprio talento.
Le 57 opere raccolte a Catania costituiscono anche un’antologia del fare pittorico nel Novecento: impressionismo, fauves, espressionismo, macchiaioli, persino qualcosa del realismo magico. I soggetti sono soprattutto la campagna riarsa, antica, cupa e luminosa del latifondo siciliano; nudi dipinti come da distanze; ritratti assai intensi realizzati con la tecnica della china su carta – forse le cose sue migliori – e su tutto la solitudine di una terra enigmatica, al di là del tempo, dentro ogni tempo.

L’impressione è però di un epigono, di un artista che ha scelto volutamente di isolarsi in luoghi splendidi ma che sociologicamente costituiscono periferia dell’arte contemporanea. A chi gli chiedeva che cosa ci facesse a Morra, Romano rispondeva «coltivo il giardino». Una citazione dal Candide di Voltaire, certo, ma il rischio di una scelta come questa è indicato da alcuni versi di Vittorio Sereni: «…Pensare / cosa può essere –voi che fate / lamenti dal cuore delle città / sulle città senza cuore- / cosa può essere un uomo in un paese, / sotto il pennino dello scriba una pagina frusciante / e dopo / dentro una polvere di archivi / nulla nessuno in nessun luogo mai» (Gli strumenti umani, Einaudi 1980, p. 67).
L’arte, la filosofia, la vita non sono un’acquisizione soltanto individuale e intima ma costituiscono sempre un riflesso e un’espressione del tempo e dello spazio dai quali germinano. Per questo bisogna sempre abitare la distanza ma saper rendere anche quella distanza il centro del mondo.