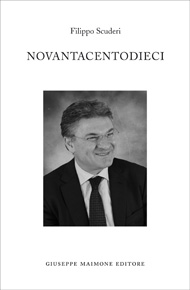Novantacentodieci
di Filippo Scuderi
Giuseppe Maimone Editore, 2013
Pagine 74
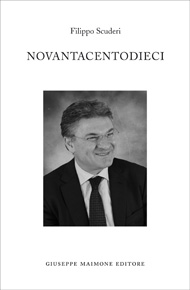 «E da qui di nuovo scuro nella mia modesta vita» (pag. 16). Così definisce la propria vita il Narratore, aggiungendo sempre “modesta” al sostantivo. Modesta come il voto di laurea che dà il titolo al libro, obiettivo raggiunto con tenacia al culmine di una dura esistenza. Un flusso di coscienza quasi ininterrotto -scandito da molte virgole e da pochi punti- ripete ancora una volta le figure archetipiche simili a quelle che abitano i romanzi di Elsa Morante: la Madre amata, morta quando il protagonista ha soltanto due anni; il Padre che si risposa con la Matrigna alcolizzata, pazza e gelosissima, perché «lei lo sapeva come era fatto mio padre in fatto di gonne, se c’era da alzarne una non perdeva tempo, ma la cosa che mordeva la sua coscienza era la conoscenza e la consapevolezza che quando la mia povera mamma si trovava in ospedale a combattere tra la vita e la morte, mio padre se la spassava con lei» (63-64); i Nonni, casalinga e pescatore, affettuosi, rigorosi e determinati, che lo educano alla complessità del mondo. Una costellazione familiare e antropologica con la quale il Narratore si sente una cosa sola e che tuttavia è da lui distante per quel barlume di conoscenza che sempre lo accompagna, per quella «curiosità di approfondire, e di cercare di sapere il più possibile» (51) che fa di questo personaggio un Odisseo candido e proletario.
«E da qui di nuovo scuro nella mia modesta vita» (pag. 16). Così definisce la propria vita il Narratore, aggiungendo sempre “modesta” al sostantivo. Modesta come il voto di laurea che dà il titolo al libro, obiettivo raggiunto con tenacia al culmine di una dura esistenza. Un flusso di coscienza quasi ininterrotto -scandito da molte virgole e da pochi punti- ripete ancora una volta le figure archetipiche simili a quelle che abitano i romanzi di Elsa Morante: la Madre amata, morta quando il protagonista ha soltanto due anni; il Padre che si risposa con la Matrigna alcolizzata, pazza e gelosissima, perché «lei lo sapeva come era fatto mio padre in fatto di gonne, se c’era da alzarne una non perdeva tempo, ma la cosa che mordeva la sua coscienza era la conoscenza e la consapevolezza che quando la mia povera mamma si trovava in ospedale a combattere tra la vita e la morte, mio padre se la spassava con lei» (63-64); i Nonni, casalinga e pescatore, affettuosi, rigorosi e determinati, che lo educano alla complessità del mondo. Una costellazione familiare e antropologica con la quale il Narratore si sente una cosa sola e che tuttavia è da lui distante per quel barlume di conoscenza che sempre lo accompagna, per quella «curiosità di approfondire, e di cercare di sapere il più possibile» (51) che fa di questo personaggio un Odisseo candido e proletario.
«Mentre io ho letto più di trecento libri a casa mia non leggeva nessuno, nemmeno le bollette del telefono» (70). Un umorismo spesso surreale intride le pagine del romanzo: la professoressa di italiano che non porta a termine la lettura dell’Alchimista di Coelho e per questo viene deplorata poiché «nemmeno una professoressa di chimica (senza offesa) si comporterebbe così» (49); un’estate trascorsa «in una colonia estiva, una specie di collegio per gli sfigati» (51); la scoperta di botto e in una sola volta di una miriade di fratelli e sorelle, frutto dell’incessante attività copulatoria del padre; il rimprovero al figlio e agli adolescenti di essere tutti uguali, tanto da dire alla moglie «se ne portiamo un altro a casa alla fine è uguale» (22). L’ironia, spesso involontaria, si coniuga con una dolente comprensione della vita che «non la si gioca contro un avversario ma contro se stessi» (58). La scoperta, da adulto, della filosofia.
E tutto ciò in un linguaggio che è la vera sorpresa di questo romanzo: una lingua plebea e spesso sgrammaticata ma sempre lucida nel descrivere il mondo. Il Narratore sa benissimo che l’italiano è per lui «una seconda lingua […] una lingua difficile con una grammatica veramente tosta» (49) ma una lingua che questo flusso di parole sa piegare, tra anacoluti ed eccessiva creatività nella punteggiatura, a dipingere il dolore e l’insensatezza del mondo. È come se il Rabito di Terramatta fosse riuscito a prendere lui la laurea e non i suoi figli. Dire dello zio che «quando arrivava lui, per noi era festa, perché portava un’entrata di felicità» (27) significa aver trovato un modo luccicante per comunicare l’istante della gioia.
Le ultime pagine sono dedicate alla scoperta di un’amicizia profonda e al lutto per il padre. L’amicizia con Black, il cane che -dopo aver per caso incrociato da lontano gli occhi di Filippo- lo sceglie come suo padrone e al quale viene dato quel nome «per dimenticare i momenti neri che ha avuto tutti i giorni che è stato per strada da solo» (69). Anche il protagonista è stato per lungo tempo e tante volte lasciato per strada da solo. Lasciato da quel padre, odiato e amato, al quale è rivolta l’ultima relazione umana del testo, una lettera in cui, ormai adulto e consapevole, Filippo riconosce che «siamo stati gettati in questo universo, viviamo da spettatori o da protagonisti l’importante è vivere intensamente il tempo che passiamo, perché il tempo siamo noi» (68).