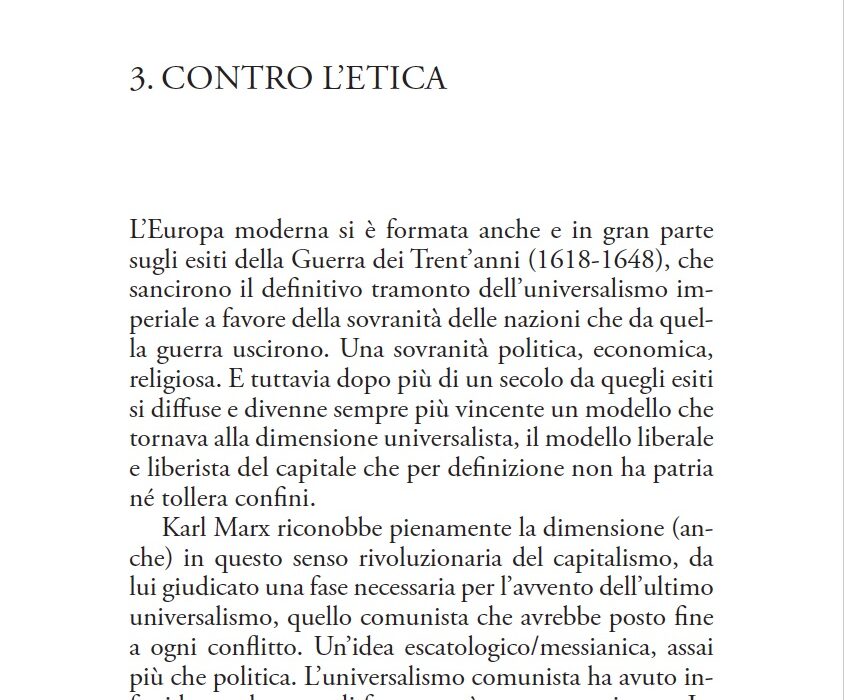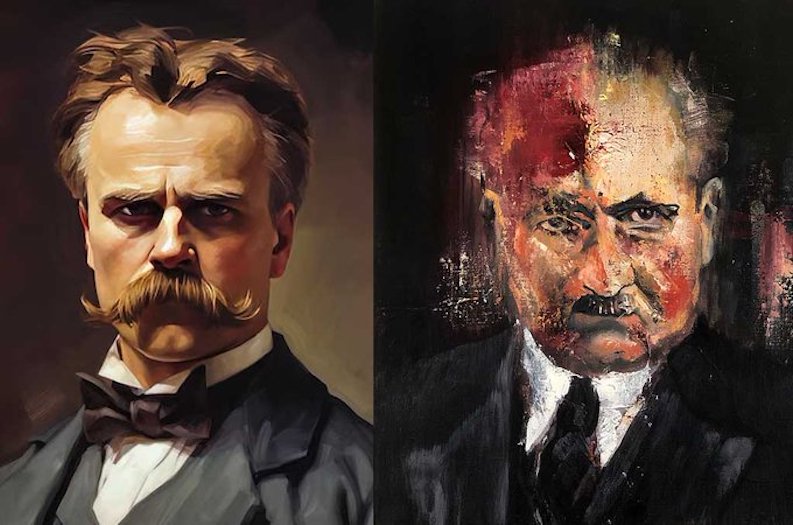Lunedì 3 marzo avranno inizio le lezioni dei tre corsi che terrò nel 2025 nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania.
Riassumo qui gli argomenti dei corsi, l’articolazione dei programmi, i libri e i saggi che analizzeremo, gli orari delle lezioni.
I link ai titoli rinviano a presentazioni o a recensioni e – in alcuni casi – al pdf del testo.
Il link al titolo di ogni corso apre la pagina Disum con le schede didattiche, vale a dire le informazioni relative alle modalità di svolgimento delle lezioni, ai prerequisiti richiesti (da prendere molto sul serio), alla scansione del programma, agli esami.
Consiglio a tutti gli studenti di iscriversi alla piattaforma Studium relativa all’insegnamento che frequentano; è da tale piattaforma infatti che invierò di volta in volta gli avvisi concernenti le lezioni e altro.
Chiedo di porre particolare attenzione ad alcuni elementi delle schede didattiche:
-le lezioni saranno svolte in modalità frontale, vale a dire con un dialogo in presenza nell’aula, con la possibilità di interagire anche tramite elementi non verbali, poiché non sono soltanto i cervelli a insegnare e ad apprendere ma è l’intero corpomente che vive in uno spaziotempo reale, non virtuale;
-il metodo è la lectio, che significa lettura, analisi, commento e discussione dei testi;
-a motivo dei due primi elementi, corpimente e lectio, pur non essendo obbligatoria, la frequenza alle lezioni è fortemente consigliata;
-prerequisito di tutti e tre i corsi (in particolare di quelli magistrali) è una conoscenza adeguata della storia della filosofia.
Riassumo anche gli obiettivi principali che i corsi si propongono di conseguire.
Per Filosofia teoretica (corso avanzato) e Metafisica:
1) Conoscenza e comprensione delle principali questioni ontologiche e metafisiche
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione all’esistenza individuale e collettiva
3) Autonomia di giudizio in ogni ambito della conoscenza e del vivere
4) Abilità comunicative nel presentare razionalmente le proprie posizioni
5) Capacità di apprendimento in ogni sfera del sapere.
Per Filosofia delle menti artificiali:
1) Conoscenza e comprensione dello statuto dell’intelligenza
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione al rapporto con gli artefatti digitali
3) Autonomia di giudizio rispetto alle informazioni ricevute in questo ambito dai media più diffusi
4) Abilità comunicative nell’utilizzo dei dispositivi digitali
5) Capacità di apprendimento da una varietà di fonti e strumenti.
___________________________________________________
Filosofia teoretica (corso avanzato)
ZARATHUSTRA
Corso magistrale in Scienze Filosofiche
lunedì 12-14 (aula A9) / mercoledì 10-12 (aula A9) / venerdì 10-12 (aula 252)
Il corso intende aprire a una comprensione quanto più rigorosa possibile del pensiero di Friedrich Nietzsche per il tramite, in particolare, di Così parlò Zarathustra, letto anche mediante la chiave ermeneutica proposta da Heidegger nelle lezioni e nelle conferenze da lui dedicate a questo filosofo.
- Alberto G. Biuso, Nomadismo e benedizione. Ciò che bisogna sapere prima di leggere Nietzsche, Di Girolamo 2006, pp. 200
- Martin Heidegger, Chi è lo Zarathustra di Nietzsche? [1953], in «Saggi e discorsi», Mursia 1976, pp. 66-82 (PDF)
- Friedrich W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi 1976, pp. XVII-425
___________________________________________________
Metafisica
METAFISICHE
Corso triennale in Filosofia
lunedì 10-12 (aula A12) / martedì 12-14 (aula A12)
Il corso intende introdurre i concetti fondamentali della metafisica, la loro storia e la loro presenza nella filosofia contemporanea.
- Alberto G. Biuso, Sul realismo, in «L’invenzione della realtà. Scienza, mito e immaginario nel dialogo tra psiche e mondo oggettivo», ETS 2022, pp. 125-135 (PDF)
- Enrico Berti, Introduzione alla metafisica, II edizione, Utet 2017, pp. XI-200
- Martin Heidegger. Che cos’è metafisica?; Poscritto a «Che cos’è metafisica?»; Introduzione a «Che cos’è metafisica?», in «Segnavia», Adelphi 1987, pp. 59-77; 257-266; 317-334
- Alberto G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica, Olschki 2020, pp. 168
___________________________________________________
Filosofia delle menti artificiali
SUL VIRTUALE
Corso magistrale in Scienze Filosofiche
martedì 14-16 (aula A12) / mercoledì 12-14 (aula 30)
Dopo una introduzione generale alle tematiche dell’Intelligenza Artificiale, il corso affronterà la questione del virtuale, con una specifica attenzione critica al tema della presenza dei corpimente nello spaziotempo.
- Renato Betti, Intelligenza Artificiale in «Enciclopedia Einaudi», vol. 7, Einaudi 1979, pp. 828-862 (PDF)
- Eugenio Mazzarella, Contro Metaverso. Salvare la presenza, Mimesis 2022, pp. 142
- Stefano Isola, A fin di bene: il nuovo potere della ragione artificiale, Asterios Editore, 2023, pp. 157
- Alberto G. Biuso, Presenza e realtà. Sul virtuale, Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio-agosto 2023, pp. 27-33 (PDF); Mutamenti politici e Intelligenza Artificiale, Dialoghi Mediterranei, n. 66, marzo-aprile 2024, pp. 30-36 (PDF)