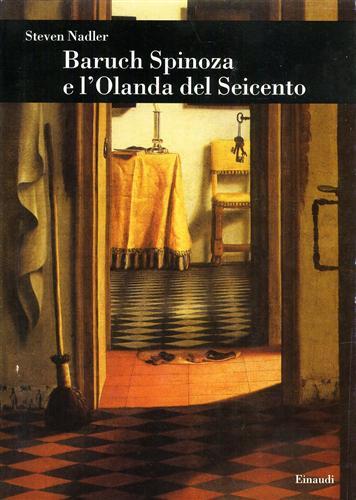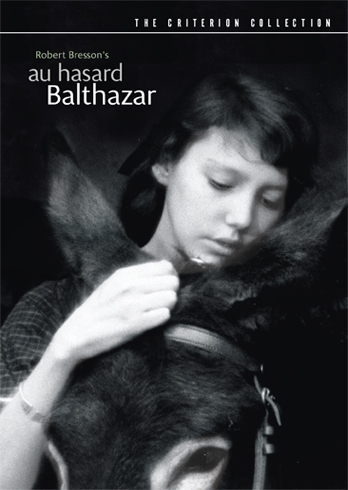Il giovane favoloso
di Mario Martone
Italia, 2014
Con Elio Germano (Giacomo), Michele Riondino (Antonio Ranieri), Massimo Popolizio (Monaldo), Valerio Binasco (Pietro Giordani), Paolo Graziosi (Carlo Antici), Sandro Lombardi (precettore di casa Leopardi), Isabella Ragonese (Paolina Leopardi), Anna Mouglalis (Fanny Targioni Tozzetti), Federica De Cola (Paolina Ranieri)
Trailer del film
Il problema sono le biografie. Le quali possono essere a volte utili alla comprensione ma che nel caso di artisti, filosofi, scienziati costituiscono per lo più un equivoco. L’equivoco della dipendenza dell’opera dal fattore biografico. È evidente che le esistenze di tutti gli esseri umani -compresi coloro che hanno lasciato qualcosa di duraturo, di fecondo, di bello nel tempo- sono segnate anche da contraddizioni e da miserie. Poiché sono segnate dal limite. Il problema è la riduzione dell’opera a tale limite. Il film di Martone cade in questo errore. E dire che ne è consapevole. Uno dei momenti chiave del film è infatti l’incontro di Leopardi con dei letterati in un caffè di Napoli. Alcuni di costoro criticano il tono eccessivamente «malinconico» delle sue composizioni. Qualcuno cerca di difenderlo ricordando i problemi di salute del poeta e facendo dipendere da questo elemento tale tono. Leopardi risponde con determinazione che questo non c’entra nulla, che -se riescono- debbono smontare i suoi ragionamenti e non le sue malattie, che non debbono ridurre a una questione di salute o di umore ciò che è frutto «del mio intelletto». Esatto. Ma il film naviga in direzione opposta. E lo fa anche esagerando, inserendo scene -come l’incontro con le prostitute- del tutto superflue e tendenti solo a titillare l’inevitabile voyeurismo di ogni biografia.
Giacomo Leopardi non c’entra nulla con tutto questo. Leopardi è uno dei più importanti filosofi europei dell’Ottocento. Un pensatore che come Kierkegaard, Schopenhauer, Heidegger, Cioran sa che l’esistere umano è un oscillare tra il dolore e la noia, il cui ultimo esito è l’essere per la morte. «Pare che l’essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono» (Cantico del gallo silvestre, in «Operette morali», Garzanti 1982, p. 287). La metafisica di Leopardi è radicalmente materialistica. Egli vede nel mondo un continuo aggregarsi e sciogliersi di enti, in cui ciò che rimane costante è solo la quantità di energia e di sostanza. Nel Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco leggiamo che «le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero incominciamento. Ma la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che ella è per sua propria forza ab eterno» (p. 294).
La logica conseguenza è il lucido e costante rifiuto di ogni antropocentrismo. L’infantile pretesa che il mondo sia stato fatto a esclusivo uso di una specie, che il volgere delle galassie e della materia sia finalizzato al progresso della vicenda umana, la dismisura antropocentrica -insomma- è deprecata da Leopardi con giusta ironia e a volte con ferocia. Prometeo riconosce di aver perduto la sua scommessa, di aver fatto un errore nell’esaltare le capacità dell’animale uomo, dato che il genere umano è sì sommo ma «nell’imperfezione» (La scommessa di Prometeo, p. 112). Nella chiusa del Dialogo di un folletto e di uno gnomo quest’ultimo splendidamente osserva che dopo la scomparsa degli umani «le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie» (p. 69). Leopardi si inserisce, così, in quella linea della filosofia europea che da Spinoza a Heidegger sottolinea la finitudine dell’ente uomo, il suo essere effimero in un mondo che si muove e vive in assoluta indipendenza rispetto alle sue componenti. La Natura risponde, gelida, all’Islandese che «se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvederei» (Dialogo della natura e di un Islandese, p. 155). Questa antica e sempre argomentata concezione teoretica si riduce nel film di Martone alla Natura che assume il volto della madre di Leopardi. Banale psicoanalisi, insomma.
Il primo a respingere con decisione il riduzionismo biografico è stato naturalmente lo stesso scrittore, il quale fu perfettamente consapevole della propria strategia ermeneutica e dei suoi fini e rifiutò con grande lucidità la tesi che voleva fare delle sue opere la mera conseguenza dei suoi malanni: «E sentendo poi…dire che la vita non è infelice, e che se a me pareva tale, doveva essere effetto d’infermità, o d’altra miseria mia particolare, da prima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso…poi tornato in me stesso, mi sdegnai un poco; poi risi» (Lettera a De Sinner, 24.5.1832). A chi gli vorrebbe negare la qualità teoretica e l’oggettività dell’analisi, Leopardi così risponde: «Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so: so che malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera» (Dialogo di Tristano e di un amico, in «Operette morali», p. 377).
Una filosofia dolorosa, ma vera. Leopardi non fu un uomo che soffriva, fu un corpomente che pensava. Ha quindi ragione Jaspers quando afferma che «un’opera deve essere valutata esclusivamente sulla base del suo contenuto spirituale: la causalità sotto il cui influsso qualcosa è creato, non dice nulla sul valore della creazione stessa» (Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo filosofare, Mursia 1996, p. 104).
In questo film sono certamente suggestive la forma, il taglio delle inquadrature, la luce. Suggestivo e ben trovato è soprattutto il titolo. E però di questo «giovane favoloso» non si comprende in che cosa consista la meraviglia, lo splendore, la favola. La vicenda si conclude con la lettura di alcuni versi della Ginestra da parte di Leopardi di fronte allo «Sterminator Vesevo». Una lettura che però si interrompe insensatamente prima dei versi finali, che avrebbero potuto esprimere meglio l’ironia e l’antiumanesimo del pensiero leopardiano: «Ma più saggia, ma tanto / Meno inferma dell’uom quanto le frali / Tue stirpi non credesti / O dal fato o da te fatte immortali» (vv. 314-317).
 Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale è il titolo del grande libro che Erich Auerbach dedicò a questo tema. E tuttavia il sottotitolo della prima edizione era Eine Geschichte des abendländischen Realismus, als Ausdruck der Wandlungen der Selbstanschauung der Menschen, vale a dire una storia del realismo occidentale come espressione delle trasformazioni dell’autorappresentazione umana. Neppure per Auerbach, insomma, il realismo è separabile dal modo in cui la mente individuale e collettiva percepisce di volta in volta il mondo.
Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale è il titolo del grande libro che Erich Auerbach dedicò a questo tema. E tuttavia il sottotitolo della prima edizione era Eine Geschichte des abendländischen Realismus, als Ausdruck der Wandlungen der Selbstanschauung der Menschen, vale a dire una storia del realismo occidentale come espressione delle trasformazioni dell’autorappresentazione umana. Neppure per Auerbach, insomma, il realismo è separabile dal modo in cui la mente individuale e collettiva percepisce di volta in volta il mondo.