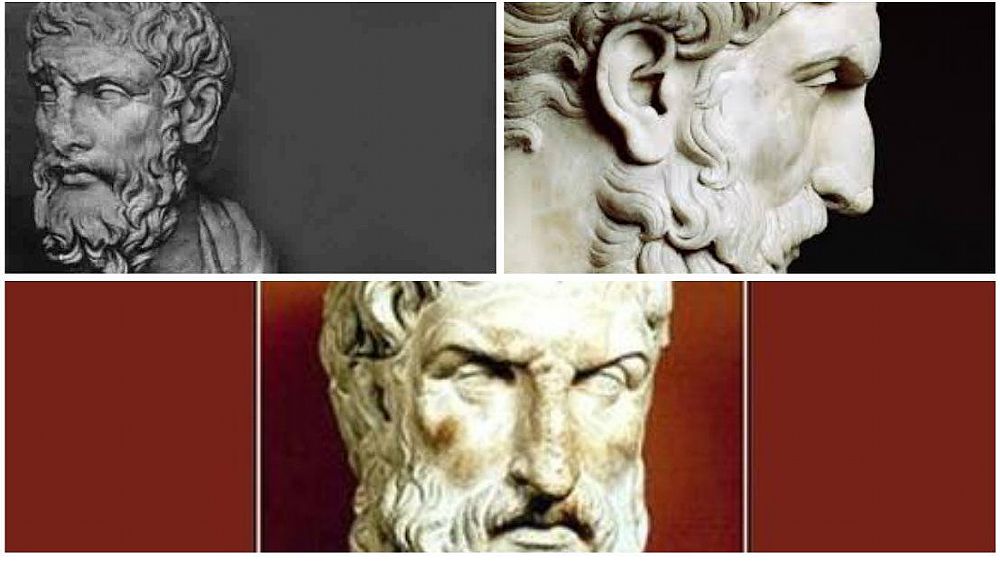Il morire determina ogni vita. Per gli umani esso si struttura non soltanto come destino inevitabile nel che e indeterminato nel quando ma anche come tessuto simbolico dal quale germinano le religioni, gorgoglia l’angoscia, si quieta ogni psiche. Anche questo vuol dire il Coro delle Supplici: «Nel mondo degli uomini non c’è nulla che sia felice fino al termine»1. La morte è così importante per la nostra specie da riservare ai defunti -e cioè a delle entità nelle quali è dissolta la persona- onori analoghi se non superiori a quelli dedicati ai viventi.
La sensibilità verso i morti è pervasiva delle civiltà antiche e ha in questa tragedia una testimonianza assai evidente. Le madri degli eroi argivi morti a Tebe, combattendo a favore di Polinice contro suo fratello Eteocle, implorano Teseo, signore di Atene, di aiutarle a recuperare i cadaveri che il re di Tebe, Creonte, ha deciso rimangano all’aria e alle fiere. Teseo tuttavia rimprovera Adrasto di aver mosso troppo facilmente e imprudentemente guerra a Tebe. Come dichiara un araldo, «la speranza è una gran brutta cosa pei mortali: spinge l’ira agli eccessi, e spesso induce a guerra le città» (229). Il vecchio re di Argo riconosce la propria follia ed è rassegnato al rifiuto. Interviene però a favore delle supplici la madre di Teseo, alla quale il figlio dà ascolto. Le donne riavranno i loro figli morti e sui loro corpi potranno piangere e soffrire. «Sventura», infatti, «che gli uomini crucci di più / di questa non c’è: / vedere cadaveri i figli» (248).
Il nostro essere per la morte si placa soltanto con il morire. Nel frammezzo c’è il pensare, c’è il canto, c’è la bellezza che riscatta il nostro pianto: «Quanto al poeta, i canti ch’egli crea, è giusto che li crei pieno di gioia» (221), la gioia che è data dal cantare.
1. Euripide, Supplici (Ἱκέτιδες), in «Le tragedie», trad. di Filippo Maria Pontani, Einaudi 2002, p. 223.