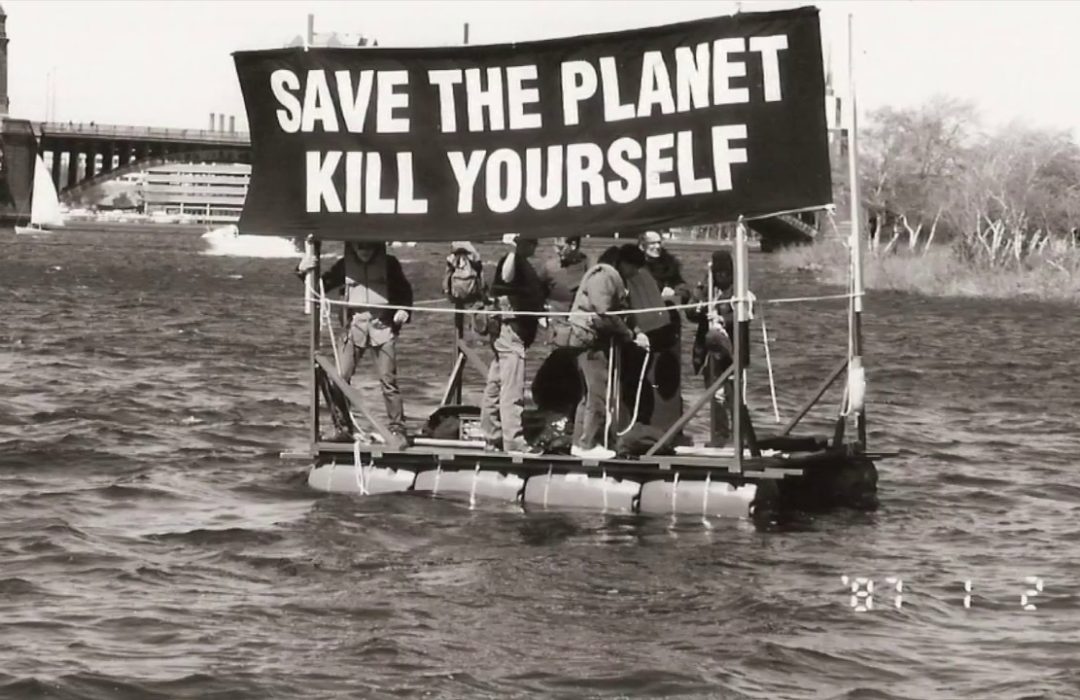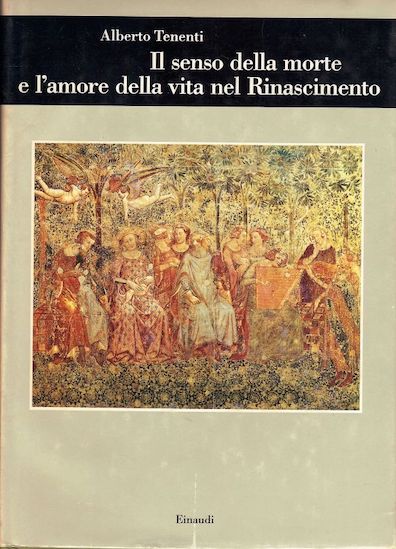
Alberto Tenenti
Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento
Einaudi, 1989 (I. ed. 1957)
Pagine XVII-511
La storiografia delle Annales ha fatto dello studio della sensibilità collettiva, della mentalità, uno dei suoi elementi innovatori e fondamentali. Questo ampio lavoro di Alberto Tenenti si inserisce in tale ambito di ricerca. Il volume prende in considerazione il periodo che va dal 1348 (anno della ‘peste nera’ in Occidente) alla fine del Cinquecento. Due secoli e mezzo che videro l’irrompere di un nuovo senso della morte nella vita quotidiana, nella sensibilità diffusa e nelle testimonianze artistiche. Da elemento naturale e quasi collettivo, la morte viene a poco a poco concepita come un evento individuale e terribile che sorprende il vivente e ne sconvolge non soltanto i progetti e le ambizioni mondane ma anche il destino di anima immortale.
Dal 1350 in poi appaiono dunque una molteplicità di testi dedicati all’ars moriendi –«che era semplicemente l’arte di vivere come se da un momento all’altro l’uomo fosse chiamato a comparire dinanzi al giudice divino» (p. 41)– e si affermano i Trionfi della morte e le Danze macabre.
Ed è proprio sul ‘macabro’ che si incentrano le analisi più originali di Tenenti. Egli dimostra che il proliferare di scheletri squarciati, di crani, tibie, fantasmi che lottano –e sembra che danzino– con i vivi, fu espressione di un primo, per quanto timido e graduale, allontanamento dalla concezione cristiana della morte. Dalla «contemplazione della putredine e dell’annichilamento fisico» molti trassero verso un ascetismo mistico ed estremo ma molti altri «attraverso il doloroso confronto con l’immagine e il sentimento della loro sorte organica, giunsero ad affermare irrevocabilmente proprio l’amore della vita ed il valore essenziale dell’esistenza terrena» (147; cfr. anche 459).
Mentre prima del Trecento la morte costituiva in qualche modo soltanto un passaggio dell’anima all’eterno, dalla nuova consapevolezza della putrefazione delle membra si svilupparono sia un funebre desiderio del Cielo sia l’amore per questa vita, per questo corpo nello splendore delle sue funzioni vitali. Ecco perché Tenenti può sostenere «la ‘laicità’ del macabro» (424), strumento ambiguo che concentrandosi sui destini del corpo costituì un elemento di rottura della concezione antropologica medioevale: «Durante dieci secoli il cristianesimo non ha sentito il bisogno di rappresentare la sorte del corpo. […] Bisognerà ammettere una trasformazione molto profonda nelle strutture spirituali cristiane per attribuire loro, anche solo in parte, le manifestazioni di quel senso della morte di cui l’iconografia dei secoli XV e XVI è l’espressione» (412).
Dall’inveramento e dal superamento del macabro si svilupparono posizioni nuove e feconde sulla morte e sulla vita: la scettica serenità di Montaigne e la recti conscientia di Erasmo che ponendo il morente –ma prima ancora il vivo– di fronte alla propria interiorità lo tranquillizza e lo riconduce a un «senso morale puramente umano» (285). Per Montaigne la morte è dentro la vita, è un fatto della vita, che non proviene dall’esterno ma nasce dal di dentro, giorno per giorno. L’esistenza è così diventata una realtà in sé completa e conclusa. Eliminata la prospettiva ultraterrena, con le sue speranze e le sue paure, il senso della vita diventa il qui e ora del lavoro, dell’amore umano, delle gioie e delle difficoltà concrete e quotidiane. Nasce insomma la sensibilità moderna e con essa un’altra forma della socialità.
Di questo snodo concettuale che dal macabro ha condotto all’ottimismo della laicità, Tenenti analizza le testimonianze filosofiche, letterarie e figurative. Il volume è infatti integrato da una nutrita iconografia che l’autore descrive e commenta permettendo al lettore di inoltrarsi nella articolata concezione rinascimentale della morte. Essa costituisce un momento, una tappa, una manifestazione della complessità dell’essere e del finire umani. Complessità che Vladimir Jankélévitch ha espresso in questa formidabile sintesi: «avendo trattato, a proposito della vita, del mortalis che esprime una proprietà astratta, e del moriturus che designa un futuro e una vocazione, poi, a proposito dell’istante, del moribundus ‘sul punto di’ morire e del moriens ‘che sta per morire’, dovremmo trattare adesso del mortuus, che designa uno ‘stato’» (La morte, trad. di V. Zini, Einaudi 2009, pp. 372-373).
Il modo in cui singoli individui, intere civiltà, epoche storiche affrontano il morire è un indice fondamentale del loro modo di intendere la vita. Nella Postfazione del 1989 Tenenti osserva saggiamente che «se, da un lato, vi sono, nella presente congiuntura, comprensibili risorgenze di fantasmi o miraggi dell’aldilà, occorre dall’altra sviluppare sempre più fortemente la coscienza che qualsiasi aspetto – rituale, funerario, mentale – del senso della morte fa parte della vita sociale, politico-economica e culturale concreta» (504).