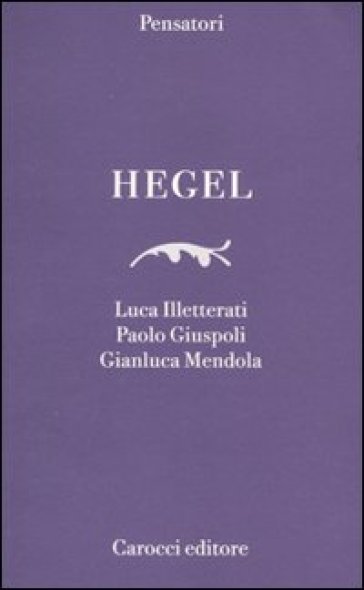Luca Illetterati – Paolo Giuspoli – Gianluca Mendola
Hegel
Carocci Editore, 2017
Pagine 355
Il lavoro del concetto è volto anche a superare «la scissione e la lacerazione che attraversano tutti i livelli della vita» (p. 18). Superamento dal quale possa emergere «la struttura razionale del mondo» (11), elaborando una prospettiva e un sapere che cerchino di intendere razionalmente la molteplicità, varietà, negatività e incomprensibilità dell’esperienza umana. «La filosofia costituisce per Hegel anche la risposta al problema avanzato da Aristotele sulla possibilità umana di partecipare a una dimensione di pura scienza, libera dalle strutture spazio-temporali che vincolano il pensiero agli oggetti finiti e instabili dell’esperienza ordinaria» (298). Prima ancora che aristotelico, questo è un gesto eleatico, fiducioso nella identità del pensare con l’essere, della logica con la metafisica. Una logica metafisica il cui motore teoretico consiste in «un incessante e mai concluso processo di autorealizzazione e di autocomprensione» (325).
Per questo è necessario comprendere la necessità del negativo, il suo costituire una dimensione intrinseca alla razionalità dell’intero. Se omnis determinatio est negatio, è anche perché il presentarsi di un ente rende impossibile il presentarsi di ogni altro ente nello stesso luogotempo; perché l’evento che sta accadendo esclude una quantità innumerevole di altri eventi, perché ogni processo è sempre e solo l’attualizzazione di una determinata potenzialità a esclusione di molte altre che pure sarebbero state possibili. Il non, la negazione, il nulla sono quindi impliciti nell’essere non come suo residuo, non come sua accidentalità, non come suo ostacolo ma come la condizione stessa nella quale e attraverso la quale enti, eventi e processi sono resi possibili, si danno, ci sono. Questo nulla intrinseco alle strutture dell’essere è la differenza, è «die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt», la magica forza che volge il negativo nell’essere, una forza posta a coerente conclusione di una delle più chiare affermazioni del negativo che siano state pensate:
«Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes, Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch, und nun, damit fertig, davon weg zu irgend etwas anderem übergehen; sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt»
(Die Phänomenologie der Geistes, «Gesammelte Werke», IX, p. 27)
«Ma non quella vita che inorridisce dinanzi alla morte, schiva della distruzione; anzi quella che sopporta la morte e in essa si mantiene, è la vita dello spirito. Esso guadagna la sua verità solo a patto di ritrovare sé nell’assoluta devastazione. Esso è questa potenza, ma non alla maniera stessa del positivo che non si dà cura del negativo: come quando di alcunché noi diciamo che non è niente o che è falso, per passare molto sbrigativamente a qualcos’altro; anzi lo spirito è questa forza sol perché sa guardare in faccia il negativo e soffermarsi presso di lui. Questo soffermarsi è la magica forza che volge il negativo nell’essere»
(Fenomenologia dello Spirito, trad. di E. De Negri, La Nuova Italia 1985, vol. I, p. 26)
Negativo significa anche che ciò che era si è dissolto e ciò che sarà ancora non è. Per questo il tempo è una delle più chiare forme, forse la più chiara, della necessità, vastità e potenza del negativo. Il cui nome necessario e fecondo è il divenire che non mira ad alcun risultato definitivo ma costituisce il processo in cui l’essere accade, è la struttura dentro la quale l’essere si rende visibile. La verità, qualunque elemento si intenda con tale parola, è la concretezza e dunque il limite del divenire. Per questo la verità non potrà mai darsi in forma definitiva ma sempre come processo. Per questo rispetto alla quieta e apparente stabilità dello spazio il tempo «è l’assoluta inquietudine di ciò che, mentre è, non è, e mentre non è, è» (213). Per questo la finitudine è intrinseca alla condizione ontologica del cosmo fatta di enti che sono eventi e la cui natura è quindi il dileguare.
Pertanto non è solo alla del tutto trascurabile componente biologica dell’essere che è intrinseca la finitudine. Ciò che per il vivente – vegetale o animale che sia – si chiama morire, è in realtà l’esperienza universale del trapassare in altro, del metabolismo, della metamorfosi, dell’entropia. La struttura biologica aggiunge piuttosto all’universale potenza del dileguare la particolarità di farlo in quel «tentativo essenzialmente ‘disperato’» (230) che è la riproduzione di una copia somigliante a sé, nella quale due entità entrambe del tutto finite presumono di differire il loro dileguarsi. Questo tentativo è una delle espressioni più chiare, drammatiche e banali della schlechte Unendlichkeit, della cattiva infinità che non smette mai di aggiungere vite a vite e dunque morte a morte:
«Dieser Prozeß der Fortpflanzung geht hiermit in die schlechte Unendlichkeit des Progresses aus. Die Gattung erhält sich nur durch den Untergang der Individuen, die im Prozesse der Begattung ihre Bestimmung erfüllt [haben] und, insofern sie keine höhere haben, damit dem Tode zugehen»
(Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, in «Gesammelte Werke», XIX, § 370)
«Questo processo della propagazione riesce alla mala infinità del progresso. Il genere si mantiene solo mediante la rovina degli individui; i quali nel processo dell’accoppiamento adempiono alla loro destinazione e, in quanto non ne hanno altra più elevata, vanno così incontro alla morte»,
(Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. di B. Croce, Mondadori, 2008, § 370, p. 363).
Porsi a questo livello di comprensione del mondo non può che lasciare dietro di sé ogni etica in quanto effetto e manifestazione dello sguardo parziale sull’intero. Qui sta certamente uno dei gesti più spinoziani, e quindi radicali, di Hegel, il quale «è fermamente convinto che una considerazione filosofico-scientifica della storia sia incompatibile con una sua valutazione etica sulla base dei principi astratti e che la considerazione scientifica della storia consiste invece nel comprendere le ragioni per cui la situazione mondiale è così com’è» (292).
Questa radicalità salva la dialettica hegeliana dal rischio intrinseco a ogni idealismo e ben presente, nonostante il suo mirare all’oggettività, a chi ritiene in modo inevitabilmente cartesiano («mit Cartesius […] können wir sagen, sind wir zu Hause», ‘con Cartesio possiamo dire d’essere a casa’, Lezioni sulla storia della filosofia, Laterza 2009, p. 469) che il pensare preceda cronologicamente e soprattutto logicamente l’essere e che dunque il pensare non debba né possa presupporre nulla prima di sé: «Questo carattere di ‘autofondatività’ – carattere che costituisce l’elemento insieme più specifico e più problematico del discorso filosofico hegeliano – è quello che consente alla scienza di essere a differenza del sistema delle conoscenze, un sapere della totalità» (104).
L’antropocentrismo idealistico hegeliano rimane comunque sempre un tentativo di pensare l’oggettività dell’essere, del nulla e del divenire; tentativo nel quale la filosofia è certamente «scienza in un senso più radicale rispetto a quanto non lo siano le scienze positive» (104), è certamente scienza del mondo nel senso che essa pensa il mondo ed è il mondo che nella filosofia pensa se stesso.