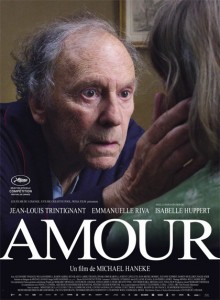di Marco Bellocchio
Con: Toni Servillo (Uliano Beffardi), Alba Rohrwacher (Maria), Isabelle Huppert (Divina Madre), Maya Sansa (Rossa), Pier Giorgio Bellocchio (Pallido), Fabrizio Falco (Pipino), Michele Riondino (Roberto), Brenno Placido (Federico), Gian Marco Tognazzi (marito della Divina Madre), Roberto Herlitzka (psichiatra)
Italia, 2012
Trailer del film
Cinema. E basta. L’immagine iniziale è di una donna con la testa e il braccio reclinati sulle panche di una chiesa. Questa donna è una tossica che cerca di rubare per procurarsi la dose, che si ferisce di continuo con un coltello, che tenta più volte il suicidio. E che un medico, il dottor Pallido, si intestardisce ogni volta a salvare.
Un’altra donna è Divina Madre, attrice di grande bravura e successo che ha rinunciato al teatro, alla famiglia, all’amore, per stare accanto alla figlia Rosa che continua a respirare solo perché aiutata da una macchina. Divina Madre si è circondata di statue della Madonna, di sacerdoti, di suore e infermiere con le quali recita furiosamente i suoi rosari lungo i corridoi del palazzo dove abita. Rosa è truccata e vestita di tutto punto nel suo letto. Spenta come una bambola. Il tormento della Madre è di non avere fede sufficiente, di non credere davvero e totalmente alle parole evangeliche che ascolta in chiesa: «La bambina non è morta ma dorme».
Due fratelli. Pipino è bipolare, estremo. Sta andando a Udine per esprimere solidarietà a Peppino Englaro, che ha ottenuto di far trasferire la figlia da Lecco a una clinica dove la restituiranno alla naturalità del suo corpo malato. Roberto lo accompagna, lo accudisce, lo protegge. Ma non riesce a evitare che in un bar il fratello incontri delle ragazze che si stanno recando anch’esse a Udine ma per il motivo opposto, per protestare contro quello che definiscono l’assassinio di Eluana Englaro. Pipino lancia un bicchiere d’acqua contro il viso di una delle ragazze. Roberto evita che faccia di peggio, chiede scusa, dà il proprio numero di cellulare a Maria.
Maria. È la figlia del senatore Uliano Beffardi (un Toni Servillo straordinario, ormai al vertice della sua bravura), il quale cerca di non rispondere alle chiamate del presidente dei senatori del PDL che dovranno votare in fretta e furia una legge che imponga di intubare nuovamente Eluana. Non risponde perché ha deciso di non votare per questa legge, di disobbedire agli ordini di Berlusconi e del partito. La moglie di Beffardi e madre di Maria era morta dopo una lunga agonia. Agonia che la donna chiese proprio a lui di abbreviare spegnendo la macchina che la teneva in vita. Ora il senatore non può, non può proprio, rinnegare le proprie convinzioni. E si pone così non soltanto contro il partito ma anche contro la figlia che continua a recitare preghiere a Udine.
Nel proprio studio Beffardi sta preparando il discorso con il quale motiverà il proprio voto e subito dopo si dimetterà da senatore. Dirà che lui, ateo, avrebbe voluto tenere ancora in vita la moglie anche soltanto per un giorno, per una settimana. E che invece la moglie, convinta cristiana, non sopportava più di vivere e gli chiese ancora un atto d’amore, l’ultimo. Per amore di lei e della sua libertà Beffardi l’aveva accontentata, in uno struggente abbraccio.
Dappertutto, nella casa di Divina Madre e di Rosa, nell’ospedale dove Pallido non lascia un momento Rossa la tossica, negli alberghi di Udine, nelle stanze del Senato, dominano i televisori che raccontano ora per ora quanto sta accadendo a Eluana, la bella addormentata. Un flusso di immagini senza interruzione, una presenza ossessiva. Televisori anche nella sauna del Senato dove Beffardi incontra un disincantato psichiatra che gli riferisce come molti onorevoli cadano in depressione allorché non vengono più invitati in televisione, o vengono invitati di meno. I senatori immersi nella sauna con gli sguardi rivolti verso i televisori formano una magnifica scena quasi felliniana, surreale e drammatica.
Quegli stessi politici si riuniscono in una delle grandi sale per una foto di gruppo sullo sfondo dei filmati che mostrano lo sventolio delle bandiere del Partito della libertà. Sui loro volti sono stampati indifferenza e menzogna. Ma anche paura.
I nomi reali si alternano a quelli simbolici: Beffardi, Rossa, Divina Madre, Pallido. Il flusso della vicenda accaduta si mescola a immagini oniriche. Il vivere e il morire si intrecciano, inseparabili. E a emergere è la Grande Paura che intesse la contemporaneità occidentale rispetto ad altre epoche e ad altre culture, la paura della morte, il suo rifiuto disperato, fanatico e perdente. Prima infatti che il senato possa votare una legge che impone il totalitarismo etico dello Stato, bella addormentata si addormenta per sempre.
Un mondo che della morte sa vedere soltanto l’orrore, e che fa di tutto per nasconderlo e differirlo, è un mondo senza dignità. Quella dignità che si vorrebbe togliere al Leib, ai corpi vissuti, per immobilizzarli nel Körper, nel puro organismo.
Ma questo sta sullo sfondo. Bella addormentata è cinema, grande cinema. E basta.

 africana e oceanica. È così che inizia una concezione panica e panteistica dell’essere, dell’umano e dell’arte. Concezione che Picasso conservò sempre ed è già assai chiara in un Paesaggio con due figure (1908) nel quale gli umani sono del tutto immersi nella physis vegetale, in una serena e potente unione con le forze ctonie del mondo [cliccando sull’immagine si noteranno meglio le due figure].
africana e oceanica. È così che inizia una concezione panica e panteistica dell’essere, dell’umano e dell’arte. Concezione che Picasso conservò sempre ed è già assai chiara in un Paesaggio con due figure (1908) nel quale gli umani sono del tutto immersi nella physis vegetale, in una serena e potente unione con le forze ctonie del mondo [cliccando sull’immagine si noteranno meglio le due figure]. La pittura di Picasso si fa spesso scultura, come in Michelangelo, e le sculture assumono la lievità di un dipinto. Dopo i colori vivacissimi degli anni Sessanta, uno degli ultimi dipinti è il grigionero di Le jeune peintre (1972). Questo giovane artista è in realtà uno spettro, è la morte/pittura che viene a prenderlo.
La pittura di Picasso si fa spesso scultura, come in Michelangelo, e le sculture assumono la lievità di un dipinto. Dopo i colori vivacissimi degli anni Sessanta, uno degli ultimi dipinti è il grigionero di Le jeune peintre (1972). Questo giovane artista è in realtà uno spettro, è la morte/pittura che viene a prenderlo.