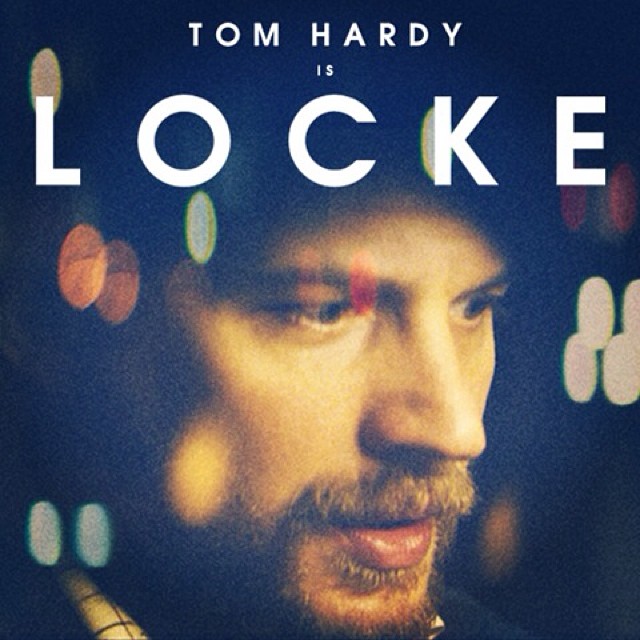Mente & cervello 132 – dicembre 2015
 Tre affermazioni contenute in questo numero di Mente & cervello ribadiscono la natura profondamente filosofica della riflessione sul corpomente.
Tre affermazioni contenute in questo numero di Mente & cervello ribadiscono la natura profondamente filosofica della riflessione sul corpomente.
La prima è che tale corpomente costituisca -ancora una volta- un dispositivo semantico volto a trovare e donare significato e senso al mondo. Persino lo stato iniziale delle allucinazioni costituisce un’espressione di tale necessità, essendo anche le allucinazioni una modalità di interpretazione di qualcosa che non si comprende: «Il nostro cervello tende infatti a interpretare il mondo attraverso conoscenze pregresse permettendoci di costruire in tempi rapidi una visione coerente dell’ambiente fisico e sociale col quale interagiamo. In particolare questo accade nella visione, un processo in cui il cervello ‘inventa’ quello che vediamo riempiendo i vuoti e ignorando ciò che non è idoneo all’immagine che ci aspettiamo» (G.A. Fornaro, p. 22).
La seconda affermazione corrobora la tesi kantiana della autonomia dell’ambito morale dalle religioni. Sembra infatti che «bambini i quali crescono in famiglie molto religiose tendono a essere meno altruisti dei loro coetanei», sulla base della ‘licenza morale’ che molte religioni danno a se stesse, «per cui se si fa qualcosa di ‘buono’, in questo caso si pratica una religione, ci si preoccupa meno delle conseguenze di un altro comportamento che non è morale». Ho conosciuto membri del movimento ecclesiale Comunione e Liberazione, i quali sostengono apertamente che ‘il fatto religioso’ ha diritto di infrangere -se necessario- le norme morali in nome della superiorità intrinseca di quel fatto stesso. Se ne può concludere che «la secolarizzazione della società e della morale può servire ad aumentare e non a diminuire la bontà umana» (S. Romano, 20).
La terza questione riguarda la consapevolezza del morire, che non è soltanto umana -come troppo spesso si ripete- ma è presente anche in molti altri animali, tra i quali una delle specie più vicine alla nostra intelligenza, vale a dire i corvi: «Creature straordinarie […] questi animali hanno una comprensione della morte dei conspecifici e la usano per valutare i pericoli per se stessi»; il testo di Federica Sgorbissa (p. 23) mostra le forme di tale consapevolezza.
Il dossier di questo numero è dedicato all’umorismo, al sorriso, al riso, alla loro necessità per la salute mentale individuale e collettiva. Come afferma Zarathustra, «questa corona di colui che ride, questa corona intrecciata di rose: a voi, fratelli, getto questa corona! Io ho santificato il riso; uomini superiori, imparatemi – a ridere!» (Nietzsche, Così parlò Zarathustra, IV, «Dell’uomo superiore», trad. di M. Montinari, Adelphi 1979, p. 359).