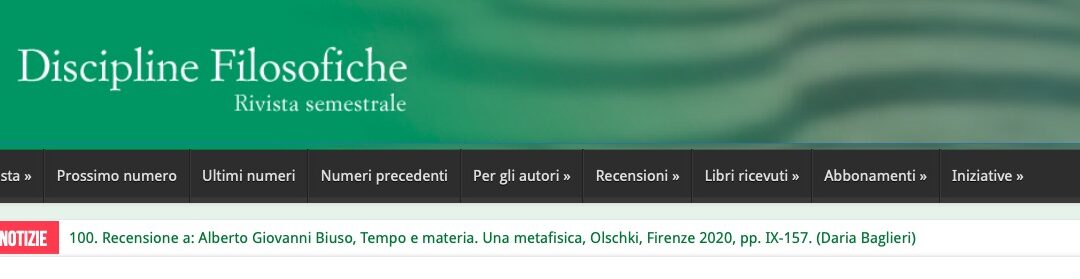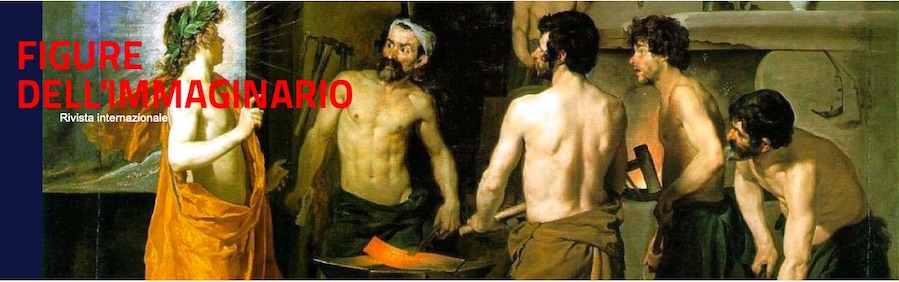«Uno strabiliante desiderio di conoscere»1 è il fondamento della cultura greca e della sua filosofia. Il fondamento dunque dell’Europa. Conoscere, non credere. Conoscere, non sperare. Conoscere, non un fare privo di consapevolezza. Credenze, speranze e azioni hanno senso soltanto se intessute della consapevolezza di ciò in cui si crede, di quanto si spera, di come si agisce.
È anche per questo che il sapere greco è ben diverso dalle visioni non argomentate delle culture soltanto religiose e dalle argomentazioni senza visioni delle culture soltanto razionalistiche. È anche per questo che il sapere greco non si strutturò, se non in rari casi, nella forma delle autoritarie ortodossie che caratterizzano molte delle esperienze culturali europee dall’avvento del cristianesimo in poi, comprese le ortodossie dei regimi totalitari del Novecento e delle tentazioni scientiste che percorrono il sapere contemporaneo e rischiano di distruggere il suo fondamento critico, dovuto anch’esso ai Greci.
Nessuna «ortodossia alla quale i suoi membri [dell’Accademia platonica] fossero obbligati a sottomettersi» (Pellegrin, 41); in essa vigeva piuttosto tutta «la libertà creatrice che contraddistingue il pensiero greco» (Lévy, 359). Lo stesso accadeva nel Liceo di Aristotele, «nel quale il maestro incorporava alcune delle critiche e dei commenti degli astanti, che di fatto più che allievi erano colleghi» (Pellegrin, 43) e dove sollevare obiezioni, questioni, critiche, era il normale modo di apprendere, come emerge anche dal «carattere problematico ed esplorativo di buona parte dell’opera aristotelica giunta sino a noi» (Sharples, 389).
La continuità e la distanza tra Platone e il suo migliore allievo non è che l’esempio più famoso e paradigmatico di «una sorprendente diversità, nella quale l’innovazione non appare inconciliabile con un’autentica fedeltà» (Brisson, 497).
È dalla filosofia «forse più originale che sia mai esistita» (Annas, 232), quella di Platone, che la struttura critica e la dimensione rivoluzionaria del pensiero greco emergono in tutta la loro evidenza. Già nelle sue scelte private Platone mostra un coraggio inaudito, rifiutando di sposarsi e di procreare figli, cosa che era vista come un dato semplicemente naturale e del tutto vincolante nei confronti della famiglia, del clan, della città. Nel modo del suo filosofare Platone rifiuta ogni autorità che non si fondi sulla plausibilità e sul rigore dell’argomentazione; elabora prospettive anche molto diverse tra i vari suoi Dialoghi (basti pensare alle tesi della Repubblica e delle Leggi, che sembrano quasi avere autori diversi); coniuga lo sguardo rivolto alla perfezione delle Forme ideali con una chiara legittimazione della ricerca dei piaceri esistenziali, come si nota non soltanto nel Filebo – dialogo che appunto ai piaceri è dedicato – ma anche nella Repubblica e nell’opera conclusiva, le Leggi, dove il fatto «che tutti cerchiamo la felicità […] necessariamente implica che in un modo o nell’altro cerchiamo una qualche forma di piacere» (Annas, 224). Il divieto posto a chi governa di possedere alcunché – compresa la famiglia, dei figli, qualunque bene economico – rimane probabilmente la richiesta più radicale che un progetto politico abbia mai rivolto a chi desidera il potere. È anche la complessità di tali cammini di pensiero a far sì che «non esista un modo incontestabile di presentare il pensiero di Platone» (Annas, 211) e a rendere la questione platonica un motore sempre acceso del pensiero.
Colui che di tale coraggio assorbì per intero profondità e sostanza, Aristotele, applicò ai campi più diversi la critica platonica a ogni dogma, fondando alcune delle scienze che tuttora costituiscono l’orizzonte del nostro sapere. Tra di esse è particolarmente feconda la biologia, che Aristotele coniuga sempre alla vita collettiva, presentando tesi che potremmo definire sociobiologiche, fondate sulla struttura corpomentale degli enti che hanno consapevolezza d’esserci in quanto individui posti sempre in relazione con altri individui e con il mondo:
Aristotele aveva definito l’anima come la forma dell’essere vivente. Ai suoi occhi dunque essa non era un’entità separabile e immateriale (come voleva Platone), né un particolare ingrediente materiale della creatura intera (come sosterrà, ad esempio, Epicuro). Tuttavia, sempre secondo Aristotele, l’anima non è semplicemente un prodotto dell’organizzazione delle parti del corpo, e quindi non è riducibile a esse: il corpo è spiegato dall’anima e, in generale, i composti di materia e forma debbano essere spiegati dalla forma (Sharples, 402).
In questa unità si fonda la natura di animale teoretico dell’uomo.
Dell’inesauribile ricchezza del sapere greco sono parte: il nesso indissolubile tra ciò che si conosce e il modo in cui si vive, il fatto che chi sa vive meglio di chi ignora; la lucidità con la quale Tucidide vede «nella paura, nel prestigio e nell’interesse le fonti principali delle azioni umane, iscritte da una necessità assoluta (anankē) in seno alla natura dell’uomo» (Ostwald, 337); la disincantata antropologia stoica, per la quale la figura del σοφός, sapiente e insieme saggio, costituisce un progetto asintotico e tuttavia da perseguire in ogni modo, nonostante gli umani siano «tutti ugualmente ‘nulli’ (phauloi, ‘senza alcun valore’, ‘ignoranti’ e ‘folli’ al tempo stesso)» (Brunschwig, 583).
Tra le questioni fondamentali dell’essere e del vivere, i Greci furono maestri del linguaggio, sia nel suo utilizzo pressoché perfetto tra i Sofisti sia nel tentativo eracliteo «di andare oltre i limiti del linguaggio ordinario» (Hussey, 119). Un tentativo del quale Heidegger ha colto per intero significato e fecondità, praticando nei suoi corsi e seminari una lettura di Eraclito che risponde ai criteri di rigore elencati qui da Edward Hussey:
Qualsiasi serio tentativo di interpretare il pensiero eracliteo deve soddisfare le quattro condizioni seguenti:
1 Tener conto del contesto intellettuale nel quale visse Eraclito […]
2 Rispettare l’unità sistematica del pensiero eracliteo celata dalla forma aforistica e implicita nelle corrispondenze tra espressione e significato che legano l’una all’altra le sentenze […]
3 Saper rilevare le indicazioni linguistiche fornite dai frammenti […]
4 Tener conto di ciò che dice o fa capire lo stesso Eraclito sulla natura del lavoro di interpretazione delle frasi difficili, e dell’identificazione che opera tra comprensione e interpretazione (121).
Tra le questioni fondamentali dell’essere e del vivere, i Greci furono maestri della metafisica. Non soltanto di quella dispiegata a partire da Platone e Aristotele sino al neoplatonismo ma anche di quella che li precede, quella dei pensatori arcaici, dell’ἀρχή, del principio, dell’inizio, i quali tutti intesero la φύσις come la condizione dalla quale e dentro la quale sorgono e splendono l’energia e la potenza delle cose che sono e che divengono, degli enti, degli eventi, dei processi, del movimento inteso nella varietà del suo darsi nello spazio e nel tempo.
È il tempo/temporalità che il sapere greco sa, conosce, esperisce e dice. Ancora una volta non soltanto nei fondatori ma in tutti. Epicuro, ad esempio, per il quale «mentre le affezioni del corpo sono limitate al presente, l’anima, che abbraccia il passato e il futuro, ne moltiplica l’intensità» (Laks, 111). O Stratone di Lampsaco, convinto che «il movimento e il tempo sono continui, mentre il numero è fatto di unità discrete; egli quindi definisce il tempo come quantità, o misura, sia del movimento sia del riposo, facendolo esistere così indipendentemente dal movimento» (Sharples, 396), tesi fondamentale che va oltre il limite aristotelico del tempo/movimento. O il maggiore dei commentatori dello Stagirita, Alessandro di Afrodisia, che affranca la temporalità dall’elemento numerante della mente, confermando la natura ontologica e non soltanto epistemologica del tempo:
Aristotele aveva ritenuto inoltre che non vi potesse essere tempo senza un’anima che eseguisse la numerazione (Fisica, 223 a 21 sgg.). Alessandro invece sostiene che il tempo è, per sua natura, un’unità, e che solo nel nostro pensiero esso viene suddiviso dall’istante presente. Ai suoi occhi dunque il tempo in se stesso potrebbe esistere al di fuori di ogni numerazione; ed egli sembra identificare il tempo così concepito col movimento continuo numerabile della sfera celeste più esterna (Sharples, 397).
Anche per questo, se un anacronismo è concesso, la scienza contemporanea nella quale il sapere greco meglio e più si manifesta è la termodinamica, il cui nome è interamente ellenico, nel suo riferimento al movimento e al divenire del calore. Uno dei primi affrancatori da ogni superstizione, Anassagora, ritiene infatti che «le ‘cose che sono’ non nascono né muoiono, ma si ‘riuniscono’ (synkrisis) e si separano (diakrisis). Anassagora così potè concepire la storia del mondo non come l’immagine impoverita del discorso ontologico, ma come il luogo stesso del suo dispiegamento» (Laks, 6). Uno dei più radicali liberatori dalle paure, Epicuro, così sintetizza gli elementi del mondo:
La stoicheiōsis fisica comporta dieci proposizioni […] che comportano l’armatura indistruttibile della disciplina […]: 1) niente nasce da ciò che non esiste; 2) niente si dissolve in ciò che non esiste; 3) l’universo è sempre stato come è ora e lo rimarrà sempre; 4) l’universo è fatto di corpi e di vuoto; 5) i corpi sono di due tipi: atomi e composti di atomi (gli aggregati); 6) l’universo è infinito; 7) gli atomi sono infiniti di numero e il vuoto infinito per estensione; 8) gli atomi di forma identica sono di numero infinito, ma il numero delle loro forme è indefinito, non infinito; 9) il movimento degli atomi è incessante; 10) gli atomi hanno solo tre proprietà in comune con le cose sensibili: la forma, il volume e il peso (Laks, 104).
La fisica atomistica, la fisica termodinamica, la fisica della materia/struttura e della materiatempo, affondano le radici in questo sapere. Non a caso non ci è rimasto alcun libro di uno dei più profondi filosofi di ogni tempo, Democrito. E questo perché «la tradizione atomista, rappresentata da Democrito e poi da Epicuro, cozzava brutalmente con gli interessi di coloro che ci hanno trasmesso la loro selezione dell’eredità classica, in particolare i letterati cristiani» (Furley, 68).
A Democrito vorrei dedicare il tentativo di metafisica che ho cercato di attuare in Tempo e materia. Che un platonico, quale in gran parte sono, possa fare una simile dedica è una piccola conferma della profonda libertà che i Greci hanno regalato a chiunque voglia coglierne i saperi.
Nota
1.P. Pellegrin, in Il sapere greco. Dizionario critico (Le savoir grec, Flammarion 1996), a cura di J. Brunschwig e G.E.R. Lloyd; edizione italiana a cura di M.L. Chiesara, Einaudi 2007, vol. II, pp. 54-55. Le citazioni successive saranno indicate con il nome dell’autore e il numero di pagina.
[Del primo volume di quest’opera coinvolgente ed enciclopedica ho parlato qui: La totalità dell’esistenza]