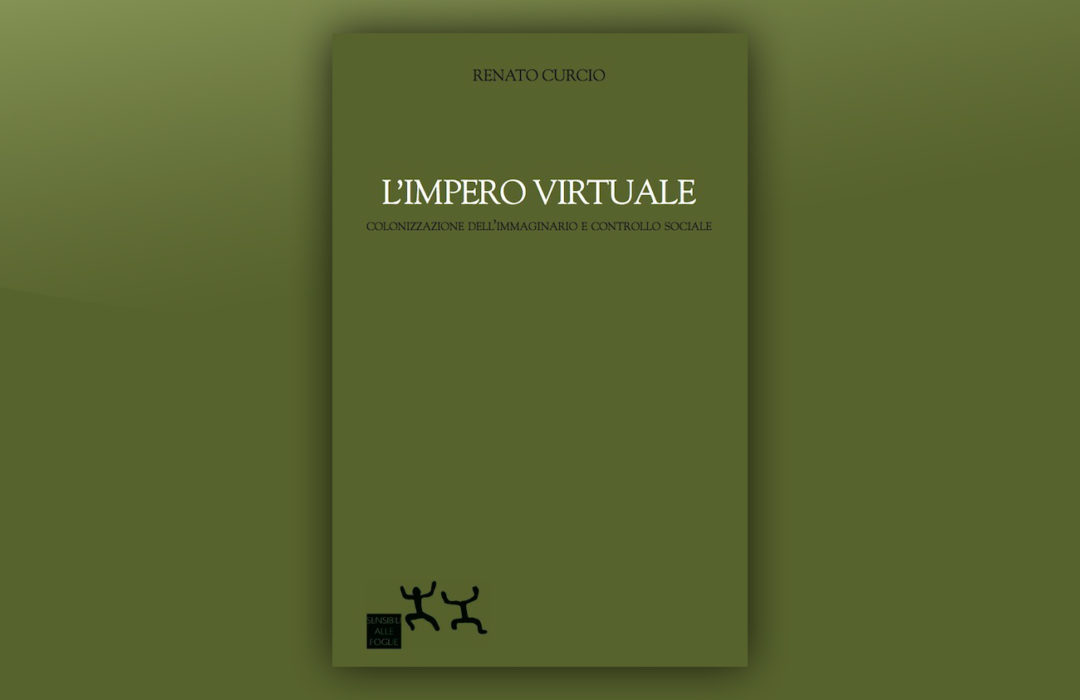Piccolo Teatro Strehler – Milano
Macbeth
di William Shakespeare
Traduzione di Agostino Lombardo
Con: Franco Branciaroli, Valentina Violo, Tommaso Cardarelli, Daniele Madde, Stefano Moretti, Livio Remuzzi, Giovanni Battista Storti, Alfonso Veneroso
Regia di Franco Branciaroli
Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano · Teatro de Gli Incamminati
Sino al 6 novembre 2016
La tragedia è l’immaginare. Tutto infatti avviene nella mente. Se non avessimo questo pungolo continuo del pensare, dal quale -certo- prendono vita poesia, cultura, scienza, interi mondi, staremmo nel presente dell’empiria, dei fatti, dell’adesso. E invece è la mente che ci porta dove aggrada. Nelle memorie felici e in quelle atroci del già stato, nell’attesa senza pause del futuro, in un presente che è sempre interpretato.
Le streghe di Macbeth, le potenze che lo inquietano, lo illudono, lo sbattono, lo distruggono, sono i suoi pensieri, sono la sua immaginazione. Il male che lo intride sta anche nel braccio che uccide, ma abita soprattutto nella fantasia che lo pungola, lo esalta, lo terrorizza, lo stronca.
Il fantasma di Banquo è la più evidente prova che la tragedia è l’immaginare. Stessimo fermi al qui e ora avremmo dolore ma non angoscia, saremmo sempre miserabili ma con misura. E invece la forza del pensare ci porta tra luoghi che sono stati e altri che forse o mai saranno. Luoghi che tralucono a volte miele di dolcezza e altre invece sono fatti di pura atrocità -«Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / nella miseria» (Alighieri, Inferno, V, 121-123)- e in essi abitiamo come a casa nostra. Poiché è il pensiero la nostra dimora. Abitiamo le sue stanze che hanno nome memoria, attesa, intenzione, fantasia.
Anche per questo «non si pò avere maggior, né minor signoria che quella di se medesimo» (Leonardo da Vinci, Scritti letterari, Rizzoli, aforisma 65, p. 71). Perché essere signori di se stessi vuol dire dominare pensieri, ricordi, attese. Vuol dire regnare.
Macbeth intende regnare sugli umani e sulle terre ma è in balia del proprio immaginare. Lui come la sua compagna. La domanda più lucida e più disperata il re non la rivolge alle streghe ma al suo medico, al quale chiede di dare aiuto alla regina: «Cure her of that. / Canst thou not minister to a mind diseased / Pluck from the memory a rooted sorrow / Raze out the written troubles of the brainrrow?» ‘E curala di questo, guariscila. Non sai occuparti di una mente malata, sradicandole dalla memoria la pena che l’avvolge?’ (Atto V, scena III). Chi sa fare questo non è un medico. È un mago, è un filosofo.
Branciaroli ha intuito tale verità e fa del suo Macbeth una tragedia dell’immaginazione. Assai efficace la scelta di far parlare in inglese le streghe, rendendo ancora più evidente la loro potenza in primo luogo linguistica e dunque mentale. La compagnia però è ridotta all’osso, otto attori, tanto che alcuni episodi non compaiono, così come la scena è minimale; il protagonista, poi, esagera un po’ nella consueta iperteatralità del suo recitare. Ma questa rimane l’opera più radicale e più profonda di Shakespeare, quella in cui la tragedia dell’immaginazione umana si è fatta parola, carne, sangue.




 I quattro capitoli di cui si compone il volume sono costituiti da altrettante lezioni che Grecchi ha tenuto a degli studenti di psicologia. Circostanza che dà un taglio didattico e divulgativo al libro. L’attenzione si concentra sulla filosofia greca, dai pensatori delle origini all’ellenismo. Della riflessione successiva viene analizzata l’opera di Leopardi, con veloci accenni conclusivi a filosofi del Novecento.
I quattro capitoli di cui si compone il volume sono costituiti da altrettante lezioni che Grecchi ha tenuto a degli studenti di psicologia. Circostanza che dà un taglio didattico e divulgativo al libro. L’attenzione si concentra sulla filosofia greca, dai pensatori delle origini all’ellenismo. Della riflessione successiva viene analizzata l’opera di Leopardi, con veloci accenni conclusivi a filosofi del Novecento.