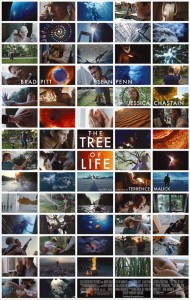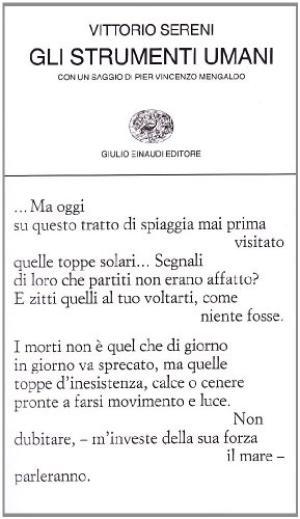Il Sé sinaptico.
Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che siamo
di Joseph LeDoux
(Synpatic Self. How our Brain Become Who We Are, Viking Penguin 2002)
Trad. di Monica Longoni e Alessia Ranieri
Prefazione di Edoardo Boncinelli
Raffaello Cortina Editore, 2010
Pagine 556
 Uno degli elementi più discutibili della ricerca neurologica -e medica in generale- sta nell’utilizzo di quelli che anche LeDoux definisce “animali da esperimento”. Una formula chiaramente inaccettabile, che riduce la dignità dell’animale vivente a una cosa. Il retaggio cartesiano di molta neurologia è evidente anche in questa scelta lessicale e nell’estensione per analogia alla mente umana dei risultati di esperimenti attuati su altre specie. Di converso si continua ad applicare agli altri animali l’illogica pretesa di essere come l’Homo sapiens. Dato che tale pretesa è per definizione impossibile da soddisfare, se ne deduce che gli altri animali non abbiano coscienza, consapevolezza, mente. C’è da dire che per fortuna l’autore di questo libro tempera di tanto in tanto simili tesi antropocentriche, come quando scrive che «una volta che si accetta che il Sé di un essere umano abbia aspetti consci e inconsci, diviene facile osservare come gli altri animali possano essere pensati come aventi dei Sé, purché si sia cauti circa quali aspetti del Sé vengano attribuiti a ciascuna specie in questione» (p. 30).
Uno degli elementi più discutibili della ricerca neurologica -e medica in generale- sta nell’utilizzo di quelli che anche LeDoux definisce “animali da esperimento”. Una formula chiaramente inaccettabile, che riduce la dignità dell’animale vivente a una cosa. Il retaggio cartesiano di molta neurologia è evidente anche in questa scelta lessicale e nell’estensione per analogia alla mente umana dei risultati di esperimenti attuati su altre specie. Di converso si continua ad applicare agli altri animali l’illogica pretesa di essere come l’Homo sapiens. Dato che tale pretesa è per definizione impossibile da soddisfare, se ne deduce che gli altri animali non abbiano coscienza, consapevolezza, mente. C’è da dire che per fortuna l’autore di questo libro tempera di tanto in tanto simili tesi antropocentriche, come quando scrive che «una volta che si accetta che il Sé di un essere umano abbia aspetti consci e inconsci, diviene facile osservare come gli altri animali possano essere pensati come aventi dei Sé, purché si sia cauti circa quali aspetti del Sé vengano attribuiti a ciascuna specie in questione» (p. 30).
Un altro limite del libro è la prospettiva nel complesso discreta e non olistica nella quale si pone. Vengono infatti narrate in dettaglio le vicende dei neuroni, dei dendriti, degli assoni, delle sinapsi. E si dà quasi per scontato che questo basti per comprendere il Sé. Ora, se è vero che tutti i pezzi e le parti di un motore devono essere attivi e funzionanti affinché si dia il movimento dell’automobile, il moto dell’auto nello spazio è altra cosa rispetto al funzionamento dei singoli pezzi meccanici. Il tutto, come l’empirista Aristotele sapeva, è superiore alla somma delle parti. Sembrerebbe quindi che anche LeDoux sia un riduzionista al pari di molti suoi colleghi. Ma più sopra ho sottolineato il “quasi”. Si tratta infatti di un riduzionismo temperato che ammette come le strutture e le dinamiche neuronali non si pongano in contrapposizione alla mente e al mondo ma con essi si integrino: «per quanto cominciamo a pensare a noi stessi in termini sinaptici, non dobbiamo sacrificare altre modalità di comprensione dell’esistenza» (18); «ritengo che le impostazioni non scientifiche (letteratura, poesia, psicoanalisi) e le scienze non riduzioniste (linguistica, sociologia, antropologia) possano coesistere con le neuroscienze, integrandole» (454).