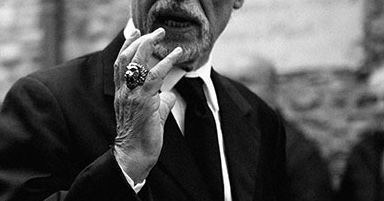Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano
Reggio Calabria – Museo Archeologico Nazionale
A cura di Massimo Osanna e Jacopo Tabolli
Sino al 12 gennaio 2025
Sempre ritornano perché mai se ne sono andati. Nascosti nelle pieghe della dissoluzione umanistica, mascherati nei dogmi dei monoteismi, potenti dentro la Φύσις, sorridenti nella luce, gli dèi sono sempre con noi e accompagnano – distanti – coloro che riconoscono nella materia e nel cosmo il Tutto del quale l’umano è soltanto una parte, un epifenomeno, un gioco, un dramma.
Questo è il politeismo, che trascorre dunque subito in panteismo. Lo si vede bene nei bronzi che dall’estate del 2022 sono ricomparsi nel Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, una località in provincia di Siena dove (come si legge nella scheda che il Museo di Reggio Calabria ha dedicato all’evento) uno scavo stratigrafico ha portato alla luce «il più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e romana mai scoperto nell’Italia antica e uno dei più significativi di tutto il Mediterraneo. Riproduzioni di parti anatomiche, offerte per chiedere alle divinità la salute o ringraziare di una guarigione, e statue realizzate secondo i canoni della cosiddetta mensura honorata (alti tre piedi romani, equivalenti a circa un metro), che raffigurano le divinità venerate nel luogo sacro o i fedeli dedicanti. La gran parte di questi pregevoli reperti si data tra il II e il I secolo a.C., un periodo storico di grandi trasformazioni che vede la definitiva romanizzazione delle potenti città etrusche».
Tutto questo costituiva la vita di un antico santuario posto nella città-stato etrusca di Chiusi, luogo che dal III secolo a.e.v. al V secolo e.v. ebbe nell’acqua sacra il principale elemento identitario.
Compare dunque davanti al visitatore la potenza dell’acqua che ha conservato questi bronzi come il mare ha fatto con quelli di Riace, l’acqua delle fonti che Servio afferma giustamente essere sempre sacra;
compare la gratitudine verso gli dèi che spingeva i pagani a dedicare loro statuette, parti anatomiche, gioielli; compare la potenza del fulmine che indicò agli umani di quelle terre dove seppellire i loro bronzi per onorare il dio che si era mostrato;
compare la potenza di questo dio, che è Zeus ma è anche Apollo «arciere dall’arco di argento» come lo chiama Omero; compare ovunque un significato totale della vita. Totale e disincantato, luminoso e tragico.
L’antropocentrismo monoteistico dei figli di Mosè, dei nazareni, dei maomettani ha tolto senso al mondo relegandolo nel dio unico, padre assoluto e signore feroce, generando così il problema ecologico dato dalla distruzione dell’οἶκος, la comune casa dei viventi. Tracce del politeismo si scorgono ancora per fortuna nel Cattolicesimo Romano, con il suo culto per i santi, alle cui guarigioni continuano a essere dedicati gli ex voto. Sono, queste, flebili tracce di una comunanza e consolazione che intesseva le vite degli antichi.
I quali anche per questo potevano generare la stupefacente armonia e bellezza dei due Bronzi che dominano lo spazio del Museo Archeologico di Reggio Calabria.
Visibili anche dalla piazza centrale dell’edificio, giustamente dedicata all’archeologo Paolo Orsi, e poi accoglienti nella sala a essi soltanto dedicata, questi dèi in forma umana sono un emblema limpido e chiarissimo della filosofia greca, del suo superamento di ogni umanesimo nel momento stesso in cui sembra celebrarlo, della metamorfosi della materia – il bronzo – in elemento sacro, della vittoria delle forme su ogni barbarie e bruttura. Accostarsi a queste due entità vuol dire avvicinarsi al dio.
Il museo della città magnogreca accoglie nei suoi spazi migliaia di reperti di varia natura, epoca, fattura, invitando a un percorso dentro la vicenda della Μεγάλη Ἑλλάς, della Grecia oltre la Grecia con la quale gli Elleni donarono al Mediterraneo luce.
Nella piazza di ingresso del Museo è attualmente allestita un’esposizione di opere contemporanee. Tra queste i Guerrieri di Filippo Balice (2024) coniugano le forme arcaiche e gli stilemi di oggi, rendendo ancora una volta vivo l’antico, che mai è morto.
Usciti dal Museo, l’ampio lungomare di Reggio Calabria offre allo sguardo i due mari che si incontrano, l’Etna che sta, la luce senza fine del Mediterraneo.