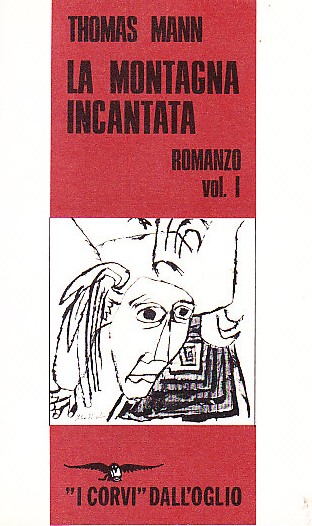
(Der Zauberberg, 1924)
di Thomas Mann
Trad. di Bice Giachetti-Sorteni
Dall’Oglio editore, Milano 1980
Due volumi – Pagine 379 e 406
Un libro immenso e inquietante, che descrive lo spazio della storia in un luogo e in un istante particolari i quali però assumono una dimensione metatemporale. Il tempo è al centro dell’opera, come in Proust. Ma diversamente da Proust non c’è qui alcuna tensione verso la memoria. Piuttosto, c’è l’ambizione di un tempo puro, di un tempo altro. Il tempo non vi è calcolato ma viene esperito nella sua neutra immediatezza, per la quale «anni densi di avvenimenti trascorrono molto più lentamente di altri poveri, vuoti, leggeri, che il vento soffia via. […] Una uniformità ininterrotta abbrevia grandi periodi di tempo in un modo incredibile e spaventoso» (Vol. I, p. 116). Nonostante secoli di cristianesimo, la rappresentazione del tempo torna a farsi circolare e soprattutto diventa rispettosa del suo enigma, del suo essere «un mistero privo di essenza, inafferrabile e potente» (II, 5).
In questa temporalità senza tempo si svolge l’iniziazione di Hans Castorp alla vita. Uomo semplice, borghese senza eccessivi conflitti e aspirazioni, Castorp si trova a partecipare al grande spettacolo della conoscenza e della morale. Il mondo in cui si muove è un teatro tutto letterario e proprio per questo veramente reale. Una pervasiva ironia e una scettica ambiguità danno voce e carne ai grandi princìpi, agli archetipi, ai concetti. E tutto ciò senza che i personaggi nei quali idee, archetipi e concetti prendono corpo e forma risultino minimamente artificiosi.
Il romanzo è immerso in un’atmosfera nichilistica ben riassunta dalle parole di Clawdia Chauchat: «Il nous semble qu’il est plus moral de se perdre et même de se laisser dépérir que de se conserver» (I, 376; il corsivo e il francese sono dell’Autore). Nell’incontro e nel conflitto tra Occidente e Oriente, pensiero e natura, ragione e magia -conflitto che attraversa l’intero romanzo- Hans Castorp catalizza intelletto e corporeità, si fa testimone e vittima della dissoluzione di un mondo, dell’Europa alle soglie del suicidio, alla vigilia della Prima guerra mondiale.
Insieme a lui vivono altre allegorie: la mediocrità volgare della signora Sthör; la regalità dionisiaca di Peeperkorn «sacerdote danzante» (II, 254); la lucidità umanistica di Settembrini, per il quale la parola è civiltà; il radicalismo religioso e comunistico di Naphta, che unifica Gregorio Magno e la dittatura del proletariato in una palingenesi millenaristica; il militarismo obbediente e devoto alla bandiera di Gioachino; il bonario ed eccentrico dottor Behrens. È un universo di comportamenti e di caratteri che rendono il sanatorio di Davos una metafora del mondo, con tutto il suo male, la sua stoltezza, la sua violenza.
Il «monte del peccato» (II, 402) è una piovra continuamente tesa ad afferrare altre vittime tra i suoi tentacoli, è un trionfo della morte nella morte del tempo. Non a caso l’improvviso ritorno di Castorp in pianura a causa della tragedia bellica acquista quasi un senso di rinascita dopo la costante dissoluzione vissuta sulla montagna incantata. Al di sopra, eppure, sembrano rimanere incontaminati, dietro l’apparenza di un’intima partecipazione al male, la misteriosa antica bellezza di Clawdia e la calma tollerante di Hans. I dialoghi tra loro due e Peeperkorn sono singolari e perturbanti ma testimoniano di una lucida razionalità, di uno sceverare l’interiorità fin nei più reconditi meandri, di un amore verso la «forma» che non è «pedanteria» ma umana civiltà (I, 377). Clawdia rimane tuttavia una venere tartara e indolente, Hans un preoccupante figlio della vita troppo facilmente attratto dall’ambigua grandezza della morte, dell’amore, della malattia. Una triade costante nella poetica di Thomas Mann, per il quale il corpo è a volte una cosa sola con il Geist, altre è invece principio di dissolutezza.
Der Zauberberg è intriso di una palpitante luminosità, che si racchiude e si schiude nel finale del romanzo, quando in mezzo a rumori di sfacelo e a bagliori di guerra germina la luce di un sentimento d’amore legato alla «festa mondiale della morte» ma che al di là del «malo delirio che incendia intorno a noi la notte piovosa» (II, 406) ha saputo essere pura forma di una bellezza antica.


