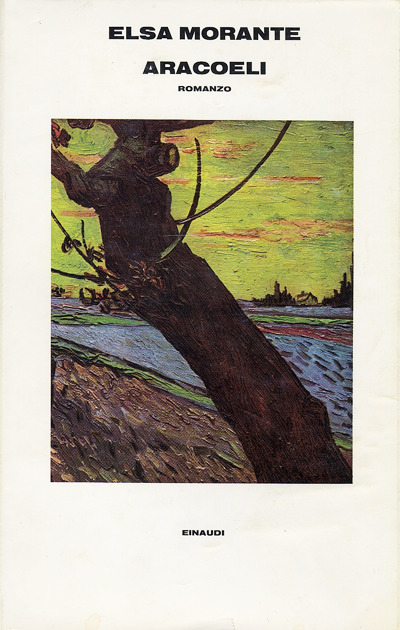Dune
di Denis Villeneuve
USA, 2021
Con: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (Il duca Leto Atreides), Stellan Skarsgård (il barone Harkonnen), Charlotte Rampling (La reverenda madre Mohiam), Chen Chang (il Dottor Wellington Yueh), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar), Zendaya (Chani)
Trailer del film
Le aride colline libanesi, il cerchio del tempo, le potenti strutture che si sbriciolano e il pesante rumore dell’acciaio erano alcuni degli elementi di precedenti film di Denis Villeneuve.
Essi convergono in Dune e si aprono alla forma che sempre sottende l’opera di questo regista: il mito. Che qui trova una vertiginosa condensazione di modi e narrazioni. La casa regnante si chiama Atridi; il giovane protagonista appare spesso una sorta di Amleto; la forza fisica si coniuga a possanza interiore; gli animali non umani vengono continuamente evocati: dai topi ai mezzi di trasporto che sono chiaramente delle libellule meccaniche, da piccoli insetti artificiali e velenosi agli enormi, enigmatici e inquietanti vermi del deserto che scavano le dune al suono ritmato dei corpi o di altre macchine; le potenze malvagie gorgogliano da liquidi e liquami e si sollevano nello spazio in tutto il loro orrore, come ben sanno le più arcaiche fiabe di ogni epoca; le potenze complici dell’Imperatore hanno un nome simile a quello dei collaboratori del funesto Demiurgo gnostico: Harkonnen; le antiche Madri continuano a tessere il destino di ogni cosa.
E su tutto il duplice mito dal quale è nata la letteratura in Europa: la guerra (Iliade) e il viaggio, il ritorno (Odissea). In questa sorta di antologia dei poemi fondativi, i pianeti si moltiplicano e gli umani -o altre entità antropomorfe e consapevoli- appaiono sempre più insignificanti e schiacciati dalla forza immensa degli spazi e delle macchine.
Sono queste ultime, le macchine, l’elemento peculiare di Dune, ancor più del deserto immane, ospitale e ostile. Macchine gigantesche, ciclopiche e massicce, che tuttavia si alzano in volo, sfrecciano nello spazio, poggiano lievi sulle superfici. Autentici palazzi galattici azionati da leve e strutture del tutto e pesantemente meccaniche, che non possiedono niente di virtuale, nulla di algoritmico, non sono dei software e sono composti invece di pietra, di cemento, di acciaio. O di qualcosa che alla pietra, al cemento e all’acciaio rimanda.
È questa realtà solida, imponente e poderosa che permette non soltanto alle coscienze di essere composte «della materia di cui son fatti i sogni» (Shakespeare, La Tempesta) ma anche ai sogni, come Dune, di essere composti della materia di cui son fatti i macigni, della materia delle rocce, del fuoco e delle galassie. Di materia è intessuta la realtà e non di formule interiori e digitali nelle quali l’umanità vagheggia e anela il proprio sopravvivere. Tranne poi, e come sempre, morire.