
Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa
Gallerie d’Italia – Milano
Primavera 2021
Tiepolo è il vortice; il Settecento è un vortice di delirio e di razionalità, una ragione che si guarda allo specchio, esulta, altro non vede fuor della propria gloria.
Tiepolo è le luci e le ombre di Caravaggio ed è gli spazi, la simmetria, la potenza di Paolo Veronese.
Qualunque tema lo ispiri, gli venga commissionato, tocchi -mito, letteratura storia–, Tiepolo è forma che tende al colore, che diventa puro colore, che si dissolve nel colore.
La santità dei suoi santi sta nella luce. Il numinoso dei suoi dèi sta nella luce.
Tiepolo è l’aria, la leggerezza, il vuoto che si fa battito cromatico, che respira, che si slancia dentro la profondità della tela, che apre i soffitti con i suoi angeli, animali, carri, sovrani, nuvole. Strutture che sprofondano e si alzano dentro un cielo azzurro, turchino, cobalto, vibrante di materialuce. Fino a che tutto sembra muoversi in una spirale senza fine di gioia, di potenza e di gloria.
Tiepolo è l’illusione che non precipita mai nel suo destino, che non diventa delusione ma, al contrario, si avvita dentro il fasto luminoso dell’eternità.
Tiepolo è Venezia, è Milano (suoi sono lo splendore di Palazzo Clerici, Palazzo Archinto, Palazzo Casati), è Madrid, è la magnifica reggia di Würzburg. Luoghi tutti dove «Tiepolo dipinge l’aria e la luce, e i suoi cieli sono meteorologicamente esatti, con nubi sempre in movimento, anche in funzione della complessa costruzione spaziale».
Tiepolo è il sorriso della forma.
Questa mostra colloca Giambattista Tiepolo (1696-1770) dentro il suo secolo, i suoi compagni e maestri di bottega, la sua famiglia, i viaggi, le architetture, le tele, gli affreschi, in un movimento infinito e vorticoso.
(«Vortice», in Un barlume di fasto, Scrimm Edizioni 2013, p. 15).







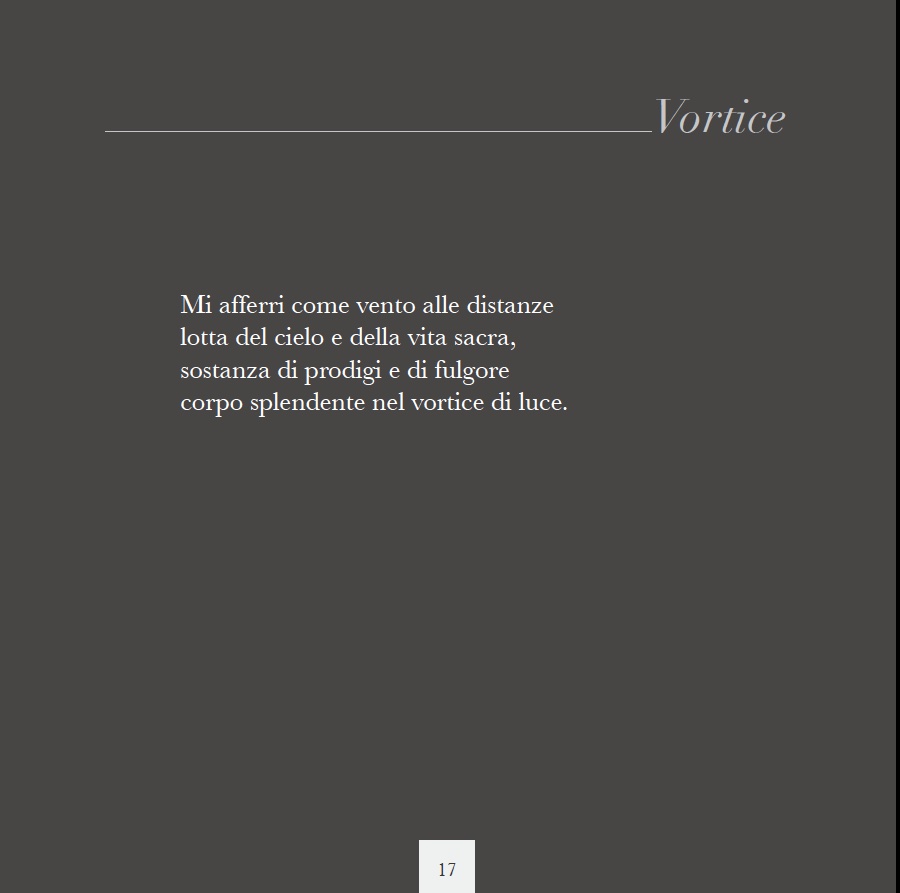
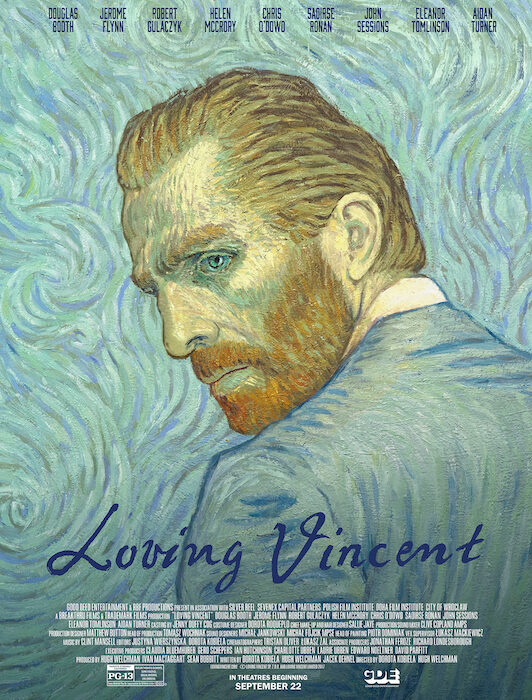
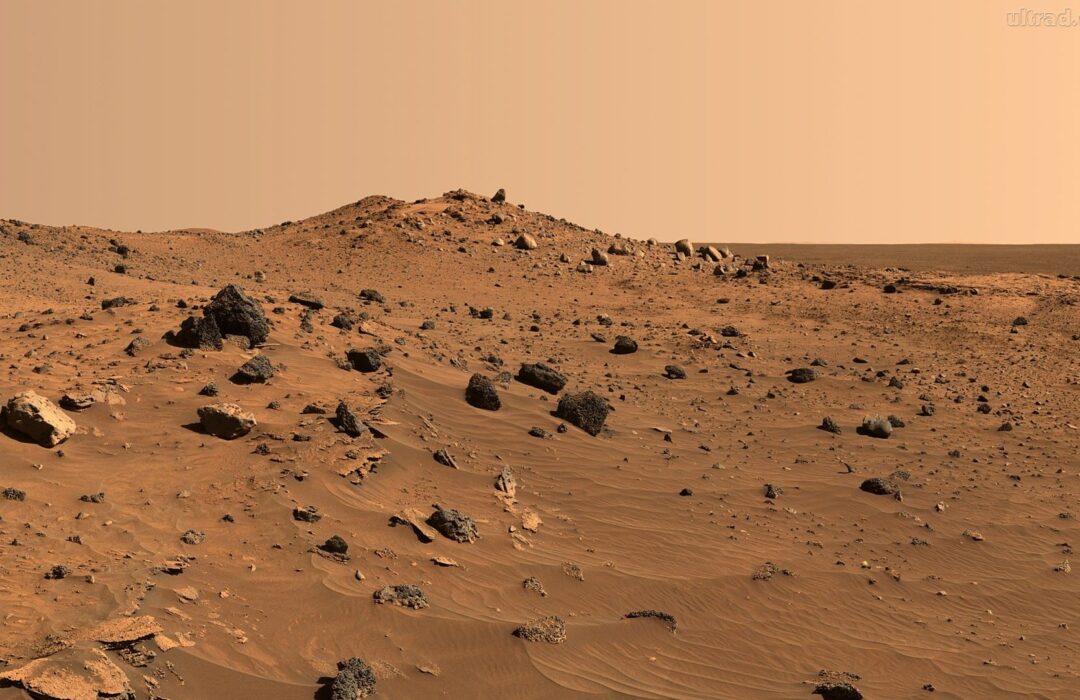



 Conte dirige con la sua tipica e discreta ironia; gli assoli costruiscono arabeschi e virtuosismi, in particolare la fisarmonica è una totalità, una potenza; Dall’Omo sembra un tarantato con accanto invece il tranquillo contrabbassista. Ma colui che mai si ferma è il batterista che per tutto il tempo ripete lo stesso gesto – davvero il pedale del diavolo rosso – con una concentrazione e un’indifferenza sovrumane. Si capisce bene perché la musica, questa musica, sia nata con Dioniso. Una canzone visionaria.
Conte dirige con la sua tipica e discreta ironia; gli assoli costruiscono arabeschi e virtuosismi, in particolare la fisarmonica è una totalità, una potenza; Dall’Omo sembra un tarantato con accanto invece il tranquillo contrabbassista. Ma colui che mai si ferma è il batterista che per tutto il tempo ripete lo stesso gesto – davvero il pedale del diavolo rosso – con una concentrazione e un’indifferenza sovrumane. Si capisce bene perché la musica, questa musica, sia nata con Dioniso. Una canzone visionaria.