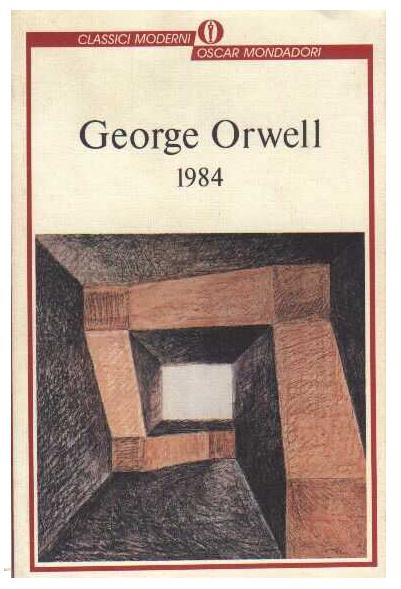di Umberto Eco
Enciclopedia Filosofica ISEDI, 2
Istituto Editoriale Internazionale, Milano 1973
Pagine 174
Un segno è qualcosa -qualunque cosa- che sta al posto di qualcos’altro. Peirce esprime con chiarezza questa sua natura: «something which stands to somebody for something in some respect or capacity» (Collected Papers, [1931], 2.228, qui a pag 27). Tutto è quindi segno, o tutto può diventarlo se viene interpretato da qualcuno come un indicatore di qualcosa.
Morris ha quindi ragione a ritenere che «la semiotica non ha a che fare con lo studio di un tipo di oggetti particolari, ma con gli oggetti ordinari in quanto (e solo in quanto) partecipano al processo di semiosi» (Lineamenti di una teoria dei segni [1938], Einaudi 1959, p. 20; qui 34). La pervasività del segno nella vita sociale e nei rapporti interpersonali è data dal fatto che l’uomo stesso è «un segno. Vale a dire uomo e segno esterno sono la stessa cosa, come le parole homo e man sono identiche. Così il mio linguaggio è la somma totale di me stesso perché l’uomo è il pensiero» (Peirce, cit., 5.314; qui 138).
Pervasività, varietà e universalità del segno sono state da sempre oggetto del discorso filosofico. Platone indaga le relazioni tra il referente (iperuranio), l’imitazione (gli enti), i concetti che riassumono gli enti e le parole che li esprimono. Per i neoplatonici, poi, è l’intero cosmo a costituirsi in forma di segno, in teofania. Traducendo come sempre la metafisica del maestro in discorso tecnico su ciò che appare, Aristotele distingue tra onoma, il segno/nome che significa qualcosa; rema, un segno al quale si aggiunge un fondamentale riferimento temporale; logos, segno complesso e discorso significativo. Quindi /Mario/ è onoma; /Mario è arrivato e sta lavorando/ è rema; la descrizione del viaggio di Mario è logos. Gli Stoici individuano a loro volta il semainon come segno fisico, linguistico o di altra natura; il semainomenon, la parte immateriale del segno, il suo significato concettuale; il pragma e cioè l’oggetto/referente al quale il semainon si riferisce, che può essere un ente fisico ma anche un evento o un processo. Lo schema è dunque: significante-significato-referente e spiega la compresenza nel segno di una forma-significante e di un contenuto-significato, inseparabili come due facce della stessa moneta. I filosofi antichi e quelli medioevali sanno anche che tra le parole e le cose si pone il concetto. Per Ockham la parola rimanda non alle cose direttamente ma ai loro concetti-significati, i quali a loro volta diventano dei significanti il cui significato-referente sono soltanto le cose singole.
Con Locke la semiotica inizia ad acquistare un proprio statuto autonomo, oltre che il nome che la indica. La svolta fondamentale è costituita naturalmente da Peirce, dalla sua stupefacente e articolata costruzione estremamente tecnica e insieme pansemiotica, all’incrocio tra pragmatismo e platonismo. Le Ricerche logiche di Husserl -in particolare la prima, la quarta e la sesta- sostengono una posizione radicale, che intende «lo stesso significato percettivo come un risultato di processi semiotici» (111), le percezioni come dei costrutti, la conoscenza come una sintesi attiva che trasforma il dato (Gegenstand) in oggetto (Objekt). «Questa nozione di una costruzione percettiva del mondo, in sé aperto a vari esiti possibili, come continua donazione di senso a cui partecipo non solo col linguaggio verbale ma con l’intera espressività della mia corporeità, è presente in tutto il pensiero di Merleau-Ponty. La fenomenologia della percezione si salda quindi con una fenomenologia della semiosi» (114). Rimanendo in ambito fenomenologico, Eco critica con asprezza l’ermeneutica heideggeriana in quanto essa sarebbe l’esatto opposto di una teoria dei segni e costituirebbe invece «una pratica, continua e appassionata di interrogazione dei segni» (97) e tuttavia discutendo della Semantica Generale di Korzibsky e di Sapir-Whorf, ricorda che per questi studiosi «la lingua non è ciò attraverso cui si pensa, ma ciò con cui si pensa o addirittura ciò che ci pensa o da cui siamo pensati» (106), che è tesi anche heideggeriana.
Sui rapporti tra pensiero e linguaggio, la posizione di Roland Barthes è che «la verbalizzazione sia la forma stessa del pensiero, che non si possa pensare senza parlare: quindi la semiologia sarebbe solo un capitolo della linguistica» (93). In ogni caso è chiaro che la complessità della semiotica è tale da tenere lontano ogni riduzionismo logicistico. La logica formale, infatti, «si applica a linguaggi appunto formalizzati e assolutamente non equivoci e entra in crisi quando vuol farsi logica dei linguaggi naturali, che sono invece il luogo dell’equivocità, della polisemia, della sfumatura e dell’ambiguità» (82). Il neopositivismo presenta lo stesso limite, giudicando «come strumento accreditato di comunicazione quell’uso di segni assolutamente univoci che si verifica così di rado nella vita umana e solo nel chiuso dei laboratori, mentre veniva discreditato il discorso quotidiano, il discorso della politica, dell’affettività, della persuasione, dell’opinione che non può essere ridotto ai ferrei parametri della verifica fisicalistica» (134).
La ricchezza della semiotica è data anche dal fatto che la creazione e lo scambio di segni costituiscono un ciclo senza fine, sono la vita stessa della comunicazione umana. Il processo fonte-emittente-canale-messaggio-destinatario richiede non soltanto la comunicazione di una serie di segnali che in quanto tali possono essere puro significante (flatus vocis) ma di una struttura semantica, un codice, che renda quei segni parte di un mondo condiviso e li trasformi immediatamente in prassi; «nel segno il significante si associa al proprio significato per decisione convenzionale e dunque in base a un codice» (142). Secondo Peirce, la società umana si mostra in questo modo e tutta intera come linguaggio e cultura, come un «sistema di sistemi di segni. Anche quando crede di parlare, l’uomo è parlato dalle regole dei segni che usa» (138).
«Ein Zeichen sind wir, deutungslos» (Hölderlin, Mnemosyne), siamo un segno che nulla indica. Nulla, al di là di se stesso, del proprio indicare, della vita come segno, parola, concetto, significato che abita in noi e non certo nelle cose e nella materia, che bisogno di senso non hanno.