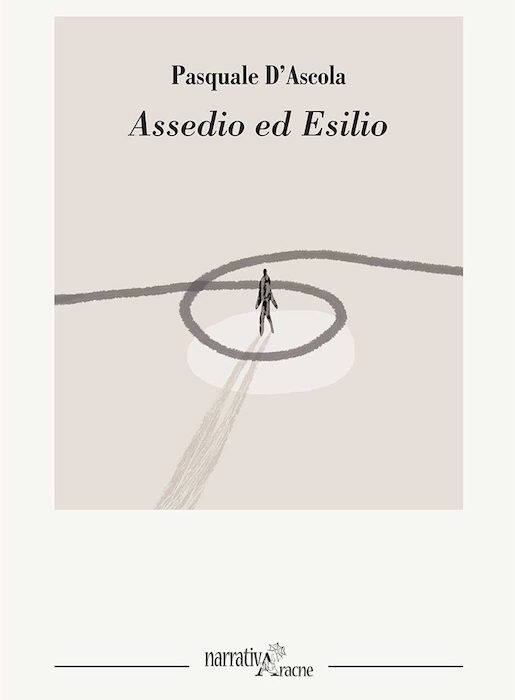Metto a disposizione la registrazione audio dell’intervento che ho svolto a Ragusa Ibla il 18 ottobre 2019 Contro il politicamente corretto nell’ambito di un Convegno sui Linguaggi del potere.
Ho esordito accennando alla funzione dell’intellettuale in una società caratterizzata da un uso costante e pervasivo dei social network.
Il primo riferimento teoretico-critico è a Proudhon e Schmitt, al loro concetto di umanità come imbroglio: «Wer Menschheit sagt, will betrügen», ‘chi dice umanità, sta cercando di ingannarti’. Il politicamente corretto è infatti una conferma del loro sospetto, essendo un dispositivo produttore di tabù, di ortodossia, di autoritarismo cognitivo.
Ho poi distinto nozioni e termini vicini ma diversi come l’etnocentrismo, la xenofobia, il pregiudizio, il razzismo.
Ho evidenziato soprattutto gli atteggiamenti sessuofobici e spiritualisti -e una generale avversione al materialismo- coltivati dalla sinistra immaginaria che si esprime nel politically correct, il quale è stato definito da Robert Hughes una «sort of linguistic Lourdes, where evil and misfortune are dispelled by a dip in the waters of euphemism», «una sorta di Lourdes linguistica, dove il male e la sventura svaniscono con un tuffo nelle acque dell’eufemismo», senza che la realtà, naturalmente, muti in alcun modo.
Ho discusso un inquietante esempio di politicamente corretto, che chiede la censura di Shakespeare e l’abolizione della lettura e dello studio della Divina Commedia dalle scuole italiane.
Ho concluso difendendo invece la libertà di parola, lo splendore e la varietà del linguaggio, in tutte le sue forme e contenuti, anche quelli che una determinata società in una specifica epoca giudica ‘inaccettabili’. Le fonti di questa mia convinzione sono Spinoza, i libertini del Sei-Settecento e soprattutto un grande amore verso la libertà, la quale è messa in pericolo da ogni atteggiamento politically correct: «Tale libertà è soprattutto necessaria per promuovere le scienze e le arti, poiché queste sono coltivate con successo soltanto da coloro che hanno il giudizio libero e del tutto esente da imposizioni. Ma supponiamo che questa libertà possa essere repressa e che gli uomini siano tenuti a freno in modo tale che non osino proferire niente che non sia prescritto dalle sovrane potestà. Con questo, certamente, non avverrà mai che non pensino niente che non sia voluto da esse; e perciò seguirebbe necessariamente che gli uomini, continuamente, penserebbero una cosa e ne direbbero un’altra [atque adeo necessario sequeretur, ut homines quotidie aliud sentirent, aliud loquerentur] e che, di conseguenza, verrebbe meno la lealtà, in primo luogo necessaria allo Stato, e sarebbero favorite l’abominevole adulazione e la perfidia, quindi gli inganni e la corruzione di tutti i buoni principi» (Spinoza, Trattato teologico-politico, cap. 20, §§ 10-11; in Tutte le opere, Bompiani 2011, trad. di A. Dini, p. 1117).
La registrazione dura 26 minuti.
- Contro il politicamente corretto (file audio mp3)