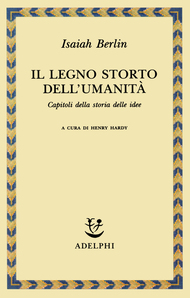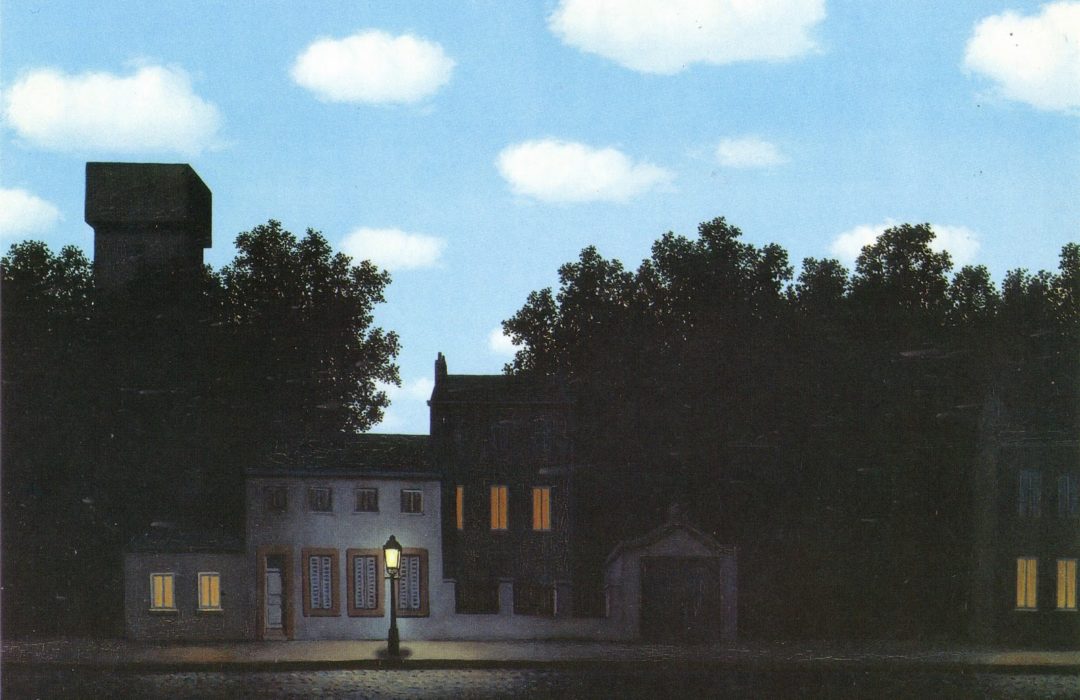La corrispondenza
di Giuseppe Tornatore
Con: Olga Kurylenko (Amy Ryan), Jeremy Irons (Ed Phoerum)
Italia, 2015
Trailer del film
Un professore di astrofisica di Edimburgo. Una sua studentessa, che per vivere fa anche la stunt nel cinema. Si amano da sei anni, incontrandosi quando e dove possono, in particolare a Borgoventoso, un affascinante paesino sul lago d’Orta. Si chiamano di continuo, si scambiano messaggi, si vedono su skype. Fino a quando il flusso sembra interrompersi a causa dell’astrocitoma che uccide il professor Ed Phoerum. Sembra però, perché Ed continua a far avere ad Amy i messaggi, i video, i sorrisi che ha registrato negli ultimi mesi della sua malattia, della quale nulla ha detto alla ragazza. «Solo che da qui non posso toccarti».
La corrispondenza è anche la struggente storia di un amore che va oltre la morte; è anche la prova della potenza degli strumenti digitali di comunicazione; è anche la raffinata e troppo patinata descrizione di Edimburgo e del lago d’Orta. Ma è soprattutto la continuazione di Una pura formalità (1994), il film più radicale di Tornatore. Analoghi sono l’enigma del morire e del rimanere, la domanda sui labirinti del tempo, l’intuizione di un errore fatale che conduce tutti gli umani alla fine, nonostante siano nati immortali. L’errore delle passioni, di una qualche passione che si amplia all’intera esistenza, come il tumore che uccide Ed Phoerum e che sembra dare ragione a Immanuel Kant: «Le passioni sono cancri» (Antropologia pragmatica, Laterza 2007, p. 157).
Il professor Phoerum naturalmente sa bene -e lo ripete a lezione- che la luce che ci arriva dalle stelle è in tanti casi la luce di astri che sono spenti da molto tempo. Una luce che però continua ad attraversare gli spazi e a battere il tempo. Come l’amore, a volte.