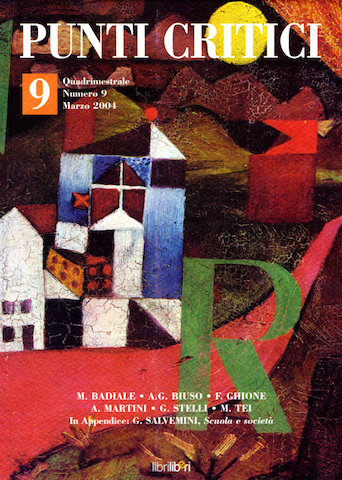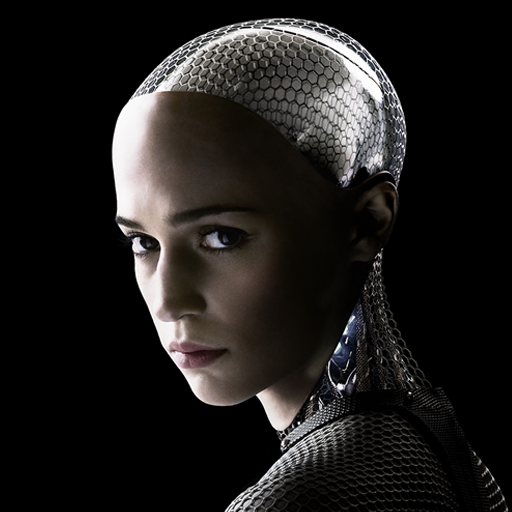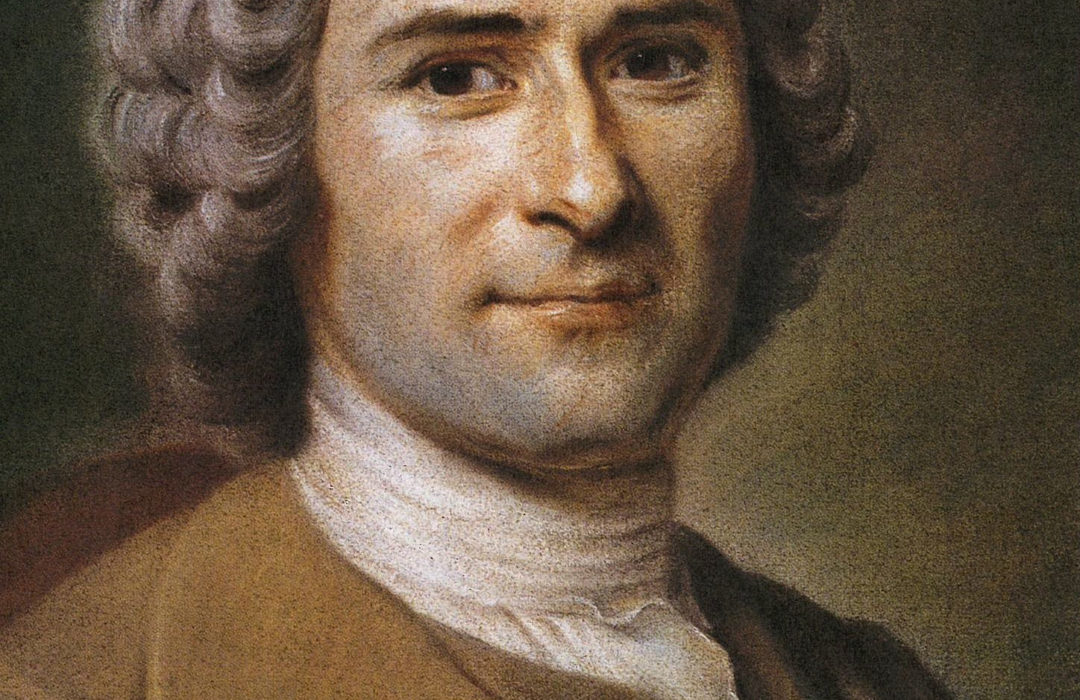Mente & cervello 124 – aprile 2015
 Il linguaggio non è soltanto un modo del comunicare, una descrizione di enti e di situazioni, un protocollo di regole. Il linguaggio contribuisce a generare per noi la realtà. È questa una delle ragioni che rendono difficile e forse impossibile la costruzione di un’intelligenza artificiale, poiché intelligenza vuol dire anche e in gran parte linguaggio e quindi «la necessità di andare, più frequente di quanto si pensi, oltre il significato letterale delle parole» (D.Ovadia, p. 51). Una delle maniere più efficaci per andare al di là del ‘significato letterale delle parole’ -vale a dire al di là della semplice descrizione protocollare del mondo- è la metafora. Di metafore il nostro linguaggio, e dunque il nostro mondo, è intriso. Sino, spesso, a non rendercene neppure conto. Metafora viene dal greco e significa trasportare una parola da un contesto a un altro, spostare il senso per comunicare con maggiore efficacia ciò che pensiamo e per indicare nessi profondi tra gli enti, gli eventi, i processi. «Sei un sole», «oggi splende il sole», «sei luminosa come il sole» sono tre espressioni simili. La terza è una similitudine, la seconda una descrizione letterale, la prima una metafora.
Il linguaggio non è soltanto un modo del comunicare, una descrizione di enti e di situazioni, un protocollo di regole. Il linguaggio contribuisce a generare per noi la realtà. È questa una delle ragioni che rendono difficile e forse impossibile la costruzione di un’intelligenza artificiale, poiché intelligenza vuol dire anche e in gran parte linguaggio e quindi «la necessità di andare, più frequente di quanto si pensi, oltre il significato letterale delle parole» (D.Ovadia, p. 51). Una delle maniere più efficaci per andare al di là del ‘significato letterale delle parole’ -vale a dire al di là della semplice descrizione protocollare del mondo- è la metafora. Di metafore il nostro linguaggio, e dunque il nostro mondo, è intriso. Sino, spesso, a non rendercene neppure conto. Metafora viene dal greco e significa trasportare una parola da un contesto a un altro, spostare il senso per comunicare con maggiore efficacia ciò che pensiamo e per indicare nessi profondi tra gli enti, gli eventi, i processi. «Sei un sole», «oggi splende il sole», «sei luminosa come il sole» sono tre espressioni simili. La terza è una similitudine, la seconda una descrizione letterale, la prima una metafora.
Esistono delle «strutture cerebrali deputate a elaborare il linguaggio metaforico» (Ibidem), tanto da far sembrare il cervello un organo naturaliter filosofico. Le metafore sono talmente potenti da determinare il modo stesso nel quale vengono affrontate questioni fondamentali, come quella del tempo. Bergson è convinto che il linguaggio sia in gran parte un ostacolo alla comprensione del tempo poiché trasferisce (metaforizza) l’ambito temporale in uno spaziale. Le ricerche contemporanee sulla metafora sembrano dargli ragione. Infatti «poiché i nostri occhi guardano avanti, il futuro è pensato, immaginato e rappresentato come ‘davanti a noi’. Le metafore danno forma al tempo e influenzano persino le teorie scientifiche» (Id., 52).
Questo esempio suggerisce, inoltre, che le metafore hanno un’origine e una struttura profondamente corporee. Non è affatto vero, come invece ritengono le prospettive cognitivistiche, che il linguaggio sia una struttura formale indipendente dalla corporeità. Tutt’altro: «Le metafore fanno da legame tra linguaggio, emozioni, sensi e corpo. E possono influenzare il nostro comportamento, anche in modo implicito, proprio perché incidono su un network cerebrale complesso» (Id., 53). Il corpo stesso è anche una struttura linguistica, la cui sintassi e semantica variano «in base alla situazione e al singolo individuo» (A.Gojowsky – Gielas, 63).
La varietà dei linguaggi, delle situazioni spaziotemporali, dei corpi, produce anche la varietà dei comportamenti e delle loro regole. Ritenere che esista soltanto un codice morale, un unico decalogo valido sempre e ovunque, un solo imperativo formale, significa ignorare la complessità del mondo umano, poiché «l’uomo è nato per avere una morale, non per avere una morale ben precisa» (S.Ayan, 69). Un solo esempio, ricordato da Ayan: tra gli etoro della Nuova Guinea «c’è l’usanza che i giovani, per essere accettati nella comunità degli adulti, debbano essere ‘inseminati’ da maschi maturi, ossia che pratichino loro il sesso orale raccogliendone in bocca il seme, che dovrebbe servire a far maturare la loro capacità riproduttiva» (65). Già Pascal osservava che vero e falso, bene e male, variano anche di molto in relazione ai luoghi geografici.
Dovremmo comprendere e accettare, ci faccia o meno piacere, che i comportamenti umani sono -pur nelle loro specificità- simili a quelli di tutto il resto del mondo vivente. Simili soprattutto nell’essere determinati. Il più diffuso organismo unicellulare del pianeta, il Toxoplasma gondii, (il protozoo responsabile della toxoplasmosi) produce nei ratti un cambiamento spettacolare, inducendoli ad avvicinarsi con interesse ai gatti, invece di allontanarsi lestamente da loro. Come mai? La ragione sta nel fatto che questo parassita si riproduce in modo sessuato soltanto nella pancia dei felini, per poi diffondersi con le loro feci. Molto probabilmente quella che l’epidemiologa Joanne Webster ha chiamato ‘fatale attrazione felina’ è «un metodo ingegnoso per il parassita di tornare all’interno della pancia di un gatto, per completare lo stadio sessuato del suo ciclo vitale» e lo può fare soltanto modificando «il comportamento dei roditori, alterando l’attività neurale e l’espressione genica» (G.Arrizabalaga-B.Sullivan, 89).
Questo organismo che entra così abilmente nel corpo di altri animali ha dunque una raffinata intelligenza politico-strategica? Tendo a escluderlo, non essendo fatto che di una sola cellula. Toxoplasma gondii si comporta così perché è il modo più efficace che ha trovato per colonizzare il pianeta. Ritengo che i comportamenti di tutti gli altri animali, Homo sapiens compreso, seguano analoghe regole, del tutto deterministiche. Certo, pensare questo è un duro colpo nei confronti del pregiudizio relativo alla nostra ‘superiorità’ biologica, culturale, spirituale, ma dovremmo una buona volta accettare con serenità -anzi, con gaudio- il fatto che «ogni persona è un ricco ecosistema, e per ogni cellula del corpo ci sono altre dieci cellule di batteri che influenzano la psicologia, il metabolismo e la salute» (Id. 93). ‘Conosci te stesso’ significa anche conosci la molteplicità biologica che sei, in tutto e per tutto.