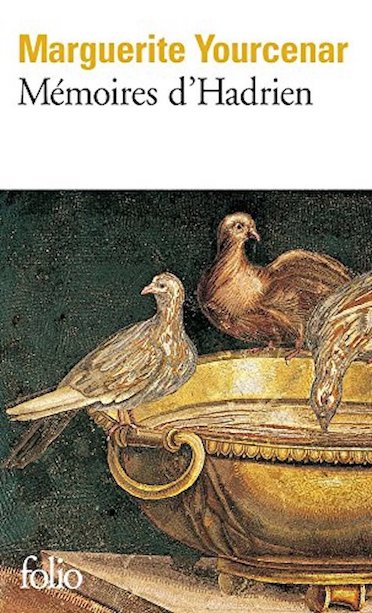
Marguerite Yourcenar
Memorie di Adriano
seguite dai Taccuini di appunti
(Mémoires d’Hadrien, suivi de Carnets de notes de Mémoires d’Hadrien, 1951)
A cura di Lidia Storoni Mazzolani
Einaudi, 1988
Pagine 330
È uno dei libri che restituiscono alla lettura il suo senso più proprio, il suo significato proustiano, il suo essere prima di ogni altra cosa un molteplice dialogo con se stessi e dunque un confronto pieno con l’esistere. La scrittura splendida e semplice di Marguerite Yourcenar mostra quanto vivo sia il mondo dei Greci, il mondo dei pagani.
Tra il 117 e il 138 dell’e.v. un uomo a tutto interessato, viaggiatore instancabile, soldato abilissimo, lettore e scrittore, amante della bellezza in ogni sua forma, politico accorto e lungimirante, prende il potere e fa della pax romana molto più che un’aspirazione o una formula. Con Adriano l’integrazione dei popoli, la molteplicità religiosa, lo sviluppo economico, la pace alle frontiere, l’incremento urbanistico, culturale, artistico, costituiscono delle realtà tangibili.
 Yourcenar ha disegnato di quest’uomo un ritratto compiuto e di grande bellezza. Ha lavorato con acume su moltissime fonti ma non ha scritto un saggio storico. E tuttavia sono pochi gli episodi frutto di sola invenzione. L’autrice afferma di aver voluto «rifare dall’interno quello che gli archeologi del XIX secolo hanno rifatto dall’esterno» (p. 285). Ne scaturisce un’opera sintesi, nella quale i temi e i caratteri più propri dell’epoca imperiale al suo apogeo si intrecciano con motivi e pensieri universali, di profonda qualità filosofica.
Yourcenar ha disegnato di quest’uomo un ritratto compiuto e di grande bellezza. Ha lavorato con acume su moltissime fonti ma non ha scritto un saggio storico. E tuttavia sono pochi gli episodi frutto di sola invenzione. L’autrice afferma di aver voluto «rifare dall’interno quello che gli archeologi del XIX secolo hanno rifatto dall’esterno» (p. 285). Ne scaturisce un’opera sintesi, nella quale i temi e i caratteri più propri dell’epoca imperiale al suo apogeo si intrecciano con motivi e pensieri universali, di profonda qualità filosofica.
Adriano vuole comprendere l’esistenza e gli enti; sa di disporre a questo scopo di tre mezzi soltanto: «lo studio di se stessi […], l’osservazione degli uomini […] e i libri» (21-22). Questi ultimi sono stati la sua «prima patria» perché è tramite loro che per la prima volta ha «posato uno sguardo consapevole su se stesso» (32). Da allora ha compreso sempre più lo splendore e l’assurdità del vivere. La carriera politica, le campagne militari, le iniziazioni religiose, le passioni amorose, le opere tratte dalla pietra o incise con lo stilo, costituiscono tutte degli strumenti per il raggiungimento di una gioia possibile, poiché «qualsiasi felicità è un capolavoro» (155).
Adriano molto ha sperimentato, da tante cose si è allontanato, senza però mai aver rinunciato a nulla che promettesse una sia pur piccola pienezza. Per lui il potere è stato soltanto un modo di essere libero: «Ho cercato la libertà più che la potenza, e quest’ultima soltanto perché, in parte, secondava la libertà» (41). Il suo sguardo sugli umani è disincantato senza essere arido, è anzi colmo di una pietà libera da ogni sentimentalismo. Ha vissuto con appassionato trasporto «le gioie dolorose dell’amore» (205), fino a disperarsi per la morte dell’amato ed elevare a lui un vero e proprio culto: la religione di Antinoo. Ha nutrito verso la molteplicità delle fedi e delle idee quella feconda tolleranza di chi sa che «vi è più di una saggezza, e sono tutte necessarie al mondo» (253). Ha amato la Grecia e ha fatto di essa la vera padrona del mondo poiché da lei proviene «tutto quello che c’è in noi di armonico, cristallino e umano» (210) e ha saputo riconoscere in Roma soprattutto la perennità dell’ordine politico. Compiute le opere, raccolti i pensieri, accettato il dolore, ha cercato «d’entrare nella morte a occhi aperti…» (276). 
Ma Yourcenar non ha voluto proporre un’immagine ideale e dunque artificiosa di Adriano; lei stessa scrive con arguzia di essersi divertita «a fare e rifare questo ritratto d’un uomo quasi saggio» (286). Adriano non nasconde infatti a se stesso nessuna della proprie viltà, debolezze, limiti, e in questo modo mostra di essere -nonostante tutto– un nostro contemporaneo più che un imperatore del II secolo.
Forse il significato del libro consiste proprio nell’aver coniugato le epoche, nell’aver delineato l’umano nella sua espressione migliore e fatto di Adriano un contemporaneo lasciandolo essere un antico. A quale età appartengono parole come queste: «Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo» (127); «Ma non v’è carezza che giunga fino all’anima» (184)? Appartengono a quel tempo lontano, al presente, al sempre.




 Elio Lamia e Ponzio Pilato si intrattengono amabilmente durante una cena, ricordando il passato, la vita a Gerusalemme, il difficile governo della Giudea. Il procuratore difende il proprio operato, che era stato sempre rivolto a garantire la giustizia e le leggi, a promuovere anche in Giudea lo sviluppo e la pace che il dominio di Roma apportava alle Province dell’Impero. Ma essi, i Giudei -«questi nemici del genere umano» (p. 17)- «ignorano la filosofia e non tollerano la diversità delle opinioni» (26), fanaticamente certi di essere gli unici a conoscere il divino, seppure tra di loro continuamente in confitto sulla interpretazione delle proprie Scritture. Pilato presagisce che questo popolo non sarà mai domato, se non con la distruzione completa della Città santa e con la dispersione. Lamia è d’accordo con lui ma pensa che «in ogni cosa bisogna osservare misura ed equità» (29), ricorda anche le virtù nascoste di quel popolo e soprattutto la bellezza delle sue donne, la sensualità straripante di «un’ebrea di Gerusalemme», con le «sue danze barbare, il suo canto un po’ rauco e insieme dolce, il suo odore d’incenso, il suo vivere trasognato […] Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco» (30-31). Questa donna fu da lui perduta quando lei si unì a «un giovane taumaturgo di Galilea»; Lamia chiede a Pilato se si rammenta di questo Gesù «crocifisso non ricordo per quale delitto». La risposta del procuratore è meravigliosa: « “Gesù” mormorò “Gesù il Nazareno? No, non ricordo» (31). E su queste parole si chiude il racconto, «che è un apologo -e un’apologia- dello scetticismo più assoluto (e quindi della tolleranza che ne è figlia)» (Leonardo Sciascia, p. 36).
Elio Lamia e Ponzio Pilato si intrattengono amabilmente durante una cena, ricordando il passato, la vita a Gerusalemme, il difficile governo della Giudea. Il procuratore difende il proprio operato, che era stato sempre rivolto a garantire la giustizia e le leggi, a promuovere anche in Giudea lo sviluppo e la pace che il dominio di Roma apportava alle Province dell’Impero. Ma essi, i Giudei -«questi nemici del genere umano» (p. 17)- «ignorano la filosofia e non tollerano la diversità delle opinioni» (26), fanaticamente certi di essere gli unici a conoscere il divino, seppure tra di loro continuamente in confitto sulla interpretazione delle proprie Scritture. Pilato presagisce che questo popolo non sarà mai domato, se non con la distruzione completa della Città santa e con la dispersione. Lamia è d’accordo con lui ma pensa che «in ogni cosa bisogna osservare misura ed equità» (29), ricorda anche le virtù nascoste di quel popolo e soprattutto la bellezza delle sue donne, la sensualità straripante di «un’ebrea di Gerusalemme», con le «sue danze barbare, il suo canto un po’ rauco e insieme dolce, il suo odore d’incenso, il suo vivere trasognato […] Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco» (30-31). Questa donna fu da lui perduta quando lei si unì a «un giovane taumaturgo di Galilea»; Lamia chiede a Pilato se si rammenta di questo Gesù «crocifisso non ricordo per quale delitto». La risposta del procuratore è meravigliosa: « “Gesù” mormorò “Gesù il Nazareno? No, non ricordo» (31). E su queste parole si chiude il racconto, «che è un apologo -e un’apologia- dello scetticismo più assoluto (e quindi della tolleranza che ne è figlia)» (Leonardo Sciascia, p. 36).






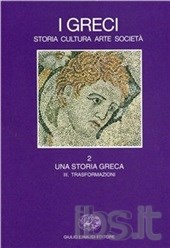 iamenti alle scienze, alle arti, alla filosofia. Quest’ultima vide forse proprio nell’Ellenismo la maggiore realizzazione del progetto platonico se è vero che «in molti, se non nella maggior parte dei contesti politici, la presenza e la visibilità dei filosofi fu altamente apprezzata» (468), tanto che nella stessa Roma -a partire dalle lezioni tenute nel 155 a.C. dai maggiori scolarchi greci- iniziò un interesse e «un desiderio per la filosofia che non sarebbe diminuito per il resto dell’antichità» (476). Lo sviluppo delle scienze durante l’Ellenismo dà ragione all’ipotesi di Lucio Russo, per il quale il III secolo a.C. fu il tempo di una vera e propria rivoluzione scientifica negli ambiti più diversi, una rivoluzione che non è stata soltanto l’anticipatrice di quella ben più famosa del XVII secolo ma la sua vera e propria fonte. E infatti: «Il secolo e mezzo successivo al presunto floruit di Euclide vide lo sviluppo davvero straordinario di una ricerca matematica di prim’ordine» (687), di una astronomia il cui valore fu riconosciuto da Copernico, di una filologia rigorosa in grado di elaborare le metodologie di lettura e di analisi dei testi «che costituiscono ancor oggi il fulcro della disciplina filologica: l’
iamenti alle scienze, alle arti, alla filosofia. Quest’ultima vide forse proprio nell’Ellenismo la maggiore realizzazione del progetto platonico se è vero che «in molti, se non nella maggior parte dei contesti politici, la presenza e la visibilità dei filosofi fu altamente apprezzata» (468), tanto che nella stessa Roma -a partire dalle lezioni tenute nel 155 a.C. dai maggiori scolarchi greci- iniziò un interesse e «un desiderio per la filosofia che non sarebbe diminuito per il resto dell’antichità» (476). Lo sviluppo delle scienze durante l’Ellenismo dà ragione all’ipotesi di Lucio Russo, per il quale il III secolo a.C. fu il tempo di una vera e propria rivoluzione scientifica negli ambiti più diversi, una rivoluzione che non è stata soltanto l’anticipatrice di quella ben più famosa del XVII secolo ma la sua vera e propria fonte. E infatti: «Il secolo e mezzo successivo al presunto floruit di Euclide vide lo sviluppo davvero straordinario di una ricerca matematica di prim’ordine» (687), di una astronomia il cui valore fu riconosciuto da Copernico, di una filologia rigorosa in grado di elaborare le metodologie di lettura e di analisi dei testi «che costituiscono ancor oggi il fulcro della disciplina filologica: l’ 
