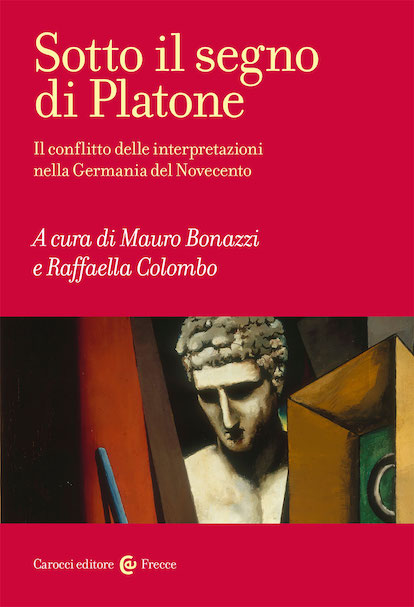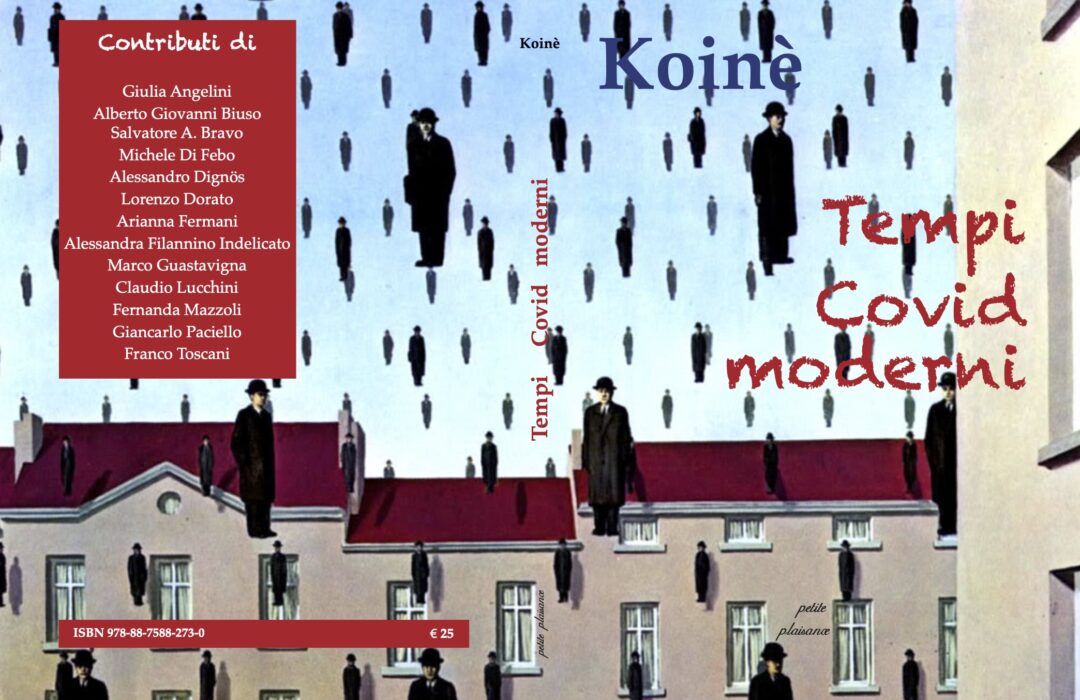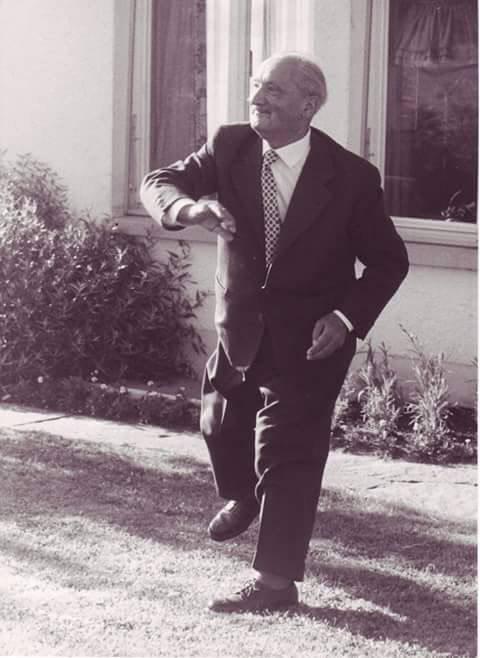Maurizio Consoli – Alessandro Pluchino
Il vuoto: un enigma tra fisica e metafisica
Aracne Editrice, 2015
Pagine 174
Tra i concetti più antichi, enigmatici, pervasivi del pensare, sempre attuali pur nel mutare delle concezioni fisiche e filosofiche, il vuoto si delinea sempre più come un altro nome dell’essere. Vuoto è infatti la condizione del movimento, del divenire, del tempo. Non soltanto nel banale e semplice senso che qualcosa per muoversi e diventare deve farlo in un elemento libero, spazialmente occupato e temporalmente non ancora compiuto ma anche e soprattutto in un significato assai più radicale, che questo importante libro indaga in una molteplicità di direzioni: dal rigore delle equazioni che intessono un intero capitolo (il settimo) ai riferimenti esatti e costanti alla storia della filosofia e alle tradizioni metafisiche orientali.
Il fecondo paradosso che attraversa tutto il testo è che il vuoto non è ‘vuoto’ ma consiste, usando il linguaggio della fisica contemporanea, nello «stato di minima energia» (p. 166); è il ground state, lo stato fondamentale che riempie uniformemente lo spazio e con il quale alla fine coincide. Il vuoto può dunque essere anche la forma oscura di materia ed energia che non è percepibile o misurabile (almeno con i nostri strumenti) ma che interagisce gravitazionalmente, determinando la struttura stessa della materia, la sua origine, il suo evolversi.
I nomi e le forme che questa potenza del vuoto ha assunto nelle differenti culture, tradizioni e paradigmi sono diversi, radicali e fondanti: l’ἄπειρον di Anassimandro, l’indifferenziato che consente l’esistenza e il dinamismo di tutti gli elementi nel tempo; la materia del Taoismo, dell’Induismo e del Buddhismo, non il mero nulla – anche qui – ma l’unità degli opposti; la χώρα platonica, «un elemento primordiale oscuro, informe ed invisibile» (p. 68); il Sein di Heidegger come trasparenza che fa vedere, attrito che fa muovere, intero che rende possibile la parte.
Un altro nome del vuoto è, infine, l’etere della millenaria tradizione fisica e metafisica, vale a dire la sostanza che pervade tutto l’universo e dentro la quale si muovono i corpi, compresa la luce. È sull’etere che questo libro formula ipotesi e propone interpretazioni di grande significato sia per la storia della scienza sia per l’epistemologia. Dall’indagine condotta in queste pagine emerge infatti come non sia vero che la relatività abbia definitivamente cancellato l’etere. Non soltanto perché, come si disse sin da subito, nella teoria einsteiniana dell’invarianza (o della relatività) l’etere continua a rimanere centrale prendendo il nome di spazio, ma per numerose altre ragioni sia sperimentali sia matematiche.
Lo stesso Einstein fu sulla questione molto più aperto di quanto di solito si pensi. Nel Manoscritto Morgan del 1920 e in una lezione tenuta a Leida lo stesso anno, affermò infatti che «nel 1905 ero convinto che non fosse più permesso di parlare di etere in fisica. Tuttavia questa opinione era troppo radicale. Secondo la relatività generale, lo spazio è dotato di proprietà fisiche. In questo senso, un etere esiste…Si può perciò dire che l’etere è risuscitato nella teoria della relatività generale, anche se in una forma più sublimata. A differenza della materia ordinaria, esso non è pensabile come composto di particelle che possano essere seguite individualmente nel tempo» (qui citato alle pp. 100-101).
Consoli e Pluchino mostrano in modo documentato che se questa posizione non venne dallo scienziato tedesco ulteriormente sviluppata fu per ragioni che non hanno a che fare con la fisica ma con la sociologia della conoscenza e con la situazione storica della prima metà del Novecento. Di fatto oggi si assiste a un ritorno dell’etere «sotto altre specie, tramite la nozione di un condensato che pervade uniformemente lo spazio e fa da sfondo ai processi fisici osservabili. Peraltro […] il campo di Higgs non è l’unica forma di etere che viene introdotta» (17).
Il vuoto non è il nulla, l’etere non è il nulla. Vuoto ed etere sono il vacuum condensation, la condensazione del vuoto, tanto che diversamente «dallo spazio-tempo banalmente vuoto che Einstein aveva in mente nel 1905, il vuoto della fisica di oggi andrebbe piuttosto pensato come permeato da diversi condensati di quanti elementari» (140).
A partire da questa complessa e ricca fondazione epistemologica, Consoli e Pluchino conducono una duplice operazione: interpretano in modo diverso – rispetto alla vulgata – il significato e i limiti degli esperimenti di ottica effettuati da Michelson-Morley nel 1887; analizzano e riproducono tali esperimenti su base matematica. Mostrano in questo modo che i residui di quegli esperimenti – il cui obiettivo consisteva nell’osservare il moto della Terra nell’etere e stimarne la velocità – conducono a un valore di 370 km al secondo, che è esattamente quello confermato dallo studio della Cosmic Microwave Background (CMB, radiazione cosmica di fondo). La loro indagine suggerisce quindi di rivalutare alcuni elementi di quegli esperimenti che risultano compatibili con l’esistenza dell’etere, non riducendoli per intero a errori strumentali ma anzi mostrando che «possono anche essere consistenti con il modello stocastico di ether-drift che abbiamo discusso» (124). Si tratta di un risultato assai fecondo, dato che «riuscire a rivelare in laboratorio un ‘ether-wind’ (vento d’etere) finirebbe con il modificare sostanzialmente il nostro modo di concepire la realtà» (10).
I primi esperimenti di Michelson-Morley, e i numerosi che seguirono nei decenni successivi, se da un lato non diedero i risultati che ci si attendeva per poter confermare l’ipotesi dell’esistenza dell’etere, dall’altro diedero però dei risultati con essa compatibili. Riformulati con metodi matematici, questi risultati «differentemente dall’interpretazione tradizionale, che tende a considerarli come puri effetti strumentali, potrebbero invece acquistare un significato fisico ed indicare un debole flusso di energia, associato al moto cosmico della Terra, che induce correnti convettive in sistemi debolmente legati come i gas ed una conseguente leggera anisotropia della velocità della luce» (140-141). Ricordo che con anisotropia si indica quella proprietà per la quale il valore di una grandezza fisica dipende dalla direzione che il fenomeno studiato assume. Questo implica che un punto di riferimento conta nell’accadere e nei risultati del fenomeno studiato e che quindi siano possibili riferimenti assoluti.
Un altro elemento favorevole a questa ipotesi è una delle più interessanti interpretazioni della meccanica quantistica, vale a dire la teoria dell’onda-pilota di de Broglie-Bohm: «Nella sua formulazione più semplice, vengono introdotte due entità distinte: un corpuscolo materiale localizzabile ed un’onda che lo guida, la funzione d’onda Ψ che compare nell’equazione di Schrödinger. L’onda ha un diretto significato fisico ed andrebbe interpretata come una reale eccitazione di un etere sottostante, cioè del vuoto. Essa viene provocata dal corpuscolo ma, nello stesso tempo, lo ‘pilota’ nel senso che ne determina il momento spaziale P tramite la relazione P = −h∇S, dove S è la fase di Ψ = |Ψ|eiS» (164). In questo modo non soltanto si supera il dualismo onda/particella ma l’etere acquista lo stato di ipotesi ancora ben presente e ben plausibile all’interno della fisica contemporanea, un’ipotesi radicata nell’intera scienza e metafisica, non soltanto europee, e coerente con la meccanica quantistica.
L’etere può costituire l’ἄπειρον come campo/energia nel quale la materiatempo fluisce, si condensa, sta e accade. In termini generali, l’etere può rappresentare lo spaziotempo assoluto la cui esistenza non è affatto esclusa ma anzi è implicata da alcune delle teorie cosmologiche più recenti.
Il fatto che la meccanica quantistica conduca «a una visione della realtà come un tutt’uno profondamente interconnesso» (52) conferma il significato e la fecondità del pensiero greco arcaico, da cui matematica e fisica sono sorte e del quale – come si vede anche in questo libro appassionante – rimangono eredi.
Gli autori del libro – che si può scaricare in pdf – ne hanno scritto un altro, molto più tecnico, pubblicato nel 2018 in lingua inglese con la World Scientific.
Le loro ipotesi sulle relazioni tra l’etere e la radiazione cosmica di fondo erano state anche sintetizzate in forma semplificata e per un più vasto pubblico in un articolo in lingua italiana, inizialmente preso in considerazione da una rivista di divulgazione scientifica ma che poi per varie traversie non è stato pubblicato. Ne pubblico qui il pdf (con le mie evidenziazioni).
Si tratta di pagine che possono aprire un dibattito fecondo, anche nel caso si volesse respingere i loro contenuti. Significativa è la conclusione del testo, che indirizza alla questione della complessità. Se un articolo così fecondo non è stato ancora pubblicato è perché, oltre i meccanismi di censura e rifiuto analizzati magistralmente da Kuhn e Feyerabend, in questi casi agisce anche la consueta antropologia del branco, tesa a respingere i membri della comunità che mostrino troppo coraggio. Un coraggio che rischierebbe di mettere in pericolo l’identità e la forza della comunità stabilita. Insomma, che siano fisici, matematici, filosofi o altro, gli umani rimangono una comunità di primati. È bene che lo sappiano per non incorrere nella ὕβρις antropocentrica. Tanto più apprezzo chi, come Pluchino e Consoli, ha il coraggio e la curiosità di muoversi su territori non dogmatici e realmente scientifici.
[La fotografia raffigura il nostro pianetino, con la Luna che gli gira intorno, come si vede da Saturno; a una distanza di circa un miliardo e mezzo di km, che corrispondono a 90 minuti luce]